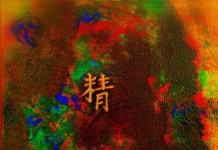Per quanto manifestamente datato, con scenografie e costumi che oggi appaiono piuttosto vintage, il film Fahrenheit 451, classe 1966, sa ancora rendere giustizia all’omonimo romanzo di Ray Bradbury, pur tradendolo svariate volte.
Sintesi meno verbosa e con qualche invenzione in più, la pellicola di Truffaut riesce a veicolare il messaggio dell’autore statunitense con rara efficacia, senza bisogno di monologhi esplicativi e con la sola forza delle immagini; a partire dai titoli di testa, che (conformemente ad una società futura in cui i libri sono banditi) sono pronunciati da una voce fuori campo, e non scritti come d’abitudine; il tutto mentre vengono inquadrate miriadi di antenne televisive, a sottolineare come, in una società dello spettacolo pre-debordiana ma post-apocalittica, le immagini abbiano preso il posto della parola stampata. Quasi una premessa visiva ai roghi che seguiranno.
Perché la trama, del film come del libro, è molto semplice: in un futuro nel quale la lettura è proibita, i pompieri sono destinati a bruciare i libri e, se necessario, anche i loro possessori; Montag, che per legge di contrappasso è proprio uno dei pompieri, diventa un accanito lettore dei pochi libri che riesce a salvare e, volendo propagare il contagio della lettura, viene denunciato e si trasforma in un fuorilegge; braccato, cerca la salvezza al di fuori della società.
Nonostante le difficoltà di produzione e le critiche che stroncarono il film al tempo della sua uscita (epoca in cui la fantascienza veniva classificata a priori come cinema di serie B), Truffaut riesce a portare a termine un adattamento magistrale, grazie anche alle musiche mai invadenti e perfettamente funzionali di Bernard Herrmann (compositore preso in prestito dall’amato Hitchcock) e alla fotografia del futuro regista Nicolas Roeg, elegante nella sua morbida pastosità e ricca di contrasti di colore.
Ma fondamentali sono anche la recitazione catatonica di Oskar Werner, perfetto emblema di una società privata di pensiero autonomo, e quella di Julie Christie, calata sia nel ruolo di Mildred, moglie di Montag, che in quello di Clarisse, la giovane istitutrice che instillerà nel pompiere il seme del dubbio, dualismo già sottolineato da Bradbury quando descrive la somiglianza delle due donne.
Semmai i difetti si possono ravvisare nei limiti della produzione: i tre megaschermi a parete in cui Mildred si immerge nel romanzo di Bradbury diventano un solo schermo, grande per l’epoca ma oggi di ordinaria amministrazione, e l’assenza del mastino robotico che, nella versione letteraria, diviene vero e proprio personaggio, teorema in metallo e circuiti della società repressiva delineata (ma realizzare un cane meccanico credibile nel 1966 sarebbe stato difficoltoso anche per Hollywood).
Diversamente, la scomparsa del monologo del capitano Beatty, superiore di Montag, viene abilmente supplita attraverso una serie di battute che ne rendono o l’essenza; e la mancanza di Faber, il professore che aiuta Montag a ribellarsi, è validamente surrogata da una maggiore incisività del personaggio di Clarisse, che ritroviamo alla fine del film (ma non nel capolavoro di Bradbury), in un corollario romantico e credibile che Truffaut, maestro nel rappresentare storie di amour fou, non poteva lasciarsi sfuggire.
L’ultimo elemento mancante nel lungometraggio del regista francese è l’incombenza della guerra, che in Bradbury è una presenza costante, come in 1984 di Orwell, e che nel finale si rivela essere reale ed estremamente distruttiva.
Ma, se nel romanzo la nuova società nasce dalle ceneri della precedente (non a caso il libro uscì in Italia con il titolo Gli anni della Fenice), Truffaut coltiva una speranza più ingenua e, forse, anche più nobile, regalandoci un finale che sfiora vertici assoluti di poesia, e che suscitò pubblicamente l’ammirazione dello stesso Bradbury.
Fahrenheit 451 è un film imperfetto e magnifico; non è neppure lontanamente il miglior lavoro di Truffaut, eppure ancora oggi, attraverso la forza delle immagini, sa comunicarci il disagio di fronte a un assolutismo che sa solo distruggere senza creare nulla di valido in cambio, e la speranza che i cambiamenti possono avvenire, ma verranno sempre innescati dal basso: le istituzioni sono troppo occupate a preservare sé stesse per occuparsi anche della salvezza.
Come Granger, un uomo-libro, dice verso la fine del romanzo: «Incontreremo una gran quantità di persone sole e sofferenti nei prossimi giorni, nei mesi e negli anni a venire. E quando ci domanderanno che cosa stiamo facendo, tu potrai rispondere loro: Noi ricordiamo. Ecco dove alla lunga avremo vinto noi».