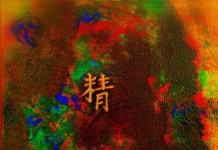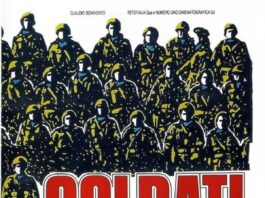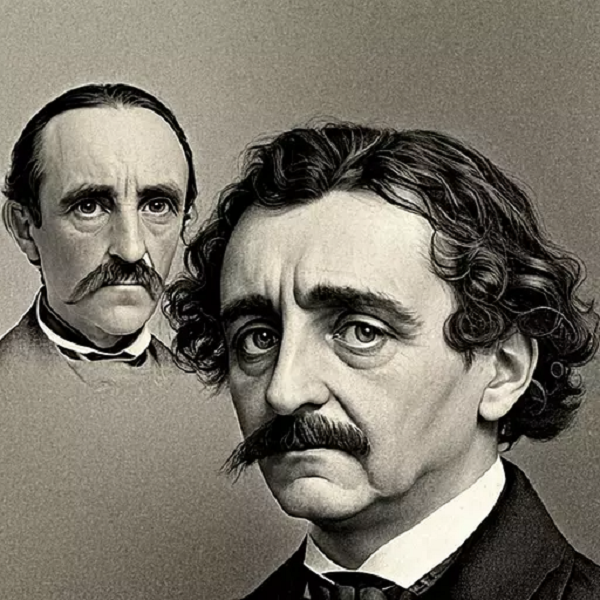“Ma il guaio è che voi, caro mio, non saprete mai come si traduca in me quello che voi mi dite. Non avete parlato turco, no. Abbiamo usato, io e voi, la stessa lingua, le stesse parole. Ma che colpa abbiamo, io e voi, se le parole, per sé, sono vuote? Vuote, caro mio. E voi le riempite del senso vostro, nel dirmele; e io, nell’accoglierle, inevitabilmente, le riempio del senso mio. Abbiamo creduto d’intenderci; non ci siamo intesi affatto.”
Questa citazione, tratta da Uno, nessuno e centomila (1926) di Luigi Pirandello (1867-1936), mi sembra una indispensabile premessa quando si vuole riflettere sul lavoro del traduttore. Se, come afferma Pirandello, è già difficile “tradurre” quello che si dice pur parlando la stessa lingua, figuriamoci quando si fanno delle trasposizioni da una lingua all’altra. Ma procediamo con ordine.
Da quando, nel 2004, fu pubblicata per i tipi di Bompiani la commedia Un padre ci vuole, di Stefano Pirandello, figlio del più illustre Luigi di cui sopra, che vide la luce grazie all’opera preziosa e infaticabile di Sarah Zappulla Muscarà ed Enzo Zappulla che da anni si impegnano a ridare vita a opere e ad autori ingiustamente scivolati nell’oblio, di questa stessa opera si sono susseguite nel corso del tempo una serie di traduzioni in moltissime lingue. E sempre a opera di illustri professori. Il testo di Stefano Pirandello è stato infatti tradotto in francese, greco, bulgaro, serbo, arabo, spagnolo, inglese australiano e, nel febbraio scorso, è uscita per i tipi di CUEPRESS una nuova traduzione in inglese, britannico questa volta, a cura di Enza De Francisci e Susan Bassnett.
Come sottolineato dalla Bassnett nella prefazione, le traduttrici hanno deciso di attualizzare la lingua di Stefano Pirandello perché, a loro parere, risulterebbe “piuttosto poetica e datata” essendo la commedia stata scritta negli anni Trenta e poi riveduta negli anni Sessanta del secolo scorso. La Bassnett specifica che si è scelto un tipo di linguaggio vicino al pubblico dei nostri giorni, in cui troviamo non solo un lessico più quotidiano, ma tante espressioni idiomatiche tipiche della lingua inglese contemporanea. A questo punto è sorta in me la curiosità di andare a confrontare questa nuova traduzione con qualcuna delle precedenti per scoprire in cosa consistessero realmente le differenze, e ho scelto allora quella francese e quella spagnola, trattandosi delle due lingue con cui ho maggiore dimestichezza essendomi occupata di traduzioni.
Prima di entrare nei dettagli portando qualche esempio interessante, mi corre l’obbligo di precisare che la traduzione di Vicente González Martín, direttore del Dipartimento di Filologia Italiana della Facoltà di Filologia dell’Università di Salamanca, come pure la bella versione della compianta Myriam Tanant, storica del teatro, drammaturga e fine italianista, sono nel complesso “traduzioni letterali” e che nessuno dei due studiosi si è posto il problema di “svecchiare” la lingua di Stefano Pirandello.
Cominciamo allora dal titolo. Un padre ci vuole, in spagnolo Un padre es necesario, in francese Un père, il en faut bien un, in inglese diventa All You Need is a Father ispirato volutamente a una famosa canzone dei Beatles, in quanto, come chiarito nella prefazione da Susan Bassnett, la traduzione letterale, che sarebbe “A father is needed, does not work in English” (non funziona in inglese).
Sempre nella prefazione la traduttrice si sofferma sull’abitudine, che lei ritiene tipicamente italiana, di interrompere continuamente chi sta parlando sovrapponendosi nei dialoghi, cosa considerata manifestazione di pessima educazione dagli inglesi, per cui si è sentita in dovere di eliminare queste interruzioni in più di qualche caso. Questa mi è sembrata una forzatura perché se si tratta, come sottolinea la stessa Bassnett, di un’abitudine tipicamente italiana, bisognava rispettarla in una commedia italiana, ambientata in Italia, con personaggi italiani. Per non dire che tutta la conversazione è giocata su esitazioni, ripensamenti, dialoghi concitati in cui i vari interlocutori si interrompono a vicenda intenzionalmente per far prevalere il proprio punto di vista.
Un’altra osservazione, che mi è nata spontanea, riguarda sempre un titolo, quello della prefazione dei curatori dell’edizione italiana, Un figlio paterno, che allude all’atteggiamento del protagonista, Oreste, il quale, in certi casi, è estremamente protettivo, proprio paterno, nei riguardi del padre. Questo è tradotto dalla Bassnett His Father’s Son cioè Suo padre è il figlio che perde di vista il senso icastico dell’ossimoro del titolo voluto dai curatori. El hijo paterno in spagnolo rende perfettamente il senso originario, la traduttrice francese, invece, ha preferito glissare.
Ma veniamo a qualche altro esempio.
Fin dalle prime battute di dialogo ci imbattiamo in una frase idiomatica che per noi italiani richiede qualche chiarimento. “Sono confuso dalla stanchezza”, che in spagnolo viene reso letteralmente con “Estaba confundido por el cansancio” e in francese con “Je suis confus de fatigue”, in inglese si trasforma in “I’m getting my wires crossed” (“Sto incrociando i miei fili”). Per avere maggiori chiarimenti sul significato di questa espressione sono ricorsa all’aiuto di una mia amica madrelingua inglese la quale mi ha spiegato che il riferimento di questa frase è al lavoro dei centralinisti. E, per comprendere ancora meglio in cosa consistesse questa attività, mi sono documentata su un blog di approfondimento sui mestieri antichi. Ho così scoperto che questo lavoro “consisteva nell’inserire ed estrarre prese a jack provvedendo manualmente allo scambio di telefonate, connettendo tra loro gli utenti”. Ovviamente poteva accadere che, in particolari momenti di intenso traffico telefonico, incrociando per errore i cavi, si creasse confusione, ebbene questa espressione è arrivata fino ai nostri giorni anche se ormai le connessioni sono tutte automatizzate!
Torniamo al nostro testo. Poche battute dopo è stato nettamente modificato il senso di due frasi. La prima: “Per fermarlo: pigliandolo a viva forza” che se in francese e spagnolo, come sempre, conserva il significato letterale (nell’ordine “qui l’arrête: par la force” e “Para detenerlo: sujetándolo con todas las fuerzas”) in inglese diventa “to physycally stop him from all this nonsense” (cioè “per fermarlo da tutte queste sciocchezze”). E, subito dopo, continuando su questa falsariga, la seconda: “lo strapazzi ben bene” (“secouez le bien” in francese e “le regañe bien” in spagnolo) diventa “knock some sense into him” (“dagli un po’ di buon senso”) che però non lega più con la battuta successiva che, invece, viene resa letteralmente (“a costo di prenderlo per il collo” – “even if I have to sgrab him by the scruff of the neck”).
“Non mi cimenti” diventa così “not to bother me” (“non mi disturbi” – è comprensibile che questa possa davvero sembrare un’espressione antiquata – ma la traduzione sembra decisamente fuorviante), mentre “no me provoque” e “ne me provoque pas”, rispettivamente in spagnolo e in francese, rendono alla lettera il senso del testo originale.
In altri casi, però, la traduzione risulta più efficace del testo originale, in tutte e tre le lingue: infatti “se lui sgarra”, espressione davvero antiquata e pure inadeguata a rendere il senso, è resa con “if something happens to him (“se gli accade qualcosa”), “si él no volviese” (“se non ritorna”), “quand il est en retard” (“se ritarda”).
Ma subito dopo, nella stessa pagina “Il proposito di uccidersi lo mise in atto sì o no?” diventa “Did he or did not threaten to kill him self? (“ha minacciato o no di uccidersi?”) che falsa completamente il senso e contrasta con quanto viene affermato subito dopo: “restò quasi cinque mesi tra la vita e la morte”.
Più letterali come sempre lo spagnolo “El intento de matarse lo llevó a cabo sí o no?” e il francese “Il a tenté de se tuer oui ou non?” Mettere in atto non è minacciare, sembra evidente specialmente se si resta “cinque mesi tra la vita è la morte”!
Spesso non risulta chiaro l’intento della Bassnett e della De Francisci, anzi, a volte l’esigenza di attuare una “domestication”, di rendere cioè più familiari le espressioni usate, porta a risultati che fanno sorridere come quando la frase “A freddo! Lo vede? A freddo!”, che allude all’atteggiamento di Oreste che intenzionalmente vuole farsi trovare dal padre in stato di agitazione, diventa “He’s calm! See that? Cool as a cucumber! (“È calmo! Lo vedi? Fresco come un cetriolo!”).
Un’altra frase idiomatica non necessaria, a mio parere, è “you’ve got the wrong end of the stick” (ha preso la parte sbagliata del bastone), che traduce “lei si sbaglia”, espressione che deve essere sembrata, forse, troppo banale.
Sono perciò molteplici i fraintendimenti ma mi soffermerò soltanto su quelli che mi sembrano i più vistosi.
Ad esempio, alla fine del primo atto ci imbattiamo in una traduzione, senz’altro molto “british”, che rende l’italiano “Che vergogna! Che vergogna!” con “It’s so embarrassing! So embarrassing!” (“È così imbarazzante! Così imbarazzante!”). Mentre, all’inizio del secondo atto, l’antiquato e letterario “Che sciagura!” diventa il più colloquiale “Such a mess!” (Che casino!), espressione sicuramente meno “british” della precedente ma molto in uso in tutte le occasioni nell’inglese colloquiale, però le traduttrici la mettono in bocca non solo a personaggi appartenenti alla “lower class” come Cravanzola, che è un mercante di campagna, ma anche a Oreste e a un professionista come il dottor Bruti, venendo così meno al proprio intento di utilizzare i registri linguistici caratteristici delle diverse classi sociali di appartenenza dei vari personaggi attraverso l’uso di “linguistic class markers” (indicatori linguistici di classe).
Un altro termine di uso molto frequente nell’inglese contemporaneo è “bloody”, un intercalare che serve per enfatizzare il discorso. Così “alto consenso” diventa “bloody consent” (“maledetto consenso”), e anche il semplice “lo credo bene” diventa “I should bloody well hope so” (“lo dovrei credere maledettamente bene”), ma “je veux bien le croire” in francese e “me gustaría creerle” in spagnolo, a mio parere, sono versioni decisamente migliori.
Va meglio, per fortuna, quando si deve rendere un’espressione idiomatica italiana che, ovviamente, è intraducibile e quindi lascia spazio alle traduttrici. “Mettere nel sacco anche me” per gli inglesi è “Pull the wool over my eyes as well! (Tira la lana anche sui miei occhi). La Tanant sceglie, a sua volta, l’espressione: “Me rendre complice de ça” (“Mi rendi complice di ciò”); González Martín, invece, traduce semplicemente: “Meterme tambien a mí en el saco”. Anche in un altro caso la traduzione inglese, che si serve di un’espressione idiomatica, risulta più convincente dell’italiano: “Io devo obbligarlo a non credersi sciolto” si trasforma in “I have to make him not fell like he’s off the leash!” (“devo fare in modo che non si senta fuori dal guinzaglio”).
Molti altri sarebbero gli esempi interessanti da riportare ma è meglio fermarsi qui, aggiungendo soltanto che una comprensione completa di tutte le sfumature dell’opera, con le loro conseguenti traduzioni, efficaci e fedeli, si riscontra solo nel lavoro del prof. Vicente González Martín il quale, senza apportare tagli immotivati di parti di testo, e, soprattutto, senza eseguire “voli creativi”, si attiene scrupolosamente a quanto scritto da Stefano Pirandello rendendolo in modo davvero impeccabile.
Anche la traduzione della prof.ssa Myriam Tanant è pregevole pur se, a volte, sembra evitare gli ostacoli semantici e interpretativi, sorvolando su frasi particolarmente ostiche.
Per quanto riguarda infine la versione di Enza De Francisci e Susan Bassnett mi sono lungamente soffermata su di essa nelle pagine precedenti e, in conclusione, non posso che fare mie le convinzioni delle stesse traduttrici secondo cui “any translation is a process of negotiation and intercultural mediation” (“ogni traduzione è un processo di negoziazione e mediazione interculturale”) e allora, da questo punto di vista, la loro traduzione può ritenersi riuscita.