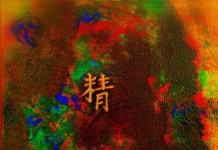Rishi Dastidar: “Le nazioni ‘sembrano’ senza tempo, ma sono invenzioni, invenzioni umane, tanto quanto la macchina a vapore, il microchip, oserei dire, la poesia.”
Intervista di Emilia Mirazchiyska
Abbiamo iniziato questa intervista per scherzo, quando ho detto a Rishi Dastidar che trovavo strano che la sua seconda raccolta di poesie, Saffron Jack (Nine Arches, 2020), non avesse una pagina dedicata all’indice.
Ci sono quattro possibili risposte a questo enigma: a) perché l’autore ha concepito il libro come una lunga poesia narrativa; b) perché all’autore piace sorprendere i suoi lettori; c) perché l’autore non può usare la funzione Indice in Word; d) perché l’autore è un postmodernista nel senso peggiore della parola.
La risposta più probabile è la prima, se prestiamo fede a una recensione pubblicata su The Guardian (sabato 9 maggio 2020), in cui Saffron Jack è stato descritto come “un lungo poema narrativo che rivede la storia del fervente imperialista Rudyard Kipling ‘The Man Who would Be King ‘, da Plain Tales From the Hills”.
La recensione continua: “Il personaggio centrale di Dastidar, Jack, è un emarginato che rifiuta un sistema che lo ha trascurato per diventare re del proprio paese. ‘Ogni Paese’, dichiara, ‘è immaginario’ “.
Quindi, Rishi, “Ogni Paese è immaginario”. Ma solo nella poesia, nel cinema e nelle storie di fantasia, temo, o anche nei sogni di ciascuno? Saresti d’accordo?
Ci sarebbe un po’ da discuterne, a dire il vero! È un po’ un trucco dello stato nazionale farsi apparire inevitabile, ma ovviamente, quando si guarda alla Storia globale, molti dei raggruppamenti che ora riconosciamo come ‘‘nazioni ‘‘ sono in realtà creazioni del XVIII secolo (non bisogna confondere i miti autocostruiti sull’antichità delle loro origini, o su quanto indietro nel passato la loro storia e le loro popolazioni abbiano radici) tradotte in realtà da singoli individui, così come dalle conseguenze di specifiche conquiste tecnologiche.
Il mio pensiero su questo argomento è fortemente influenzato dal compianto Benedict Anderson, uno scienziato politico che ha scritto Comunità immaginate: riflessioni sull’origine e la diffusione del nazionalismo. In breve, la sua tesi è che le nazioni sono strutturate dal punto di vista sociale e comunque sono immaginate perché “i membri anche della più piccola nazione non conosceranno mai la maggior parte dei loro simili, né li incontreranno o ne sentiranno parlare, eppure nella mente di ciascuno vive l’immagine della loro vicinanza”.
Ne derivano due cose: 1) le nazioni “sembrano” senza tempo, ma sono invenzioni, invenzioni umane, tanto quanto la macchina a vapore, il microchip e, oserei dire, la poesia. Allora cosa succede quando iniziamo a trattarle con meno deferenza? 2) Quanto può essere lontana e profonda una comunità del genere, soprattutto in un’epoca di individualismo? Se negli ultimi quarant’anni o giù di lì siamo stati addestrati a venerare noi stessi più delle comunità in cui viviamo, questo non contiene forse i semi per la distruzione dell’idea di nazionalità?
Più poeticamente: perché ciascuno di noi non dovrebbe ambire ad essere il monarca, il presidente, o il capo di uno stato proprio? È una risposta alla sensazione di mancanza di potere e di libero arbitrio nella nostra vita. O almeno lo è per me.
Quando la poesia contemporanea è entrata nella tua esistenza?
In una fase avanzata della vita: ero sulla soglia dei trent’anni. All’università non avevo assolutamente studiato letteratura o scrittura creativa e, sebbene avessi l’ambizione di diventare una qualche specie di scrittore, credevo che avrei fatto il giornalista (ma non è stato così: il mio lavoro quotidiano è quello di copywriter pubblicitario.)
Dunque, la poesia contemporanea è entrata nella mia vita per caso, accidentalmente. Era il 2007 e all’epoca lavoravo proprio nei paraggi di Oxford Street, la via principale dello shopping a Londra. Un lunedì, all’ora di pranzo, entrai nella grande libreria Borders, situata là a quel tempo e, mentre salivo al primo piano, un libro intitolato Ashes for Breakfast attirò la mia attenzione. Lo presi in mano e… per me fu un momento di rivelazione damascena quello in cui ne sfogliai le pagine. Non avevo idea che con il linguaggio si potesse fare qualcosa del genere: lasciare uno spazio bianco, non arrivare alla fine del rigo; essere garbati, e frivoli, e arguti, e intellettuali, il tutto nell’arco di quattro righe. Divenni un appassionato. Capii d’aver trovato quello che volevo scrivere.
Comprai il libro (l’autore è Durs Grünbein, e resta un libro meraviglioso) ed entro la fine di quella settimana mi scrissi a un corso propedeutico alla poesia, tenuto dalla brillante poetessa Clare Pollard. Così è iniziato tutto.
Dove sei nato? Qual è la tua lingua madre?
Sono nato e cresciuto a Londra. A parte gli anni dell’università e un periodo di nove mesi in una città a nord il cui nome è Milton Keynes, a circa un’ora di macchina dalla capitale, non ho mai vissuto in altri luoghi. (A volte, questo mi rattrista: forse avrei dovuto vivere più avventure in altri posti! Ma, del resto, crescere a Londra e nella sua periferia, ecco, anche quello è vivere in un fantastico parco giochi).
E ora, a mio discredito: sono monolingue, terribilmente, orribilmente monolingue. Mamma e papà, emigrati dall’India al Regno Unito negli anni Sessanta, ritenevano vitale che mia sorella e io parlassimo inglese come prima lingua; così, per lo più parlavamo inglese; non ho mai chiesto davvero di imparare di più (di più sul Bengali). Ne so quanto basta per capire quando mia madre mi sgrida, mettiamola così.
Allo stesso modo, sono del tutto privo di competenze linguistiche nelle lingue europee: una volta, a Parigi, in un ristorante ho cercato di ordinare in francese; avevo appena proferito “Je voudrais” che il cameriere mi ha interrotto, dicendo: “Signore, forse sarebbe meglio per tutti se lei ordinasse in inglese”.
Perché Kipling? Com’è la tua storia con lui?
Allora. L’ispirazione di Saffron Jack deve molto all’adattamento del film L’uomo che voleva essere re, regia di John Huston, protagonisti Sean Connery e Michael Caine. È stato il film a catturare la mia immaginazione, piuttosto che il racconto, anche se più tardi, quando sono andato a leggermelo, ho scoperto che il film aveva (almeno a mio parere) reso la storia più cupa di quanto apparisse nel libro.
Ti piacerebbe scrivere una breve recensione su quel film?
Ah! C’è un verso nel libro che tenta di farlo: “The Kaffiristan Job”; un’opera teatrale su “The Italian Job” [in italiano “Un colpo all’italiana”, ndr], ancora oggi uno dei film più famosi di Caine, e una citazione che riguarda le caratteristiche e la natura dell’adattamento di Hutson: una burla semi-comica, per così dire…
Oltre a questo, non direi di avere un forte legame con Kipling: nel Regno Unito credo abbia perso rilevanza col passare degli anni; ho l’impressione che non venga molto letto al momento, a parte “Kim” e “If”. Però prevedo che le cose cambieranno nuovamente quando inizieremo a fare i conti con l’eredità imperialista britannica, e il ruolo che vi gioca la cultura quale veicolo per trasmettere ideologie legate alla superiorità razziale.
Una domanda provocatoria. Gli inglesi mostrano un senso di colpa verso i sudditi dell’impero nati nelle colonie? Hanno prestato loro più attenzione ultimamente? Vorresti esprimere qualcosa al riguardo in ambito letterario?
È una domanda difficile e un terreno minato; bisogna essere molto cauti nell’affrontarlo, soprattutto con termini potenzialmente esplosivi come “colpa”.
Cominciamo dall’inizio. Il significato che dai alla parola “inglese” è scolastico, perché ovviamente stiamo parlando dell’Impero Britannico, non dell’“Impero inglese” – e la continua mescolanza fra “Inghilterra” e “Gran Bretagna” (soprattutto da parte di persone in Inghilterra) è stato uno dei motivi per cui, storicamente, il Regno Unito non ha avuto un dibattito più chiaro sulla colonizzazione e le sue conseguenze.
A mio avviso, la questione non è il senso di colpa quando si tratta del rapporto, e della parentela, fra la Gran Bretagna e i discendenti di persone che erano sudditi dell’Impero – si tratta piuttosto di un non sapere, di una forma di amnesia collettiva. Nella forma in cui ci è stata insegnata la Storia dell’Impero a scuola (attenzione, spoiler: non molto), la decolonizzazione del Secondo Dopoguerra veniva presentata come un processo quasi indolore, incruento, inevitabile (prendere o dare i pochi corpi della separazione all’India [India, sono sarcastico, per chiarire]) – per la Gran Bretagna niente di simile agli orrori, ad esempio, della guerra della Francia in Algeria. E quindi, in questo quadro, non è il senso di colpa che ci troviamo di fronte all’inizio, ma piuttosto un’assenza di conoscenza.
Tutto diventa molto problematico quando quest’assenza di conoscenza si scontra con la realtà dei cittadini di quell’Impero che sbarcano sulle coste della madrepatria dopo il 1948. Perché quello che possiamo dire di aver visto è che quei cittadini, dai Caraibi, dal subcontinente, non sono visti come cittadini – che è quello che sono ed erano – ma piuttosto come alieni. E, naturalmente, i cittadini delle nazioni dominanti (Canada, Australia, Nuova Zelanda, ecc.) non hanno affrontato, né hanno dovuto subire, questo genere di alterità.
Più positivamente: penso che, nel complesso, la cultura letteraria britannica stia migliorando, e sia migliorata, nel riflettere sulla complessità e sulle sfumature di queste vicende, soprattutto negli ultimi vent’anni. Lo si può notare in eventi di alto livello (ad esempio Bernardine Evaristo che vince il Booker Prize, Roger Robinson che vince il TS Eliot Prize), ma anche nell’incremento delle voci che ora fanno parte della cultura letteraria e nelle loro riflessioni sull’Impero come parte di ciò di cui scrivono. Saffron Jack è un piccolo apporto a tutto ciò.
Per favore, puoi dirci che cosa pensi della necessità delle letture poetiche online? Immagino che Zoom sia qui per restare. Le persone si sono abituate a incontrarsi e a leggere, ad esempio, senza viaggiare.
La poesia è “necessaria” online? Certamente: penso che, per molte persone, abbia costituito un momento di connessione e di conforto decisamente necessario. E sospetto che la poesia sarà una delle ultime attività a ritornare a alla situazione precedente alla pandemia, in locali piccoli e poco ventilati. Quindi Zoom e altre piattaforme online saranno qui per restare per un po’.
Potenzialmente tutto questo può essere, credo, una cosa positiva. È stato vergognoso scoprire quanto poco, fino a quel momento, tanti di noi avessero pensato all’accessibilità, a quanto fosse difficile per alcune persone partecipare a un evento, a quanto fosse complicato per altri ascoltare.
Abbiamo visto che, con un’adeguata preparazione, le piattaforme online possono ridurre questi limiti di accesso, così un maggior numero di persone che ne ha desiderio può partecipare. La nostra sfida, una volta che le cose torneranno alla normalità, sarà trovare modi per avvicinare le persone alle persone dal vivo, in una stanza. Perfettamente possibile, ma richiederà agli organizzatori di eventi e agli artisti di programmare in modo diverso da oggi.
Fai parte del collettivo di scrittori Malika’s Poetry Kitchen. Che significato ha per te? Come presenteresti questo gruppo a chi non ne ha mai sentito parlare?
Malika’s Kitchen è stata una parte fondamentale della mia crescita come letterato. È uno spazio in cui molti di noi si incontrano e lavorano su tutti gli aspetti del proprio percorso poetico.Straordinariamente, la maggior parte delle sessioni di lavoro è guidata dai membri, quindi c’è la possibilità di lavorare per elaborare idee da sviluppare e metterle alla prova assieme agli altri.
Ma più di questo: c’è un sentimento di fratellanza e sostegno che ciascuno ricava facendo parte del gruppo. Scriviamo tutti in stili diversi e perseguiamo percorsi artistici variegati. Ma lavoriamo tutti per aiutarci l’uno con l’altro a migliorare in quello che facciamo, e in quello che stiamo cercando di fare. È una sensazione confortante.
Quali sono i tuoi argomenti preferiti in poesia?
Hmmm… Non sono sicuro di essere un vero e proprio autore “tematico”: la maggior parte delle mie poesie prende inizio da istantanee o frammenti di linguaggio che non riesco a togliermi dalla testa, su cui mi concentro; e poi vedo come si sviluppano, e attraverso questo il “possibile soggetto” della poesia inizia a emergere…
Detto questo, molto di ciò che scrivo tende a esaminare e analizzare aspetti dell’economia e della politica, e molto guarda anche al futuro, in particolare alle crisi ecologiche, in cui sembra che ci siamo addentrati come sonnambuli. Ho scritto molto sul mare in questo periodo, e ho dato voce a uno stanco Nettuno, al suo spaesamento su come affrontare ciò che hanno fatto gli umani.
Quanto è importante per te il contatto e il feedback dei tuoi lettori? Come immagini il tuo pubblico ideale?
Non direi che il contatto sia una parte fondamentale del mio processo creativo, perché le possibilità che si verifichi sono così fugaci e imprevedibili… quindi devo essere in grado di lavorare autonomamente, e poi confidare nel mio istinto per perseguire i fini artistici che voglio raggiungere. Ma è bello quando si verificano il contatto e il feedback: sapere che una composizione di parole, che tu hai costruito, ha innescato una qualche forma di risposta in qualcuno è davvero meraviglioso.
Non credo di aver mai immaginato il mio pubblico ideale. Direi che è assolutamente chiunque voglia correre il rischio su un libro pieno di cose che sono poesie, ma potrebbero non essere come quelle con cui ha familiarità, per atmosfere e tematiche.
Un poeta ha bisogno di avere un mentore o no, secondo te?
Direi di sì, poiché finora ho tratto enormi benefici dall’avere diversi mentori e insegnanti nelle varie fasi della mia crescita. È possibile che qualcuno possa sviluppare il proprio talento senza l’aiuto di un mentore, ma è più divertente farlo in presenza di qualcuno che ha affrontato sfide artistiche simili a te e può aiutarti a navigare verso la tua destinazione.
Traduzione dall’inglese di Emilia Mirazchiyska e Angela D’Ambra