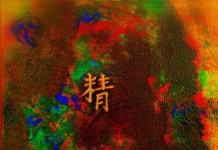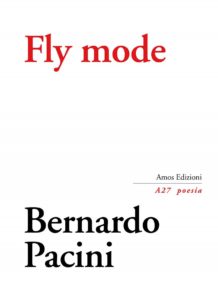La compassione del drone
Da quando la tecnologia ha trasformato i sogni in una realtà praticabile, la poesia si è sempre interessata al volo umano: mi vengono in mente Vincenzo Monti e la sua “Al Signor di Montgolfier” (1784), il fratello aviatore di Brecht (1936), i versi psichedelici già in odore di Vietnam di Allen Ginsberg in “Howl” (1956), dove aeroplani dell’anima ruggiscono sul tetto e sganciano bombe angeliche. I poeti dei secoli scorsi sono passati da un’ammirazione celebrativa e di circostanza, quando ancora il volare pare uno stravagante passatempo riservato alle classi più ricche, all’aperta denuncia di uno strumento che diventa portatore di una violenza terribile e di una morte fatale. Esiti disastrosi, annichilenti, antiumani: Eluard e Guernica, Hikmet e Hiroshima. Nel nuovo millennio il cielo si è riempito di figurette metalliche e leggere, che la differenziazione mercificatrice del neoliberismo ha innalzato nello stesso tempo ad arma sofisticata e a nuova frontiera del divertimento domestico. Si sta ovviamente parlando dei droni.
Bernardo Pacini, nella sua opera “Fly mode”, non si sdegna come un radicale per l’utilizzazione bellica dello strumento, né si esalta come un positivista per la nuova fiammante acquisizione tecnologica. La sua operazione poetica è più sottile: identificativa, fenomenologica, fino a diventare integralmente mimetica. Il drone parla e porta testimonianza del proprio essere prima che del suo impiego. È civile la poesia di Pacini? Probabilmente sì, ma in maniera totalmente antiretorica, e la sua mancanza di accentuazione patetica è il risultato di una riflessione rigorosa sull’uso della lingua nella poesia contemporanea.
Io credo che nel frullatore ideologico dell’odierna poesia, in questo umiliante confronto a base di omissioni e di I like, bisognerebbe riportare sul tavolo le discussioni che avvenivano sessant’anni fa tra i sostenitori di una poesia realistica, facilmente comprensibile al pubblico e che attraverso un linguaggio piano potesse suscitare empatia e indignazione, e una poesia d’avanguardia che sosteneva occorresse inventarsi una pratica nuovissima di ricerca linguistica. Già a partire dalla forma questa poesia doveva riflettere la condizione di alienazione e di sfruttamento della società contemporanea, per poi aprirsi a soluzioni linguistiche di assoluta libertà. Pasolini e i membri del gruppo 63 sono ancora lì che discutono animatamente.
Bernardo Pacini è indubbiamente dalla parte della ricerca, dell’avanguardia, dell’innovazione: se nuovo è l’argomento – ma questo veniva già sostenuto dagli Stilnovisti – nuovo deve essere anche il linguaggio che lo esprime. Bernardo Pacini, invece di descrivere indignato attraverso le parole stereotipate dei social le spedizioni pulitissime e mortali degli stuoli di droni in Iraq e in Afghanistan, usa il materiale di cronaca, attraverso il suo valore metaforico e il suo deposito umanamente condivisibile, per descrivere piuttosto un’esperienza intima consonante a quella cronaca, in cui affiorano ad esempio squarci biografici metaforicamente prossimi a quelli che può provocare un drone con la sua infallibile mira.
Il drone, la vista neutra, la vista partecipativa, la partecipazione in gradi più o meno distaccati alla vita famigliare, la persistenza del ricordo e la persistenza della memoria registrata nello strumento tecnologico: ecco il grande ‘labor’ che produce Pacini nel suo Fly mode.
Ma dire ‘fly mode’ è anche affermare che esiste una reale sospensione della comunicazione e che nei nostri viaggi e passaggi quotidiani, come avviene realmente quando saliamo su un aereo, tutto ormai viene agito a livello di intrattenimento, anche la brutalità, anche lo sterminio. La prima sezione dell’opera, “Alto levato drone”, è aperta non a caso dalla citazione di Hanna Arendt sulla banalità del male e pare che oggi, a cominciare dai piloti di guerra o dai carnefici che guidano il drone omicida da migliaia di chilometri di distanza, tanti piccoli Eichmann stiano proliferando sul pianeta. L’orrore globalizzato diventa così stanca ripetizione o, peggio, perfida fantasia infantile, e la sua ripetizione attecchisce come un accettato modo di dire che non riesce più a scuotere le coscienze addormentate.
Sono in tre i krampus a menare quel negro
Usano sagome di renna, snudano pezzi
di cartoni animati
con cui fracassano le ossa, lo sterno
fesso del mondo.
In 4:3 sarà uno spettacolo atroce
ciò che non esiste, ciò che non sa più d’esistere
desisterà
diventerà una fase standard del discorso.
(Hovering II, p.17, vv.6-14)
Il male non è più guardato e giudicato, ma nel suo processo di spettacolarizzazione è lo schermo di ogni calvario a osservare nell’inversione il soggetto impotente ma soddisfatto. Il climax, nella poesia di Pacini, non è dato da una frase lavorata ad effetto che possa alzare il livello della tensione. Basta aggiungere un ultimo verso evangelico che rimandi all’eclissi dell’uomo e di dio. Si cerca una tecnica di abbassamento retorico personale per poi trovare nella citazione un risultato ben più forte di amplificazione. La ben conosciuta ora tremenda.
Tutto questo cinema più largo che lungo
mi guarda con tutti gli occhi che può.
Non ha lasciato sedie per gli altri
tiene le scarpe sul posto davanti
è arrivato giusto in tempo/ per vedere me.
Non aspetta che si abbassino le luci
perché fuori sono le tre del pomeriggio
e si è già fatto buio su tutta la terra.
(Hovering III, p.18)
Ma nella poesia successiva, “Visual Line of Sight”, già si introduce una nuova linea di pensiero in cui, mentre il drone si alza, la prospettiva si abbassa a un livello domestico: il “tafano in lega di carbonio” (p.19, v.3) è radiocomandato da un pilota di elicotteri in pensione e il suo obbiettivo, ammesso dalla stessa voce della macchina volante, è la chiarificazione di un’immaginazione familiare. La memoria ossequiente al padre e alla madre, dopo aver bruciato le pagine ormai insopportabili di Sbarbaro e Ungaretti, si apre alle possibilità di una certificazione tecnologica.
Il padre diceva spesso alla moglie che la forma di quei monti, a guardarla bene, sembra il profilo di un cane che dorme. O era un drago? Forse sta a me capirlo. Per questo devo andare a vedere: è nascosta dentro di me – tra lo statore e una lucente corona di magneti – la sua speranza inossidabile di esserci e rimanere, facendo memoria del padre e della madre.
(Aerofotogrammetria, p.21)
Nella sezione DCIM (acronimo che sta per ‘immagini dalla camera digitale’) affiorano i ricordi di una vita passata, nel nome di un fratello scomparso ancora prima di venire al mondo.
Dalle persiane socchiuse del finestrone
ricorda, intravvede la corte marcita della casa di sua madre
il fiocco azzurro scolorito
garrotato alla maniglia (…)
(IV, p.32, vv.1-4)
la madre che urla da
dietro / la porta del bagno
invocazione inutile del nome:
morte del corpo / nel suo proprio corpo
(ibid., vv.12-14)
Il tema della vita non formata, del confine non più distinto tra la cosa inanimata e la vita che scorre, si offre al lettore con immagini su cui sembra avere la meglio l’interferenza, la connessione che salta. Stilisticamente questa tendenza è segnata dal ricorso ripetuto alla frattura del verso, all’enjambement e all’interruzione attraverso lo slash. Anche la successione temporale è scardinata dall’evento traumatico e le parole incise sulla lapide di Ignazio, Ai tuoi occhi, mille anni sono come/il giorno di ieri che è passato…, che sono la trascrizione di versi del salmo 90, proiettano la possibilità della selezione dall’album familiare a un panorama universale, ripreso da un punto di vista tanto cronachistico quanto simbolico. I pezzi disposti sulla scacchiera rivelano, al di là della loro materia in apparenza inscalfibile, la predisposizione alla debolezza psichica e al decadimento fisico di un’umanità divenuta astenica e che rivela, ancora vivente, i sintomi della decomposizione.
La regina è troppo debole
giorni interi che non scende
dal letto.
La torre pericola
sul cavedio, a valle la dritta
mostra un alfiere ingoiare
i pacchi Amazon. Il re ha
paura degli alberi (è senza rimedio).
Sotto la gualdrappa del cavallo
moribondo infuria il flipper
di cadaverina e putresceina.
(La circostanza, II, p.36, vv. 5-15)
La realtà circostante si deposita nella poesia di Pacini attraverso scorci non facilmente decifrabili, il fatto di cronaca si deposita misterico, occulto come l’impossibile reportage all’interno del pozzo di Alfredino, primo episodio memorabile di un dolore familiare che divenne audience inaudita, successo mediatico. L’indeterminazione fa in modo che l’elemento biografico e la notizia esterna ancora si confondano, attraverso processi di immedesimazione in cui è ancora il motivo della morte a prevalere. Il soggetto è uno dei tanti elementi selezionabili dal repertorio di immagini della camera digitale che, in un processo di vanificazione, in un repertorio di oggetti decaduti, di immagini scespiriane, diventa tout-court camera ardente. L’allestimento tecnologico lascia che le immagini volino via alla ricerca rapida di un R.I.P.
Lui solo rimane, stelo degli occhi di santa Lucia.
Come me può essere ovunque: stipiti, nicchie, libri
caduti, colli di fiaschi lasciati a metà.
Come un trovante la attende / non parla.
Vuole che lei sappia che il lutto è veemente, lo eccita ancora:
come le ossa di un camaleonte luccica
al buio della camera ardente.
(Lo stelo degli occhi di Santa Lucia,III, p.42, vv.7-13)
Dalle casse del computer sfilano aquile e corvi:
stormi in salti inqueti e trasvoli – da qualche parte avranno
pace.
(IV, p.43, vv1-3)
Il progetto di poesia progressiva di Bernardo Pacini prosegue nella sezione successiva, “Vite in 4K”. La sintesi mi pare un altro punto di forza di questi versi, capaci di raggruppare in maniera analogica gli altoforni di Livorno, il sound di uno sconosciuto gruppo rock islandese, la fine di un amico musico e velocista, descritta in modo per nulla retorico, con quel “la sirena di un’ambulanza, l’unico inno/ del quale ora / porti la mano sul petto.” ( Velocista, p.50, vv.16-17): orgoglio nazionale sgonfiato ante litteram, premonizione di pandemia e cattiva sanità. In “Walkera” (per Clarissa) viene invece descritto l’amore impossibile al tempo dei droni. La macchina incontra la ragazza e l’innamoramento, l’enfasi sentimentale si cristallizzano nella traduzione tecnica dell’intercettazione visiva e nella persistenza dell’immagine rilevata. Come una canzonetta sanremese performata da un cyborg timido e distratto.
Sei sempre dentro di me, letteralmente:
salvata in DCIM, in ordine per data.
Appari all’incirca al minuto 17
Eccetto il martedì – che prendo un’altra strada.
(p.54, vv.9-12)
Macchine e uomini, prodotti tecnologicamente sofisticati e cascami di sangue, sudore e lacrime, siamo tutti destinati all’obsolescenza. In “FAQ” il drone ormai ha lasciato dietro di sé i sogni di gloria e gli ampi orizzonti del suo conduttore e conferma, con la nuova vocazione addomesticata, che ai nostri tempi il territorio è diventato consustanziale alla mappa: i cieli azzurri e le nuvole non sono nemmeno più fatti di cartapesta, ma si irrigidiscono nei tracciati elettronici di google street view. Se un luogo simbolico vorrebbe attraversare, per dimostrare la superiorità della sua costituzione, questo è l’Hot Tube of Despair, il lago sotterraneo sotto il golfo del Messico che uccide ogni forma di vita. Ma il drone riaffiorerebbe in una simulazione dell’affogamento. La macchina che vede tutto degli uomini non può alla fine che fingere la loro fine. O ormai anche l’agonia umana sta diventando macchinica? La metafora apparenta, come un tempo faceva per le rondini pascoliane, gli umani e i droni.
Oh, farmi un’idea precisa della morte
del tipo di stupore che si prova a starne fuori
pinneggiando controvoglia nell’attesa
di tornare in superficie a fare il morto
con le braccia larghe, a croce
(Underwater drone, p.60, vv. 17-21)
Il drone riposa nella sua totale immobilità e cecità. La sua volontà sarebbe di godere di una vista limitata, di una ristrettezza di campo, di vivere sino in fondo la custodia domestica e la sua prospettiva ingabbiata ma confortante. Di percepire di essere per una volta in riposo, senza l’alternativa drastica dell’accensione e dello spegnimento.
Desidero vedere
la stanza in un fotogramma statico
schermata dal contenitore di polistirolo
che mi ottunde la vista
(Irreversible return to land, p.65, vv.5-8)
Ma alla fine tutto ancora una volta ritorna all’indeterminatezza e il micio di casa può assumere l’aspetto del gatto vivo e morto nello stesso tempo dell’esperimento di Schrödinger. Il canarino Titti e la fisica quantistica.
(Qui c’è un gatto?
Dietro un sensore spento mi dico-non è detto
che qui da qualche parte viva un gatto).
(ibid., vv.16-18)
L’obsolescenza, lo scorrimento dei ricordi, l’infermità che cancella la memoria e la memoria tecnologica che ritorna ad essere sensibile testimonianza umana: questo è il filo di kevlar che unisce progressivamente le parti poetiche di “Fly mode”, alla cosiddetta “Appendice” finale, in cui la modalità di scrittura, forse per opporsi allo straniamento e alla frammentazione dell’io parentale, il nonno irreversibilmente malato, diventa blocco resistente di prosa. Virgilio di una verità memoriale consolatoria è qui W.G. Sebald, l’autore di “Austerlitz”.
Se prima dunque i riferimenti biografici scorrevano in versi, propri di una camera verde personale di difficile accesso, qui tutto si raggruppa in una rappresentazione familiare più canonica, antropologicamente meno frammentaria, come poteva essere l’infanzia che si viveva in campagna, con i fumetti incomprensibili che si fingeva di leggere per darsi un tono e l’occhio di bambino irresistibilmente attratto dall’alienità corporale dell’anziano nonno, visto come un’entità vegetale, ancora solida ma intricata. Allora il morire non era lo scoppio, la fiammata, il dissolversi improvviso dell’immagine, ma una forte eredità di carne e di pensiero: nelle ultime parole della raccolta il morire è un mettere a dimora qualcuno che ci è caro. E alla fine il drone, strumento di strage, viene invocato come dispensatore di correzione affettiva, di compassione, dentro un passato ottativo che il suo volo non potrà mai raggiungere.
Avrei voluto già averti, drone, per vedere ciò che non mi era dato – correggere gli errori, zoomare sulla carne increspata del nonno, sfumarla con un filtro che fosse adatto, salvarlo dalla morte su un capiente disco rigido. Ma ormai ricordo solo la grande cattiveria.
(Idrocoltura-fase vegetativa, pp.80-81)