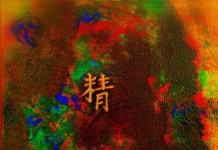Riccardo contemplò con un misto di inquietudine e sgomento l’ingresso in marmo e mattoni rossi del cimitero, incorniciato da quattro cipressi un po’ sbilenchi. Il camposanto del paese non aveva proprio niente di solenne: non fosse stato per l’orrenda croce al neon che svettava sopra la facciata, ultima trovata di un prete in vena di modernità, di giorno avrebbe potuto essere scambiato per uno di quei parchi sonnolenti seminati su discariche dismesse, lontani dai centri trafficati.
A quell’ora, però, non c’era possibilità di confondersi: una moltitudine di lumini bianchi e rossi occhieggiava oltre il cancello in ferro battuto.
Il pensiero di Riccardo andò a sua nonna: da tre anni ormai riposava là dentro, sotto una siepe di bosso rigoglioso che lui, in primavera e in autunno, spuntava meticolosamente.
Si domandò se sua madre avesse pagato la fornitura di energia elettrica per il lumino della tomba o se lo Xanax avesse cancellato in lei anche quella preoccupazione, e annotò mentalmente di controllare le ricevute delle bollette.
Guardò il cellulare: le due e mezza. Che fine avevano fatto gli altri?
Scuotendo la testa e imprecando a bassa voce, si avviò verso il retro del cimitero a passo spedito, lanciando sguardi furtivi allo stradone deserto. Benché fosse primavera, la notte era gelida: Riccardo sollevò il cappuccio della felpa e si avvolse nella sciarpa, lasciando scoperti solamente gli occhi. Si sentì confortato dal tepore del proprio respiro che gli scaldava il naso e le guance intirizzite.
Sul retro si apriva un varco, chiuso alla bell’e meglio con una rete arancione da cantiere, dove un cartello informava che erano in corso lavori di ampliamento e di ristrutturazione: le elezioni comunali, infatti, erano alle porte e la giunta doveva riscattare cinque anni di inettitudine.
Riccardo sbirciò nuovamente il telefonino: le due e trentacinque. Forse gli avevano tirato il pacco; decise che avrebbe aspettato ancora dieci minuti, non uno di più.
Finalmente dalla curva spuntò un veicolo; riconobbe i fari del furgone di Michelangelo, l’unico del gruppo a essere maggiorenne e ad avere la patente. Era stato proprio lui, qualche settimana prima, a lanciare l’idea del colpo. Del resto i cimiteri erano il suo pane quotidiano: con un padre marmista, lapidi e cippi funerari erano stati i suoi primi balocchi. Riccardo sorrise sotto la sciarpa, pensando all’amico cui il padre aveva imposto un nome tanto impegnativo, che il figlio onorava prediligendo, fra i reati minori che già lo avevano reso noto alle forze dell’ordine, il furto di manufatti, meglio se in bronzo.
«Allora, siamo pronti?» fece l’omonimo del Buonarroti, emergendo dal posto di guida. Dal furgone uscirono altri due ragazzi: Dritan e Michele. Riccardo li aveva conosciuti all’epoca delle scuole medie: entrambi ripetenti, non passava giorno senza che fossero convocati in presidenza. Per lui erano un mito. A quel tempo si era dato da fare per attirarne l’attenzione e, alla fine della terza media, loro tre erano divenuti il terrore dei ragazzini delle prime classi, che li omaggiavano con cospicue porzioni delle loro merende e con atti di servilismo, dal cedere il passo al portar loro lo zaino; gesti che sfuggivano agli adulti ma che, fra i ragazzi, rappresentavano un inequivocabile segno di sottomissione. Purtroppo l’epoca d’oro della scuola media era tramontata da un pezzo e, dopo una pluribocciatura all’istituto professionale, si erano ritrovati tutti e tre senza un’occupazione, ancora troppo piccoli per lavorare, qualora ne avessero avuto l’aspirazione, e troppo svogliati per studiare. Trascorrevano le giornate ciondolando fra i parchi del paese e il centro commerciale, dove spendevano in sala giochi i pochi euro che riuscivano a racimolare dai borsellini delle loro madri.
«Sentite bene: mio padre ha detto che se ci sgamano, lui non sa niente di questa storia». Michelangelo si mostrava spavaldo, sentendo su di sé la responsabilità dell’impresa, ma la sua era solo una recita a beneficio dei tre, più piccoli di lui. «Tranquilli, andrà tutto bene, fra un paio d’ore riposeremo nei nostri letti!». Era la prima volta che tentava un colpo con quegli sfigati, e non era sicuro che mantenessero i nervi saldi. Anche suo padre si era mostrato scettico su quella banda improvvisata, benché conoscesse solo Riccardo. Lo aveva incrociato qualche volta andando a trovare sua madre, una Bocca di Rosa sfiorita e impasticcata. La furia che aveva letto negli occhi del ragazzo non gli era piaciuta affatto. Ovviamente si era ben guardato dall’accennare la cosa a Michelangelo, ma quella sera gli aveva raccomandato di essere prudente. «Ognuno per sé e Dio per tutti: non dimenticarlo», gli aveva detto, mentre lo aiutava a sistemare gli attrezzi nel camioncino.
Riccardo prese dal furgone pinze, grimaldelli e un piede di porco e li distribuì silenziosamente ai compagni. Nessuno degli altri aprì bocca. Del resto c’era ben poco da dire: avevano architettato l’impresa diversi giorni prima e ogni particolare, ogni eventuale imprevisto era stato sviscerato nei dettagli, come solo i dilettanti sanno fare.
Tutta l’euforia del pianificare, però, era di colpo scomparsa, lasciando il posto a una vaga apprensione che Riccardo percepiva nitidamente e che leggeva con la medesima chiarezza negli sguardi sfuggenti di Dritan e di Michele.
Michelangelo, intanto, aveva tagliato la rete che chiudeva l’ingresso del cimitero e faceva loro cenno di sbrigarsi. I tre ragazzi si mossero e furono inghiottiti dalla plastica arancione, mentre il capo della banda andava a parcheggiare il furgone in una strada laterale.
«Ragazzi, che figata! Non sono mai stato in un cimitero di notte!». Michele sembrava esaltato dalla nuova esperienza e Riccardo si chiese se avevano fatto bene a coinvolgerlo. Era il più spericolato dei tre, e anche il più incosciente: soffriva di una specie di epilessia, ma non voleva che se ne parlasse. Ricordavano ancora con un brivido quella volta in cui, gonfio di Montenegro, per una stupida scommessa si era arrampicato sul tetto della palestra e avevano dovuto metterci del bello e del buono per farlo scendere. Ma era impensabile escluderlo da quella nottata al cimitero: non li avrebbe mai perdonati. E, in fondo, averlo con loro era una garanzia: se fossero stati scoperti il buon Luigino, suo padre nonché integerrimo vigile urbano, li avrebbe tirati fuori dai guai, come già in passato.
«Sono il fantasma Formaggino… uuuh!». Michele continuava a fare il pagliaccio.
«Dai, Michi, piantala di fare l’idiota e muovi il culo», lo esortò Dritan ponendo fine all’esibizione. Era musulmano, ma la sua famiglia, immigrata dall’Albania quindici anni prima, non era osservante, e comunque a lui il cimitero non faceva né caldo né freddo. Voleva sbrigarsi, fare il lavoro e intascare i cento euro promessi dal padre di Michelangelo. L’indomani si sarebbe fiondato al centro commerciale, dove lo attendeva l’Iphone 5. Era fissato con gli abiti firmati, i profumi costosi e i cellulari di ultima generazione, premessa indispensabile, aveva capito da tempo, per raggiungere il successo nel Bel Paese; opinione peraltro condivisa da tutta la sua famiglia, che investiva per lo più all’outlet i soldi della disoccupazione.
I tre ragazzi si diressero verso la cappella dei Fasoli Colosio; il busto in bronzo di Enea, medaglia d’oro al valor militare, si ergeva nell’angusta nicchia, contornato dai volti austeri di antenati e discendenti.
«Dai, raga, mettiamoci al lavoro». In assenza di Michelangelo, Dritan aveva preso il comando.
«Caro Enea, da oggi i Fasoli hanno finito di tirarsela! Vi immaginate che bordello domani, quando scopriranno che cosa abbiamo fatto? Già mi sembra di sentire quel coglione di mio padre». Michele si mise sull’attenti e imitò la voce del vigile: «In che mondo viviamo, non c’è più rispetto neanche per i morti!».
«Dai, Michi, piantala di dire stronzate e vieni ad aiutarci». Anche Riccardo era innervosito e non vedeva l’ora che quella notte terminasse. Il busto ormai scardinato di Enea Fasoli cadde sul marmo del pavimento con un rumore sordo che li fece sobbalzare: epilogo ben triste per il fervente repubblichino che, interpretando il segno dei tempi, aveva saputo farsi partigiano all’alba del ‘45.
La voce di Michelangelo li raggiunse dall’oscurità: «E che cazzo, non potete fare più piano?».
Il testone bronzeo dell’eroe fu faticosamente trascinato verso l’uscita.
«Se sapevo che fare il ladro era così faticoso, andavo a fare il manovale con mio zio». Michele non riusciva proprio a starsene zitto, ma Riccardo stavolta gliene fu grato: per un attimo dimenticò dove si trovava e gli sembrò di essere tornato alla scuola media, quando loro tre, confidando nell’omertà del bidello in odor di pedofilia, saccheggiavano gli zaini abbandonati negli spogliatoi della palestra.
I ragazzi lavoravano concentrati; ogni lapide passava meticolosamente sotto le loro mani. Cornici, lettere, numeri, croci, angeli e angioletti: tutto veniva silenziosamente accatastato vicino alla rete tagliata.
Era già passata un’ora e si apprestavano a omaggiare dei loro servigi la parte più moderna del camposanto. Riccardo stava spostando la scala per cominciare il saccheggio dalle tombe più in alto, quando la luce dei fanali di un’auto filtrò dalla rete arancione, abbagliandolo.
«Cazzo, i carabinieri!». La voce di Michelangelo era un sussurro.
I ragazzi si appiattirono contro la parete di loculi, udendo il rumore di due portiere che si aprivano.
«Ti prego, ti prego, ti prego fa’ che non ci scoprano. Nonna, aiutami: ti prometto che non lo faccio più». Riccardo pregava tanto intensamente che gli parve che i suoi pensieri riecheggiassero da una tomba all’altra.
Due sagome scure si stagliarono davanti ai fanali: i carabinieri buttarono un occhio dentro il camposanto. I quattro adolescenti non fiatavano, gli occhi puntati con terrore sul taglio nella rete, sperando che l’oscurità riuscisse a occultarlo.
Un fascio di luce investì le lapidi, soffermandosi sull’escavatore giallo che troneggiava nell’anfiteatro cimiteriale; ne illuminò il sedile ribaltato in avanti e il braccio che sprofondava in una buca, quindi proseguì l’esplorazione. Si avvicinò pericolosamente ai quattro ragazzi e sfiorò il ciuffo laccato che si innalzava sulla testa di Michelangelo. Il capo branco non mosse neanche un muscolo, rivelando un inaspettato sangue freddo. O forse era solo paralizzato dalla paura.
Poi la torcia fu spenta.
«Che freddo, stanotte! Appena arrivo in caserma mi piglio un’aspirina: sento che mi sto già ammalando», si lamentò uno dei due gendarmi.
«Forza bambolina, risali in macchina. Qui è tutto tranquillo», lo esortò l’altro.
«Come no… un silenzio di tomba!».
Una risata sguaiata accompagnò il rumore delle portiere che si chiudevano. L’auto fece retromarcia e si allontanò sullo stradone deserto.
«Che culo! Ci è mancato poco». Il viso di Michelangelo stava a poco a poco riacquistando colore.
«Già mi vedevo in caserma a telefonare al mio vecchio!». Michele, invece, sembrava più deluso che sollevato: suo padre e la malattia lo avevano sempre protetto dalla fama di cattivo ragazzo, ma una nottata nella stazione dei caramba lo avrebbe fatto assurgere al livello dei compagni e lo avrebbe liberato da quel senso d’inferiorità che lo accompagnava da quando aveva memoria.
«Raccogliete gli attrezzi, io vado a prendere il furgone». Le parole del capo furono accolte come una liberazione: non avevano intenzione di stare un minuto di più in quel luogo, ma nessuno di loro avrebbe avuto il coraggio di confessarlo.
Con sorprendente rapidità accatastarono la refurtiva nel furgone; poi, come d’accordo, presero quattro direzioni diverse. L’indomani mattina si sarebbero ritrovati nel laboratorio del marmista, che, come pattuito, avrebbe pagato il loro duro lavoro.
Mentre raggiungeva casa attraverso i vigneti, Riccardo giurò a se stesso che non si sarebbe più fatto coinvolgere in un’impresa tanto rischiosa: sentiva ancora le gambe molli dalla paura. Avrebbe ricominciato a spacciare erba all’oratorio: era sempre il lavoro più sicuro.
Nei giorni successivi il vergognoso oltraggio al cimitero del paese, perpetrato dai soliti ignoti, destò grande scalpore. L’immagine della cappella Fasoli Colosio, orfana del busto di Enea, campeggiava sulle prime pagine delle principali testate locali.
Alcuni turisti, appassionati di cronaca, non potendo recarsi presso i più noti scenari di fatti di sangue, si accontentavano di immortalare sugli schermi digitali i loculi violati. Aggirandosi fra i vialetti, qualcuno forse notò, in un’ala più vecchia risparmiata dai malviventi, una lapide perfettamente pulita, incorniciata da una rigogliosa siepe di bosso che era stata artisticamente potata. Non avrebbe potuto ignorare l’enorme mazzo di garofani rossi che traboccava dal vecchio vaso di bronzo. Fra i fiori un biglietto, con due parole vergate in inchiostro blu: Grazie, Riccardo.
FINE