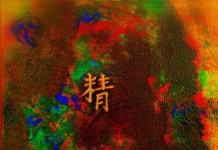Headley Grange, East Hampshire. Un tipico casale vittoriano della british countryside, un’austera eleganza di mattoncini e ampie finestre che svettano su un impeccabile prato all’inglese. Il perfetto contrappunto ad un plumbeo cielo di dicembre. La grande hall d’ingresso offre un colpo d’occhio atipico per l’Inghilterra rurale del 1970. Una cassa Ludwig del diametro di 26 pollici in finitura Green Sparkle staziona monolitica ai piedi dell’ordinata scala che porta ai due piani superiori. John “Bonzo” Bonham, seduto al drum kit, guarda curioso verso l’alto. Non è per nulla convinto. Oltre il pregiato lampadario in pendenti di cristallo su per la stairway, la tromba delle scale, due microfoni Beryerdynamic M160 sono fissati alla ringhiera del secondo pianerottolo. Le valvole sfrigolano nell’adiacente sala ricevimenti, dove l’ingegnere del suono Andy Johns ha allestito con cura le postazioni di John Paul Jones e Jimmy Page, e fasci di cavi creano traiettorie intrecciate sul caldo legno del pavimento fino a raggiungere lo spiazzo esterno. Lì, tra la ghiaia, staziona minaccioso un grosso camion, militaresco sin dal colore: il Rolling Stones Mobile Studio.
Tutto è pronto, con buona pace di Bonham e delle sue perplessità, lì, solo, ai piedi delle scale con il resto della band lontana e due microfoni ipercardioidi appesi otto metri sopra la sua testa.
Per quanto l’astuto genio calcolatore di Jimmy Page culli le sue ambizioni in un sogno ad occhi aperti, quello che succede nei sei giorni seguenti non ha nulla a che fare con strategie e furbizia, ma risponde al richiamo della magia del caso, delle intuizioni epocali, delle piccole scelte che portano a grandi risultati. I Led Zeppelin non lo sanno ma stanno scrivendo la storia.
L’attacco di Led Zeppelin IV non lascia prigionieri, un uno-due di istant classics che riuscirà a pochi altri negli anni a venire: l’incredibile mix di perizia tecnica e spontaneità di Black Dog, un complesso intreccio ritmico giocato su una dinamica di botta e risposta tra voce e strumenti, e l’immortale Rock n’ Roll, una dichiarazione d’intenti, il surrogato di uno standard che si reincarna in un nuovo standard. Rock n’ Roll nasce casualmente, per magia, alla fine dell’ennesima take errata di Four Sticks. Bonzo, per scaricare la rabbia, si avventura nel pattern ritmico dell’intro di Keep on Knockin’ di Little Richards e la band lo segue in un’improvvisazione al fulmicotone. Così nasce uno dei pezzi più amati e influenti del XX secolo, un locomotiva lanciata a tutta velocità da palate di spontaneità elettrica. Sono passati otto minuti e trentotto secondi dall’inizio di Led Zeppelin IV, già sufficienti per decretarlo un ottimo disco. Non abbastanza per etichettarlo capolavoro.
Dopo il lusso interlocutorio della bucolica Battle of Evermore, con ospite Sandy Denny dei Fairport Convention, la band cala l’asso. Stairway to Heaven: gli otto minuti che cambiano una vita, l’arpeggio che spinge milioni di ragazzi a imbracciare una chitarra, la colonna sonora di mille e ancora mille esistenze, a Londra come a Tokyo, nella campagna del Sussex come a New York. In Stairway to Heaven c’è tutto, la perizia strumentale e le doti vocali, la chitarra che culla e il rock solo, l’eleganza degli arrangiamenti e l’intelligenza esecutiva: quella leggerezza, ad esempio, con cui Bonham scandisce la sua rullata d’ingresso dopo quattro minuti e diciotto secondi, il valore aggiunto di un equilibrio già di suo perfetto che continua a stupire anche all’ennesimo ascolto.
I Led Zeppelin non saranno più semplicemente un’ottima band adorata da milioni di fan e punzecchiata dalla spocchia della critica, i Led Zeppelin imprimono a fuoco la loro immortale poesia su quella palla sospesa nel nulla che chiamiamo mondo. I Led Zeppelin diventano i più grandi degli anni ’70, forse i più grandi di sempre.
Il lato B del vinile non può certo fare meglio di quanto impresso nei solchi delle prime quattro canzoni, tuttavia gli Zep non sbagliano un colpo, l’allegro movimento di Misty Mountain Hop, giocata su un continuo contrappunto chitarra/organo/voce che porta la tensione fino al punto in cui le corde vocali di Plant salgono in cattedra, il tutto su una monolitica parte di Bonham le cui pelli, grazie alla poco ortodossa amplificazione nella tromba delle scale, sembrano respirare, vivere. Il batterista resta sugli scudi anche nella successiva Four Sticks (le cui parti di batteria vengono registrate senza fortuna diverse volte, fino al momento in cui il batterista impugna quattro bacchette contemporaneamente e in due takes ottiene la versione definitiva) e dopo l’acustico relax di Going to California, nella conclusiva When The Levee Breaks (The Drum Song, come l’ha ribattezzata Jimmy Page), un acidissimo blues su tempo dimezzato la cui potenza ritmica potrebbe tranquillamente essere portata ad esempio per spiegare la fisica del suono.
Led Zeppelin IV finisce qui, otto semplici pezzi di grande musica in cui si trovano i semi di ciò che germoglierà sotto altre vesti in decine di realtà di successo dei tempi recenti, un’eredità che si sposta nei decenni senza scalfirsi, costante termine di paragone di quanto il rock ciclicamente propone. A dispetto della critica, che non perdona alla band il suo riappropriarsi così sfacciatamente di stilemi e pattern neri, la grandezza dei Led Zeppelin sta proprio qui, nel tradurre a una gioventù bianca e pronta a imbracciare le chitarre un paradigma sonoro di futuro invischiato fino al collo nel rassicurante fango del passato.
Il Rock non sarà più lo stesso, e, a ben ascoltare, Led Zeppelin IV avrebbe potuto anche morire lì, quel lunedì 8 novembre 1971, giorno in cui il mondo conobbe la sua inarrivabile alchimia.