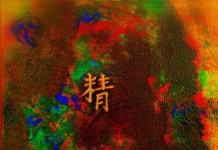La passione del grunge
Nonostante il lavoro più importante e identificativo degli Alice in Chains sia quasi unanimemente considerato Dirt, il loro secondo album, è di certo Facelift, il loro disco d’esordio, quello che ha iniziato a far notare il grunge al mondo, facendolo uscire dalla ristretta scena di Seattle. Scena che, alla fine degli anni Ottanta, era musicalmente una delle più prolifiche e innovative e che vide la nascita di molti gruppi che avrebbero inciso a livello mondiale negli anni successivi. Pubblicato un anno prima dei celebri Nevermind dei Nirvana e Ten dei Pearl Jam – gli album che portarono il grunge al successo commerciale, e di conseguenza alla sua diffusione planetaria –, Facelift è uno di quei dischi che hanno cambiato la storia della musica, ridando visibilità e voce a una generazione che si ribellava alle mode che avevano infestato il decennio precedente di hair metal, quel rock cotonato fatto di colori sgargianti e immagini di bella vita sempre e ovunque, ma che di prodotti di qualità, a parte Van Halen, Guns’n’Roses e forse qualcun altro, ne ha lasciata davvero poca.
Quest’opera degli Alice in Chains è un disco di forte impatto, sia musicale che testuale, il cui sound non rinnega l’heavy metal degli anni precedenti, anzi, sarà un marchio di fabbrica in grado di distinguerli dagli altri tre Fab Four del Seattle Sound (Nirvana, Pearl Jam e Soundgarden) e in generale dagli altri gruppi grunge.
Caratterizzato da ritmi potenti, ipnotici e incalzanti, Facelift parte veloce con un brano, We Die Young, in cui musica e testo rappresentano emblematicamente il dolore e la frustrazione di quella generazione; un pezzo che fa capire subito quale saranno l’impronta cupa e rabbiosa dei loro testi e l’energia della loro musica. Jerry Cantrell, chitarrista di intelligenza sopraffina e maestro del riffage, apre subito con un suono massiccio, trascinante nell’introdurre la ritmica sostenuta del basso di Mike Starr e la precisa batteria di Sean Kinney, perfetti metronomi delle sue variazioni e, soprattutto, della voce di quel meraviglioso vocalist che è stato Layne Staley, vera perla di questa band sorprendente.
Dopo il primo passaggio, che fa riprendere il fiato solo alla fine, si passa a Man in the box, brano che ha dato loro fama internazionale grazie al lancio su MTV, in cui si nota l’ispirazione al dark sound dei Black Sabbath, che sarà presente in molti dei loro brani più famosi, con un riff ipnotico e continuo che si zittisce solo per lasciare spazio all’urlo di Staley, nei passaggi che ne hanno decretato l’entrata di diritto nel gotha dei cantanti rock. In questo brano i quattro denunciano la soggezione dell’uomo al potere economico, quella dipendenza dai media che è sempre peggiorata arrivando ai giorni nostri: una sorta di avvertimento di qualcosa che loro avevano già fortemente percepito. Il video che promuove il pezzo è altrettanto significativo nel dare dimensione all’immagine del grunge, lontana dalle apparenze patinate e finte del decennio musicale precedente.
Sea of Sorrow è un momento quasi divertente, impreziosito da un breve ma memorabile assolo di chitarra, in cui si alternano momenti lenti ed esplosioni ritmiche e si comincia a notare quello che sarà l’altro marchio di fabbrica del gruppo: l’abbinata vocale di Staley e Cantrell, che caratterizzerà gli AIC anche dopo la scomparsa del frontman, e che resterà inimitabile per tutta la loro carriera.
Segue poi un terzetto di brani in cui si sublima definitivamente la capacità vocale di Staley: le più lente ed emotive Bleed the Freak e I Can’t Remember, e la complicata Love, Hate, Love, quest’ultima caratterizzata da continue variazioni tra pause, stacchi repentini e ripartenze metalliche.
In It Ain’t Like That si ritorna ad una dimensione di rock pesante, con basso e chitarra a dettare un ritmo cupo e un riff ossessivo con la voce che si cala nel contesto come strumento aggiunto, seguita dall’ennesima dimostrazione di eccellenza vocale in Sunshine.
Altro cambiamento in Put You Down, dove Cantrell dimostra tutta la sua creatività con un pezzo che nulla ha da invidiare alle chitarre del rinato progressive metal, e nell’intensa, sebbene più schematica, Confusion, in cui si percepisce invece più chiaramente l’influenza zeppeliniana (e chi non l’ha avuta?), soprattutto nei suoni della chitarra.
Il disco si conclude con due brani, I Know Somethin’ (‘Bout You) e la magnifica Real Thing, in cui l’amalgama è più tipicamente grunge, con quei suoni e ritmi incalzanti che ritroveremo anche in altri gruppi e che daranno l’etichetta a questa musica.
Dodici brani splendidi, intensi e coinvolgenti, corredati dalle capacità tecniche e creative di Staley e Cantrell, che pochi eguali hanno avuto nell’ambito del grunge e che hanno dato il via a un cambiamento dei canoni del rock, che a quel tempo aveva perso la sua identità svendendosi al business e a un’immagine di facile ritorno ma di (molto) scarsa creatività.
Facelift è un album che facilmente si colloca tra quei dischi formidabili assolutamente da avere, in cui si respira un cambiamento epocale e si gode di una grazia creativa che ai tempi latitava, almeno nel rock, salvo che per quei gruppi di prog metal che stavano parallelamente ridando smalto al loro genere (Dream Theater, Queensrÿche, Fates Warning). Un’opera che non definisce totalmente la dimensione degli Alice in Chains, che affineranno la loro musica nei successivi (capo)lavori Dirt e Jar of Flies – in cui le armonizzazioni di Cantrell e l’intensità di Staley arriveranno a livelli eccelsi – lasciando per strada le influenze del passato e dandosi un’identità ben precisa e distintiva. Un album che, oltre a essere l’inizio di tutto, ha reso l’idea di che cosa significhi “cambiamento” e ha saputo dar voce a una generazione preda di depressione e impotenza, in un urlo artistico che ha dettato la scena musicale mondiale per un ulteriore decennio. Un’intensità che probabilmente sarebbe durata anche di più se la prematura scomparsa del cantante, arresosi ai suoi fantasmi e ai tormenti interiori non avesse frenato l’entusiasmo e la spinta del gruppo, che resta comunque una realtà musicale importante i cui ultimi lavori, per chi sa ascoltare, sono ancora dipendenti dalla potenza e dal fascino che Facelift ha creato attorno a loro.
Jerry Cantrell entra di diritto tra i chitarristi più creativi e intelligenti, capace, rispetto ad altri gruppi grunge, di dare uno spazio molto più ampio a differenti sonorità senza cementarsi in uno status etichettato, e raggiungendo un livello sopraffino nell’armonizzare suoni e voce a supporto del vocalist. Layne Staley, rimasto davvero troppo poco, è in assoluto “la” voce del grunge, l’unico di quel periodo capace di distinguersi nel panorama rock; come è stato, e lo dico senza timori, Robert Plant a cavallo degli anni Sessanta/Settanta, con la differenza che forse la voce di Staley, e la sua meravigliosa capacità interpretativa, non erano dipendenti dalla tecnica, ma totalmente dalla passione.
In definitiva Facelift è un must per chi ama la musica, un capolavoro innovativo e sorprendente che vivrà molto a lungo essendosi ritagliato, assieme ai suoi due successori Dirt e Jar of Flies, uno spazio tra quelle opere che diventano “senza tempo”.
Gli AIC hanno dedicato l’intero album a Andrew Wood, vocalist dei Mother Love Bone, una delle prime band del grunge di Seattle alla quale avevano fatto da spalla, scomparso poco prima della pubblicazione del loro esordio.