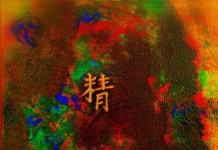Luciano saliva lentamente le scale della palazzina anni settanta alla periferia della città. Erano le sette di una calda serata estiva, di quelle che un tempo avrebbe trascorso all’aperto, davanti a un bicchiere di prosecco in compagnia dei colleghi, evasi insieme a lui dalla calura dell’ufficio.
Ma Laura non era tipo da aperitivi al bar e poi, negli ultimi tempi, le era presa la fissa del risparmio e stava attenta ad ogni euro che gli uscisse dalle tasche.
La porta dell’appartamento era chiusa e, mentre armeggiava nella valigetta alla ricerca delle chiavi, lo sguardo gli cadde sulla targhetta accanto al campanello: “Fam. Salvetti Ing. Luciano”. Il suo titolo di studio, così esibito sulla porta di casa, continuava a metterlo a disagio; ma all’epoca del loro trasloco, sua moglie aveva tanto insistito che, alla fine, aveva dovuto cedere. Ricordava bene quella loro prima discussione, quando, freschi sposini, avevano fatto il loro ingresso nell’ampio quadrilocale, dono di nozze dei genitori di Laura.
«Ma, amore, come sei sciocco: un titolo di studio non è certo un disonore!», lo aveva blandito quando aveva avanzato qualche obiezione.
«Non so, Laura, non sono convinto: mi sembra così provinciale!». Si era illuso che quella parola l’avrebbe indotta a desistere, invece era stata implacabile: «Bè, se avere una laurea è da provinciali, allora noi lo siamo!». Avendo sposato un ingegnere, era come se il famoso pezzo di carta appartenesse un po’ anche a lei. «E poi», aveva aggiunto, cingendogli il collo con le braccia, «pensa a tutti i sacrifici che hanno fatto i tuoi per farti studiare. Che ti costa dargli la piccola soddisfazione di vedere il tuo titolo sulla porta di casa?». Davanti a quel colpo basso, Luciano aveva deposto le armi e un bacio sulle sue labbra.
Finalmente l’uomo aprì la porta d’ingresso e fu investito dall’odore stuzzicante di carne alla griglia.
«Bentornato, amore! Stasera una bella grigliata per il mio maritino che ha lavorato tanto!», gli cinguettò dal balcone la moglie che, da quando aveva perso il lavoro per una riduzione del personale, aveva scoperto l’arte culinaria. All’indomani del licenziamento il marito, che aveva temuto un tracollo emotivo, aveva assistito a una trasformazione repentina: Laura sembrava essersi spogliata con sollievo dei tailleur da impiegata per indossare, con inconfessato appagamento, grembiulini vezzosi da casalinga perfetta; quasi non aspettasse altro.
Luciano osservò la figura morbida della moglie affaccendarsi sulla griglia elettrica, i capelli biondi sollevati sulla nuca a scoprire il collo imperlato di sudore. In un istante attraversò i pochi metri che li separavano, si chinò e la strinse da dietro, strusciando le guance sulla pelle bianca del collo e armeggiando goffamente con il nodo della cintura che chiudeva la vestaglietta di cotone leggero.
La donna lo allontanò infastidita: «Ma che fai? Guarda cosa hai combinato: ho rovesciato l’olio! Adesso dovrò pulire tutto! Vai a cambiarti, va’, che fra dieci minuti è in tavola». La sua attenzione era tutta rivolta alla macchia che si andava allargando sul pavimento di finto cotto.
Luciano andò in camera da letto, si tolse gli abiti da lavoro, che ripiegò con cura, e indossò un paio di calzoncini e una maglietta sdrucita. Aprì la finestra e, sporgendosi sul davanzale, si concesse una sigaretta, contravvenendo così alle regole di Laura. Rientrando nell’angusta cucina, vide che era ancora sul balcone, intenta a strofinare energicamente il pavimento. Non osando più avvicinarsi, ripiegò sul televisore, che sintonizzò su un insulso gioco a premi. Mentalmente si ripromise di scorrere più tardi, sul sito dell’ANSA, le notizie del giorno, troppo stanco in quel momento per concentrarsi su qualunque telegiornale.
Laura entrò nella stanza, deponendo solennemente sulla tavola un piatto colmo di carne.
«Vuoi proprio farmi venire la pancetta da uomo sposato!» scherzò bonariamente alla vista della tavola imbandita.
«Non sei obbligato a mangiare, se non hai fame», lo raggelò lei, ancora irritata per la chiazza d’olio che non era riuscita a pulire del tutto.
«Ma, tesoro, stavo scherzando: sai che la sera torno sempre affamato… e non solo di cibo». Le si avvicinò e le sfiorò le labbra con un bacio leggero.
«Che cos’è questo odore? Sento puzza di fumo!». Laura annusava l’aria e i vestiti del marito.
«Sono io che brucio d’amore!». Cercava di fare lo spiritoso, paventando la discussione che sarebbe seguita.
«Ma per la miseria: lo sai che non voglio che fumi in casa! Detesto la puzza di sigaretta! E il mozzicone: dove l’hai buttato? Non nella pattumiera, spero: non voglio che impesti tutta la cucina».
«No, non è nella pattumiera». Luciano sperò di non dover confessare che aveva gettato la cicca nel tombino del vialetto sotto casa. Non ci aveva neanche riflettuto: aveva preso la mira e, con un colpo secco dell’indice, aveva centrato perfettamente il bersaglio. Lì in cucina, però, sotto lo sguardo inquisitorio di Laura, si vergognò dell’infantile soddisfazione che aveva provato.
Temendo altre domande sull’argomento, cercò di buttare acqua sul fuoco, appellandosi ai suoi buoni propositi: «Dai, tesoro, parliamo d’altro: sai che sto cercando di smettere».
«Non devi cercare, devi farlo e basta. Mio padre, quando decise di smettere, ci riuscì da un giorno all’altro, senza tante manfrine! È la volontà che ti manca».
Se c’era una cosa che irritava Luciano, era sentirsi paragonare al suocero, al Santo Subito, come lo chiamava nel suo intimo. «Forse hai ragione», le rispose piccato e si sedette, risoluto a concentrarsi sul cibo. Continuarono il pasto in silenzio: lei immersa nella TV, il marito sfogliando distrattamente una rivista, appoggiata deliberatamente accanto al piatto, nel preciso intento di innervosire la consorte. Senza sfiorarsi, sparecchiarono la tavola con gesti meccanici.
«Ti preparo il caffè?» chiese Laura, fattasi d’un tratto più dolce.
«Grazie», le fece lui di rimando, perplesso per quel repentino cambiamento d’umore. La donna gli volse le spalle e iniziò a trafficare con la macchinetta a cialde, sfavillante dono di nozze che aveva preteso nella lista dei regali.
«Sai», esordì Luciano, «ho pensato che potrei chiedere le ferie per settembre: fa ancora caldo, c’è meno gente in giro e i prezzi sono più bassi. Che ne diresti di andare qualche giorno in Sicilia o in Sardegna? Che cosa ti ispira di più?».
«Io, veramente, avrei altri progetti per l’autunno», gli rispose senza voltarsi.
«Che progetti? Sono incluso anch’io?».
«Sei necessario». Scandendo le sillabe, si volse verso di lui e proseguì: «Ho pensato che è arrivato il momento di avere un figlio».
La parola risuonò nella stanza come una condanna. Per qualche secondo fiatò solo la televisione che, con inarrivabile tempismo, trasmetteva la pubblicità di una marca di pannolini dall’imbattibile potere assorbente.
«Allora? Non dici niente?» lo incalzò.
«No… è che sono solo un po’ sorpreso».
«Sorpreso? E perché? Cosa credevi: che avremmo fatto due cuori e una capanna da qui all’eternità?».
«Che discorsi! Certo che ho pensato a un figlio. È solo che mi sembra un po’ prematuro: in fondo non è nemmeno un anno che siamo sposati».
«Che cosa dobbiamo aspettare? Ti ricordo che ho già trentasette anni. Sai come le chiamano in ospedale quelle come me? Primipare attempate». La donna pronunciò le parole come un insulto, poi continuò: «Io voglio fare la mamma per mio figlio, non la nonna!».
«Non so: un figlio cambia tutto! Avevo pensato che avremmo fatto gli sposini ancora per un po’».
«Senti», ragionò Laura mentre la sua voce diveniva via via più acuta, «facciamoci due conti: io ho trentasette anni. Se siamo fortunati rimarrò incinta fra qualche mese, perché non puoi certo sperare di fare un colpo un centro».
Il pensiero di Luciano corse al mozzicone nel tombino, mentre Laura proseguiva la sua filippica: «Quindi, se non ci sono intoppi, partorirò a trentotto anni. Dammi un annetto e mezzo di allattamento al seno e svezzamento, e arrivo alla vigilia dei quaranta: sono quasi fuori tempo massimo per il secondo».
«Il secondo cosa?»
«Il nostro secondogenito, no? Non vorrai che il nostro bambino sia un figlio unico, come te?».
«C’è di peggio a questo mondo che essere figli unici. Io ho avuto un’infanzia bellissima! E non ho mai sentito la mancanza di un fratello o di una sorella».
«E ci credo!», obiettò acida Laura, «Hai fatto il reuccio tutto il tempo, viziato e coccolato come un principino!».
«Perché dici così? Mi pare di essere cresciuto bene!».
«Certo, certo, come no! Sei cresciuto!» ripeté sarcastica lei, guardando con ostentata ironia i modellini di auto che si intravvedevano nella vetrinetta dell’ingresso e l’ultimo numero di “Quattroruotine” ancora aperto sul tavolo. «E comunque dillo, dillo che non vuoi un figlio da me!» piagnucolò.
«Ma, tesoro, certo che lo voglio, però non corriamo troppo, iniziamo a pensare al primo». Le lacrime, come al solito, riuscivano a fargli perdere ogni prudenza e a fargli dichiarare cose che non era proprio sicuro di volere.
«Davvero, amore?». La donna lo scrutava attraverso il velo delle lacrime. «Allora abbiamo deciso! Ho già parlato con la ginecologa e guarda qua il calendario: vedi i giorni segnati da un cuoricino? Sono quelli fertili. Dalla prossima settimana ci si mette al lavoro!».
Lo sguardo malizioso che la moglie gli lanciò, ben lungi dall’eccitarlo, gli fece venir voglia di una boccata d’aria: «Vado a portar fuori la spazzatura».
Mentre percorreva il vialetto condominiale, preferì non pensare alla discussione, per concentrarsi sull’ultima sigaretta della giornata. Anzi, quella sera, in via del tutto eccezionale, se ne accordò due, una dopo l’altra.
Quando rientrò in casa, Laura lo accolse con un lungo bacio. «Dovrai proprio smettere, adesso che avremo un figlio», gli sussurrò melliflua, per nulla ingannata dal sapore della mentina che il marito aveva sgranocchiato. Tenendolo stretto nella morsa delle sue braccia, proseguì con lo stesso tono mieloso: «E poi… dobbiamo trovare un posto per tutta la tua roba».
«Di che roba stai parlando?».
«La roba che c’è nello studio, no? I modellini, le riviste, la collezione di Tex, la playstation… Come possiamo fare la cameretta, altrimenti?».
«Non vorrai che butti via tutto, vero?».
«La play potrebbe stare in soggiorno, ma il resto potresti metterlo in garage, se proprio vuoi tenerlo».
L’uomo non rispose, accese la grande TV al plasma nel salotto e si accasciò sul divano.
⃰ ⃰ ⃰
Avere un figlio si rivelò un compito più impegnativo del previsto. Da subito Luciano comprese che romanticherie e sentimentalismi erano banditi dall’impresa. Accadde la sera del primo giorno segnato col cuoricino: quando la moglie fece il suo ingresso nella camera da letto, Luciano la strinse in un abbraccio che voleva essere appassionato e la attirò sopra di sé, nel lettone di ecopelle bianca.
«No, amore, non così: è meglio che tu stia sopra… aiutiamoli con la gravità i tuoi piccoli girini».
Come la donna aveva pronosticato, la campagna nascite occupò svariati mesi. Dopo una rigida dieta a base di salmone e carni rosse, che favorivano la motilità degli spermatozoi, la rigorosa astinenza da caffè e zuccheri, e docce fredde a tutte le ore (stando ai dettami di Laura, avrebbero quintuplicato la quantità del suo sperma), Luciano riuscì nel duro cimento.
Seguirono quatto mesi di nausee, due di sciatalgia, tre di reflusso gastrico.
Quando un giovedì sera, davanti alle immagini di “Ventiquattr’ore in sala parto”, Laura si alzò in piedi e, contemplando la macchia sul divano blu, pronunciò le fatidiche parole: «Mi si sono rotte le acque», l’uomo era pronto. Afferrò la valigia, preparata tre mesi addietro, il kit per la conservazione del cordone ombelicale, la videocamera e scortò premurosamente la moglie in auto. Di quella lunga notte gli sarebbero rimasti solo ricordi confusi, se non fosse stato per le due ore di filmato che Laura, inconsapevole dei liquidi che le sarebbero traboccati da ogni orifizio, gli aveva imposto di girare.
Nella mattinata poté affidare madre e figlio alle cure del reparto maternità, dove sarebbero stati confinati per altri quattro giorni. Ma potevano essere anche di più: se il bimbo fosse divenuto itterico, o se fosse subentrata qualunque complicazione, anche non grave.
Luciano, uscendo dall’ospedale, provò la stessa ebbrezza che sentiva quando forcava a scuola, con in più la consapevolezza di aver fatto il proprio dovere. Nel programmarsi le quattro serate di libertà che lo attendevano (hamburger, patatine fritte, fumo libero e silenzio), l’uomo stabilì di dedicare qualche ora al garage: avrebbe progettato un angolino tutto suo, dove montare i suoi modellini, sfogliare Tex e, magari, anche fumare.
Laura, in casa, avrebbe giocato a fare la mamma.
FINE
Leggi altri racconti d’autore