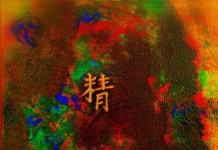La sera prima della sua morte, il signor Miranda arrivò al Caffè Funchal poco dopo le undici. Scelse il solito posto all’aperto, vicino alla balaustra che dava sul fiume. Dalla tasca interna della giacca estrasse un astuccio contenente una penna stilografica e due volumi, che appoggiò sul tavolino. Era sua abitudine portare con sé un’edizione tascabile del Filodemo di Camões e un raccoglitore di cartone giallo, sulla cui copertina, in bella calligrafia, campeggiava la scritta: “L’espresso delle sette e diciassette”. Solitamente lavorava sui fogli sgualciti del manoscritto per tutta la notte, facendo correzioni e annotazioni al margine del testo, finché i proprietari alle prime luci dell’alba chiudevano il locale. Quella sera, invece, non lo degnò nemmeno di uno sguardo. Sembrava che qualcosa lo preoccupasse.
Ormai era un cliente abituale e, non appena lo riconobbe, il cameriere si mosse verso di lui per prendere l’ordinazione. Avvicinandosi, notò qualcosa di diverso in quell’uomo taciturno e solitario: il signor Miranda, quella sera, aveva gli occhi tristi. Indossava una giacca zaffiro, i cui contorni si confondevano con le colline della valle circostante, visibili al di là del parapetto. Quando il vento saliva dal Duero, il signor Miranda si allacciava i bottoni di velluto per proteggersi dal freddo. Un berretto inglese di cotone leggero nascondeva i capelli ispidi e rossicci, lascito tangibile, insieme alla carnagione pallida, della madre bretone. Le mani erano imponenti e nodose, più adatte a impugnare un remo che una penna. Una sfiorava la tovaglia, come ad accertarsi che il mondo attorno a lui esistesse ancora, mentre l’altra, appoggiata sulla guancia scavata, sorreggeva il peso della sua intera figura. Sembravano grandi ancore.
«Buonasera, signor Miranda», esordì il ragazzo distogliendo l’uomo dai suoi pensieri.
«Buonasera, Alberto», rispose quello con tono gentile. «Per favore, portami il solito».
«Mi dispiace, ma il Ramos Pinto è finito», replicò Alberto, le mani incrociate dietro la schiena. «Questa sera abbiamo dell’ottimo vintage di Graham’s. È un po’ più caro, ma le posso assicurare che non se ne pentirà».
«Ne prendo una bottiglia allora. E ricordati della mia piantina».
«Certamente, signor Miranda».
Qualche minuto dopo il cameriere ritornò dal bar con un vassoio metallico contenente la bottiglia di porto e un bicchiere appena lavato. Nell’altra mano, invece, teneva un vasetto di terracotta in cui era riposta una piccola digitale. Su precisa richiesta del signor Miranda, tutte le sere Alberto la portava al suo tavolo. Lui gliel’aveva affidata il primo giorno in cui si era recato al Caffè Funchal, un paio di anni prima, e dopo avergli allungato qualche escudo, gli aveva chiesto di custodirla per lui, visto che non aveva un posto in cui metterla. Così, Alberto la teneva su un davanzale in cucina e le dava l’acqua tutti i giorni. Il signor Miranda era un cliente silenzioso e pagava sempre le consumazioni: non mostrava altre stranezze, perciò i gestori del locale erano felici di accontentarlo.
«Vedo che questa sera non lavora al suo libro», accennò il ragazzo mentre sistemava gli oggetti sul tavolo.
«Credimi, Alberto, questa non è la notte giusta per scrivere», spiegò il signor Miranda senza convinzione.
«È in difficoltà con la trama? Magari la posso aiutare: vado spesso al cinema e chissà che non mi venga in mente l’idea giusta».
«La storia è molto semplice e ce l’ho già tutta in mente. Racconta il viaggio dell’espresso Porto-Lisbona in una mattina soleggiata», sospirò il signor Miranda. «Il problema è che, a volte, ci dimentichiamo del tempo. Nella mia vita non ho fatto altro che scrivere questo libro, ma forse non è bastato».
Prima che Alberto potesse chiedergli a che cosa alludesse, una giovane coppia lo chiamò dall’altro lato della piazzetta per ordinare. Il ragazzo sorrise, si scusò e, prima di allontanarsi, disse: «Spero che me lo farà leggere, quando sarà finito».
«Solo le pagine migliori, ragazzo», precisò l’uomo. «Solo le pagine migliori».
Mentre segnava sul taccuino una caipirinha e un’acqua gassata, Alberto controllò il signor Miranda con la coda dell’occhio. L’uomo se ne stava afflosciato sul tavolino a fissare il vuoto. Ogni tanto lanciava un’occhiata ai fiori che si allungavano dallo stelo tremolante. Ma la distrazione durava soltanto pochi secondi e, in men che non si dica, le sfumature indaco della pianta si smarrivano in una nuvola di pensieri dimenticati.
Il signor Miranda aveva altri ragionamenti per la testa. La sua attenzione pareva rivolta a un’indagine tanto scrupolosa quanto svogliata: il suo sguardo vagava nella piazzetta, tra i sampietrini del pavimento, le gambe dei tavolini in ferro battuto e le calzature degli avventori del locale. Alla fioca luce dei lampioni, le sue pupille acquose disegnavano traiettorie senza costrutto, in equilibrio tra l’inquietudine e una desolante rassegnazione che Alberto non si sapeva spiegare.
Le ore notturne si consumarono una dopo l’altra: il ragazzo correva tra il bancone di zinco e la piazzetta e il signor Miranda se ne stava in compagnia del porto e dei suoi problemi.
Poi, verso le due e mezza, mentre portava una torta di compleanno, Alberto si accorse che al tavolo del signor Miranda si era seduto qualcuno. Guardò meglio e riconobbe immediatamente il profilo di Estanislau Ferreira. Non era un cliente abituale del Caffè Funchal, e lo si vedeva raramente da quella parte della città. Ogni tanto, però, passava a fare una partita a carte. Per quello che ne sapeva, era uno con cui era meglio non avere a che fare e, soprattutto, con cui non era bello perdere al gioco. Nessuno conosceva il colore dei suoi occhi: un paio di lenti scure, bordate da una sottile linea argentata, li nascondevano giorno e notte. La fronte ampia rivelava un principio di calvizie: i capelli avevano l’attaccatura all’altezza della nuca e, dopo aver circumnavigato l’ellisse delle orecchie, si ricongiungevano ai riccioli di una barba cespugliosa, rigata dai segni dell’età. Un imponente paio di mustacchi completava la cornice di un volto arcigno, solido, che ispirava un timore spontaneo a chiunque si imbattesse in lui.
La carnagione olivastra si intonava perfettamente al cubano color mogano che fumava con ostinazione, ad ampie boccate, e il suo arrivo era sempre annunciato dall’odore penetrante del sigaro. Il collo imponente era nascosto da un maglione a lupetto, su cui portava una giacca cenere di taglio tradizionale. L’orlo della manica destra tradiva l’esistenza di un tatuaggio a forma di croce che si sviluppava sull’avambraccio.
Accadde tutto in un attimo. Il signor Miranda, terrorizzato, provò ad alzarsi, ma l’altro lo afferrò per il polso e lo costrinse a rimanere seduto. Con l’indice puntato, gli ringhiò contro un fiume di parole che, dalla sua posizione, Alberto non riuscì a comprendere pienamente. Poi, così com’era arrivato, Estanislau Ferreira se ne andò portandosi dietro una nuvola di fumo. Aveva detto quello che doveva dire. Alberto appoggiò frettolosamente i cocktail che aveva nelle mani per raggiungere il signor Miranda. Quello se ne stava rannicchiato in stato catatonico, come se un tornado lo avesse investito. Allora il ragazzo cercò di mettergli una mano sulla spalla per tranquillizzarlo, ma l’uomo, con un gesto insospettabile per la sua natura tranquilla, lo scansò violentemente e sfrecciò tra i tavolini del Caffè Funchal. Alberto non fece nemmeno in tempo a chiedergli se stesse bene, che già spariva per le strette vie della città vecchia.
Poi, con sua grande sorpresa, il ragazzo si accorse che il signor Miranda aveva dimenticato il suo manoscritto sul tavolo.
***
L’alba arrivò dalle colline, attraverso il letto del Duero, rivelando un cielo senza nuvole. Le case dei pescatori, le cantine e le guglie delle chiese si colorarono di mille tulipani. Era stata una lunga notte, e il signor Miranda era stanco. Nella sua mente non esistevano più piante di digitale, bottiglie di porto invecchiato, romanzi incompiuti, debiti di gioco o camerieri gentili. Dal mezzo del ponte Dom Luis I, tutto gli sembrava così piccolo.
Guardò il fiume per l’ultima volta, poi si lasciò cadere. E, proprio mentre il mondo scompariva attorno a lui, gli sembrò di scorgere l’anima d’acciaio dell’espresso delle sette e diciassette che, tremolante nella luce dell’alba, attraversava uno degli infiniti ponti della città senza fretta, come per dirgli addio.
Per una frazione di secondo temette che fosse tutto frutto della sua fantasia. Ma poi, si accorse che non aveva alcuna importanza. Sarebbe un finale magnifico, pensò.