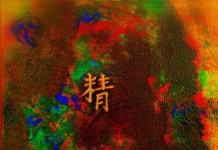Quella del duemiladieci fu l’ultima estate molisana trascorsa in vacanza con mio padre. Si partiva in furgone da Lecco, verso le tre del mattino dei primi giorni di esodo d’agosto, per cercare di evitare il traffico emiliano, che dallo svincolo tra la A1 e la A14 adriatica trasformava quasi di colpo l’asfalto e le corsie diventavano solo due. I Tir in sorpasso e gli imbecilli al volante puntualmente ci tenevano bloccati per ore su strade roventi senza aria condizionata, con mezzo pacchetto di Marlboro e una bottiglia da un litro e mezzo di acqua frizzante, bollente.
Settecentoventi chilometri di magliette appiccicate ai sedili, musica, finestrini abbassati e almeno quattro soste in Autogrill per raggiungere Guglionesi, l’amato paesino a pochi minuti dal poco mare molisano.
Per tutto il periodo delle vacanze, poi, le mie giornate le passavo così: col mio vecchio, in furgone, girando per le coste, le pinete sulla sabbia, i laghi in collina o i paesi più sperduti del Molise in cerca di mozzarelle di bufala e castelli medievali diroccati.
I cd erano sparsi dappertutto nell’abitacolo dello Scudo blu: su tutto il ripiano alto, ai lati sotto le maniglie, nel portaoggetti, sul sedile del “terzo” passeggero e sotto ai piedi. Raccolte, prime uscite da edicola, originali, tarocchi, in cartone, inserti di riviste.
C’era Black Market dei Weather Report. C’era The Dark side of the Moon dei Pink Floyd. C’erano Pino Daniele, gli Almamegretta, Joe Cocker, gli Xtc, i 24 Grana, Miles Davis e Frank Zappa. C’erano i Rolling Stones, e quell’album fenomenale, ascoltato in furgone in giro per il Molise. Era Let it bleed, la pronta risposta di Mick Jagger e compagni ai Beatles, nello stesso istante in cui questi uscivano con Let it be.
Quando papà raccontava qualche concerto vissuto nei primi anni Ottanta o qualche avventura in Westfalia (mitico e spartano caravan della sua epoca) in giro per l’Oriente, abbassava leggermente l’impianto ma lasciando sempre il giusto volume per poter ascoltare il racconto e nello stesso istante, guardando fuori dal finestrino, assopirsi tra la musica, le cicche e il paesaggio in continuo e perpetuo mutamento.
L’odore di sigarette mischiato a quello della pelle di papà era uno di quelli, pochi, che resteranno sempre dentro le mie narici come le rocce delle colline di Pietrabbondante, resistenti alle catastrofiche vibrazioni di quelle terre mosse dal loro stesso cuore.
C’erano anche lunghissimi momenti di silenzio, intervallati da qualche assurdo sogno utopico del mio vecchio, che si innamorava come un bambino di questa o quella cascina di campagna e bofonchiava qualcosa riguardo a come sarebbe stato bello restaurare una casetta con il pollaio, avere qualche pianta di ulivo, un bell’orto e una compagna con cui condividere silenziosi pomeriggi in amaca a leggere qualche libro, l’amore per la buona cucina e, perché no?, notti di passione con quel gentile contadino di città.
A me piaceva tantissimo ascoltare i suoi stravaganti pensieri. Mi trasmetteva tranquillità. Mi rilassava. Mi sballava. Mi sballava il suo modo repentino di passare da pensieri assurdi e cervellotici a futili banalità. Un minuto prima era lì che spiegava come e perché cambia la composizione della band di Frank Zappa nel tour italiano dell’82 e dieci minuti dopo si intestardiva nel cercare di capire come si pronunciasse e che cosa significasse letteralmente you can’t always get what you want. Era geniale e affascinate, decisamente atipica come figura paterna.
Ascoltavamo i Talking Heads e gli Stones se andavamo verso il mare. I King Krimson e i Traffic se volevamo perderci per le campagne. I Weather Report e il Jazz se andavamo per paesini dell’Alto Molise.
Lui mi faceva scoprire band praticamente ogni giorno. Rock, Progressive, Prog italiano, Scuola di San Francisco, Pop, Blues, Jazz. Era una fonte infinita di chicche musicali e aneddoti da intenditori, sempre condite con qualche mezza balla o esagerazione che si concedeva per dare un po’ di pepe al racconto.
Ma mentre si parlava e si fumava, intorno a noi il paesaggio era in continuo mutamento: passava dal colore giallo dei girasoli al verde degli ulivi, dal blu del mare al marrone e al rosso delle pietre delle case arroccate sui bassi e morbidi Appennini.
Ho sempre pensato che il Molise, nel suo essere piccolo e sconosciuto, avesse fondamentalmente tutto quello che volevo, quello che esigevo da un viaggio. Era il mio viaggio. Intimo. Confortevole. Pazzesco.
Osservavo tutto, e anche se una strada l’avevo già percorsa negli anni decine e decine di volte, non mi stancavo mai di farmi coinvolgere dall’immagine di un contadino che metteva benzina al trattore, da un gatto randagio maculato, rinsecchito e senza un occhio, dall’accento antico di una signora di Scapoli o di qualche paesiello che ci spiegava la strada per gli scavi di Sepino o semplicemente quella per tornare indietro. La cosa più bella era infatti la totale assenza di segnaletica. Niente. Nessun riferimento. Bivi, tratturi, strade cieche, sterrate, deserte. Campi, macchie e inversioni di marcia.
Un giorno ci fermammo nella piazza principale di Guardialfiera, paese che dà il nome anche a un bel lago artificiale formatosi dopo la costruzione di una gigantesca diga alla fine degli anni Sessanta. Il paese di Francesco Jovine, genio dimenticato che in Le terre del sacramento ha espresso storia, tradizioni, vita e tutto l’amore che anch’io provo per questa mia terra.
Accostammo davanti a uno dei tantissimi “Roxy bar” e chiedemmo a un vecchio dal baffo lungo e poco curato, pieno di rughe e con gli occhi neri e sottili, seduto su una piccola seggiola di legno alla sinistra dell’ingresso: “Scusi, la strada per Larino?”
E quello ci rispose: “P’lar’n?” Sguardo assorto rivolto alla discesa. “Va abbasc’, quand arrv all massaria d’Varzagl, a snstr!”
“Grazie, arrivederci!”
Papà ripartì, io tirai su un po’ il finestrino, ci guardammo e scoppiammo in una risata complice che durò minuti interi.
Noi avevamo compreso il criptico linguaggio, ma immaginammo entrambi lo sguardo perplesso e gli occhi sbarrati di un eventuale, raro qui, turista del nord.
Geniale.
Cosi, tra l’odore di barbabietola e le buche sull’asfalto mangiato dai trattori, tornammo verso casa. Semplicemente immersi, come carote tagliate sottili, dentro quel pinzimonio saporito, verde e speziato che da tempo è l’antica zona selvaggia del mio Molise.