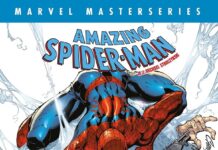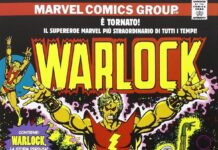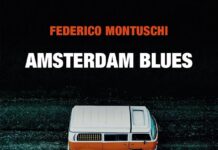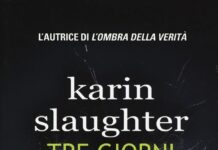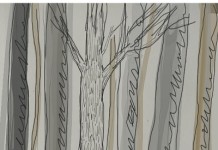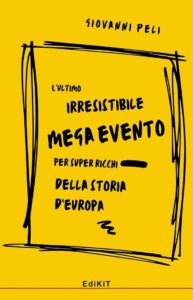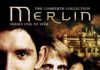In un futuro distopico, durante un colossale Mega Evento per super ricchi che trasforma l’Italia in un palcoscenico di lusso e delirio, le vite di artisti falliti, intellettuali caduti in disgrazia e rivoluzionari disperati si intrecciano in un mondo devastato dal degrado sociale e ambientale, in cui ogni speranza di redenzione sembra essere sepolta sotto una coltre di spettacolo mistificante.
L’ultimo romanzo breve di Giovanni Peli è una satira tagliente della società contemporanea, che porta all’estremo i paradossi del capitalismo e del culto per gli eventi spettacolari. Ambientato in un futuro distopico, intreccia storie di personaggi solo apparentemente scollegate, il cui legame è proprio il Mega Evento, simbolo dell’iper-commercializzazione culturale e della disuguaglianza sociale.
Peli adotta una narrazione frammentaria, con capitoli che oscillano tra visioni grottesche e descrizioni lucide di un mondo in pieno disfacimento. Le descrizioni sono ricche di dettagli macabri e surreali, riflesso inevitabile di una realtà esasperata che cerca vanamente di sopravvivere a se stessa. Infatti vengono messi in primo piano il divario crescente tra i super-ricchi e i poveri, la disumanizzazione provocata dall’ossessione per il progresso tecnologico e la spietata spettacolarizzazione del dolore umano. E anche l’ossessione per la trasformazione corporea, di derivazione ecologista, diventa metafora centrale, suggerendo da un lato l’adattamento forzato alle dinamiche sociali, dall’altro la perdita d’identità all’interno di un sistema che le fagocita e le annulla.
I protagonisti, pur rappresentando archetipi sociali, sono caratterizzati in una modalità caricaturale che ne amplifica la funzione satirica.
Peli denuncia apertamente l’ipocrisia delle politiche culturali e la complicità di istituzioni e media nella perpetuazione delle disuguaglianze anche in questo ambito. L’ambientazione in un futuro non lontanissimo gli permette di estremizzare i mali del presente, creando un effetto straniante ma incisivo. Un monito sulle derive della nostra società e un invito a riflettere anche sull’autenticità delle nostre esperienze culturali, nelle quali siamo condotti come pesci all’amo.
Non mancano i riferimenti a un tema caro all’autore, il cambiamento climatico (già trattato nel romanzo precedente, Veranio, 2023). Il futuro descritto mostra un mondo in cui l’ecosistema è stato profondamente alterato, non tanto da eventi climatici catastrofici espliciti, quanto dal risultato cumulativo delle attività umane, dall’urbanizzazione selvaggia allo sfruttamento sconsiderato delle risorse. Un mondo in cui fenomeni come frane, smottamenti, tsunami lacustri (come quello del Sebino) e condizioni meteorologiche estreme diventano quasi normalità. E la costruzione dei Grand Hotel per i super ricchi sulle sponde del lago d’Iseo rappresenta un esempio di sfruttamento capitalistico che ignora le esigenze dell’ecosistema locale, a sottolineare l’indifferenza delle élite verso le conseguenze ambientali, emblematico di un’umanità che privilegia il profitto immediato rispetto alla sostenibilità, com’è sotto gli occhi di tutti già ai giorni nostri.
Anche l’evacuazione forzata dei villaggi e la creazione di mega strutture (come le arene e i parcheggi) richiamano l’idea di una società che distrugge il territorio in nome di un sedicente progresso e dell’intrattenimento. Il cimitero park, in cui le tombe sono sostituite da parcheggi, è un’immagine fortemente simbolica del rapporto distorto tra uomo e natura. Al punto che il tema della trasformazione umana, cui abbiamo già accennato, prende forme assurde (come il cinghiale parlante e le persone che aspirano a diventare piante), parodia del tentativo umano di adattarsi a un ambiente ormai invivibile. In questo senso, Peli sembra ironizzare sull’idea di soluzioni estreme, tecnologiche o transumane, che spostano l’attenzione dal problema reale: il bisogno di proteggere il pianeta.
Peli non offre soluzioni, ma lascia trasparire una critica profonda a un sistema socio-economico che antepone il lusso e l’apparenza al benessere collettivo e ambientale. Il Mega Evento, con tutta la sua ostentazione e inutilità, si configura come una dimostrazione dell’incapacità umana di affrontare le vere emergenze, tra cui quella climatica.
C’è da dire che questo romanzo condivide alcuni elementi tematici e narrativi con il film Don’t Look Up, soprattutto per tono, critica sociale e stile tragicomico: le élite sono ritratte come ciniche e parassitarie, completamente disinteressate al bene comune¹.
Il Mega Evento rappresenta la celebrazione di un’umanità sull’orlo del collasso, che preferisce festeggiare piuttosto che affrontare il proprio destino, analogamente a quanto accadde durante alcune epidemie di peste nel Medioevo, in particolare durante la peste nera del XIV secolo (1347-1351), in cui molti preferirono abbandonarsi ai bagordi più sfrenati, convinte che di fronte alla fine imminente tanto valesse godersi fino in fondo il poco tempo rimasto. In molte città, addirittura, vennero organizzati banchetti pubblici, feste improvvisate e celebrazioni: in assenza di risposte razionali o scientifiche, molti preferirono vivere nell’immediatezza del piacere.
In definitiva, L’ultimo irresistibile mega evento per super ricchi della storia d’Europa è una satira acuta della società contemporanea, il cui tono grottesco riesce ad appassionare mentre ci fa riflettere su temi cruciali. Ogni personaggio rappresenta un aspetto della nostra società: dall’artista disilluso al rivoluzionario idealista, dal professore decaduto al cinico riccone in declino. La loro caratterizzazione li rende tutti memorabili e offre spunti di riflessione sull’identità e sul ruolo sociale di ognuno di noi, anche di chi alza le mani credendo di non essere responsabile di ciò che stiamo lasciando accadere.
Alle descrizioni iperrealistiche di scenari immaginari, in grado di creare un’atmosfera immersiva e di evocare emozioni forti, fa da controcanto una scrittura ricca di immagini evocative, giochi di parole e toni ironici. La capacità di alternare registri linguistici diversi, dal lirico al colloquiale, rende la lettura stimolante e mai monotona.
Una lettura pungente, che mescola abilmente umorismo, critica sociale e visioni distopiche con uno stile brillante e originale. Da leggere per ritrovare… noi stessi al nostro peggio.