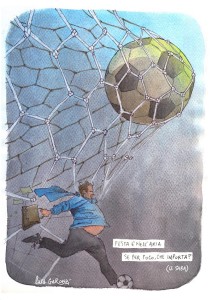
Come succede a tanti, neppure con Alessandro Cominardi, detto Alex, la vita era stata troppo benigna. Eppure, al pari di noi, anche Alex è un buon ragazzo. Un tipo a posto, per nulla stupido, ma forse un po’ inadeguato al tempo in cui vive. Dopo il liceo, e un impacciato tentativo all’università, il padre, che lo voleva sistemato a tutti i costi, l’aveva costretto a trovarsi in fretta un posto sicuro. Così, passati i trent’anni, quasi tutti i sogni della sua gioventù erano rapidamente naufragati nella noia di un lavoro monotono e pagato male.
Dal destino Alex ha ricevuto senza protestare, oltre a un temperamento timido e irresoluto, un piccolo impiego all’ufficio postale del Villaggio Ferrari, una moglie burbera e micragnosa – verso la quale ha la sventura di nutrire ancor oggi una sorta di affetto – e una cronica penuria di denaro. Un panorama desolante, è vero, un’arida landa nordica dove il sole, pur rimanendo a lungo nel cielo, è sempre malato, e troppo debole per poter riscaldare. Pure, Alex non se ne cura più di tanto. Trascina senza lamentarsi una vita incolore perché continua a coltivare l’unica sua vera passione, che tuttora lo possiede nello stesso modo in cui lo dominava da bambino: il tifo per il Brescia Calcio.
Non siate ingiusti con i tifosi di calcio, voi che avete studiato. Non disprezzateli, non condannateli senza remissione solo perché non ne comprendete gli atti. Io sono stato in mezzo a loro, e li ho conosciuti bene: fra tanti normali, ho trovato alcuni pazzi, qualche violento, uno o due invasati. Ma è l’amore che li fa parlare, vivere, e combattere. E non è l’amore una delle forze che reggono le sorti del mondo? L’amore è una cosa buona, convenitene: concedete dunque anche ai tifosi il diritto di sperimentarne la potenza.
Alex è innamorato del Brescia Calcio, e merita rispetto. Alex va al Rigamonti e, quando può, segue la squadra in trasferta. Alex legge le cronache sportive del lunedì sul Giornale di Brescia, soffre di vero dolore dopo le sconfitte e gioisce con misura nelle vittorie. In lui il tifo per la sua squadra ha assunto i contorni di una filosofia esistenziale: davvero si può dire che il Brescia sia la sua vita. Nel piccolo cabotaggio della squadra, nel suo vivacchiare blando e mai troppo fortunato lungo le stagioni, nel suo costante oscillare fra Serie A e Serie B, ad Alex sembra di riconoscere i segni delle sue proprie amarezze. Insomma, amando il Brescia, Alex rende un dubbioso e timido omaggio anche a se stesso. E sperimenta così un’affinità elettiva, una simbiosi che gli è indispensabile per tirare avanti nel deserto del mondo.
L’ha capito anche sua moglie Caterina, che per il resto lo tiranneggia senza pudore. Persino lei, che per tirchieria lo ha gradualmente spogliato di ogni piacere lecito e illecito, non si sognerebbe mai di impedirgli di spendere qualche soldo per seguire la sua squadra.
A misura che il loro matrimonio perdeva i contorni scintillanti degli inizi, Caterina aveva rivelato ad Alex la sua autentica natura: solo di rado gli venivano concessi senza protestare un film a noleggio e un libro, quasi mai un’uscita per una pizza e una birra e, solo in qualche momento fortunato, un po’ di gelido sesso coniugale, consumato fra lenzuola ghiacciate e strani grugniti che ad Alex parevano di scherno. Tutto Caterina gli aveva lesinato; tutto tranne il calcio: capiva infatti che, se non avesse agito così, la tranquilla disperazione di Alex sarebbe traboccata in lui fino a portarlo a morte sicura per consunzione. E, se ciò fosse accaduto, a lei, che era sempre disoccupata, non sarebbe più toccato neppure un centesimo dello stipendio portato a casa ogni mese dal marito.
Dopo anni di trasferte al seguito del Brescia in molti stadi d’Italia, Alex ha accumulato un bagaglio di avventure che di rado racconta ai veri amici, ai quali io, Riccardo Belleri, mi onoro di appartenere. Se ci troviamo a casa sua, con Caterina nei pressi ad ascoltare accigliata mentre finge di lavare i piatti, Alex tiene la voce bassa, non mostra entusiasmo e taglia corto. Se lei non c’è, o è lontana, Alex si trasfigura: alza e colorisce i toni, accelera il ritmo delle parole, scodella immagini una sull’altra. Scordata ogni timidezza, procede con torrenziale affabulazione, affastellando in un blocco unico luoghi, persone e ricordi. A poco a poco i suoi racconti diventano bulimici e lievemente sgrammaticati, ma si colmano di un fascino irresistibile. Quando narra in quel modo Alex davvero rivive nella sua squadra: e attraverso le gesta del Brescia si libera dall’inquietudine e dà un senso al suo quotidiano patire.
Qualche tempo fa ci ha raccontato la sua avventura più bella: una trasferta a Trieste nei primi anni Novanta, per un Brescia-Lazio. Cercherò di rendervi parte della vicenda, conscio di non poter riprodurre se non in modo imperfetto la voce narrante del mio amico. Pure, ancora una volta, vi invito a sgombrare l’animo da ogni pregiudizio, e ad ascoltare la storia di Alex:
«…e quella volta che siamo andati a Trieste a vedere Brescia-Lazio? Non ricordo bene che cosa era successo, forse qualche casino fuori dal Riga con quelli dell’Atalanta. Sta di fatto che ci avevano squalificato il campo, e voi sapete quanto è importante giocare con il sostegno dei tifosi quando si lotta per rimanere in Serie A. Per questo dovevamo andare.
Quella domenica tu non c’eri, Riccardo: eri via per lavoro, credo, e questa storia non l’hai mai sentita. Eravamo andati io, Alberto che aveva appena rotto con Carla, l’Investigatore e Barollo.
“Barollo? Ma Barollo chi?”, direte voi. “Quel Barollo? Quello che giocava nel Brescia?”.
No, non Barollo il calciatore. Il nostro Barollo faceva il barman. Adesso non viene più allo stadio, ma chi l’ha visto una volta non se lo può dimenticare: era proprio un tipaccio, lui, e al vero Barollo non assomigliava per niente. Era tanto grasso e incazzoso quanto il calciatore era filiforme e compassato. Aveva cominciato a giocare con noi a calcetto dal mese di novembre dell’anno prima, e proprio in quello stesso novembre il Brescia aveva acquistato Barollo. Per questo motivo avevamo cominciato a chiamare anche lui Barollo, solo con il cognome, anche se si chiamava Franco. Come il calciatore anche il nostro amico era un acquisto novembrino, uno da mercato di riparazione, per intenderci. Uno da sfruttare per mezza stagione e di cui poi liberarsi in fretta. Ma passavano i mesi e il nostro Barollo continuava a giocare a calcetto con noi, senza mai saltare una partita. Proprio come il Barollo calciatore faceva con il Brescia. Insomma, nessuno li voleva, e i due Barollo restavano sempre lì.
Vi ho detto che Barollo faceva il barman all’Hotel Ambasciatori, e ci raccontava di incontrare spesso il Gino, il nostro pres; e ogni volta tentava di chiedergli notizie sulla campagna acquisti. Ma il Gino, zitto e sfuggente, beveva il suo cocktail in silenzio, e non gli diceva mai niente, anzi neppure lo guardava. E allora Barollo si incazzava sempre di più al mutismo del Gino, ma non poteva certo colpirlo con il tritaghiaccio, o almeno innaffiarlo con il seltz, come avrebbe voluto, perché il Gino era il presidente della squadra, e il presidente della squadra è sacro.
L’Investigatore invece era proprio uno che lo faceva di professione, il poliziotto privato. Sembrava Clint Eastwood nell’ispettore Callaghan. Il fisico ce l’aveva, non c’è che dire. Spalle larghe, figura atletica, capelli castani con frangia e pizzetto. E poi come se la tirava da agente segreto con i Ray-Ban neri anche di notte come i Blues Brothers! E faceva sempre un sacco di domande:
“Che lavoro fai? Dove abiti? Conosci questo? Conosci quello?”
Mamma mia! Che strazio! Ma lui non smetteva. Finché:
“Basta! Basta! Basta!”, pensavi. “Ma questo chi me l’ha mandato? Non lo reggo più!”.
E poi anche l’Investigatore, come Barollo, diceva di conoscere il Gino, anzi si sussurrava che lavorasse per lui.
“Ma insomma!”, a volte ci chiedevamo io e Alberto: “È mai possibile che questo pres lo conoscono proprio tutti tranne noi due, poveri gonzi?”.
«…e pensare che la partenza non era neanche troppo sicura, quella domenica. Si va o non si va a Trieste? Nel dubbio, Caterina mi aveva rotto le scatole per tutta la mattina: “A Trieste? Da Brescia? Ma sei matto? Non vorrai mica andare anche tu?”, diceva. “Non sai quanto ti costa? E sei poi sicuro che quei tuoi amici ti pagheranno la benzina?”.
In realtà non sapevo nemmeno con quale macchina saremmo partiti. Io dovevo semplicemente vedermi alle dieci con Alberto e l’Investigatore, e andare con loro da Barollo per capire che cosa si voleva fare. Ma quando siamo arrivati a Chiesanuova sotto casa di Barollo ci siamo subito accorti che non era aria. Sì, perché Barollo, sciarpato di biancoblù, più che biancoblù era blucerchiato come un doriano: nel senso che oltre che bianco e blu come il Brescia era anche nero di rabbia e rosso come un pomodoro. Quasi senza fiato inveiva in modo volgarissimo, rintronando tutta la via – e già le persone si affacciavano perplesse alle finestre – contro un certo Gigio, noto solo a lui, che quella domenica avrebbe dovuto mettere la macchina per il viaggio, e invece aveva dato buca misteriosamente, lasciando tutti a piedi: “Quel bastardo di un Gigio! Quel figlio di puttana! Quell’infame, bastardo, cornuto di merda!”, urlava. “E adesso come facciamo ad andare a Trieste?”.
Poi, appena mi ha visto arrivare, fremendo di rabbia e fulminandomi con uno sguardo omicida:
“Tu hai qua la macchina, vero?”, mi ha detto tipo Gestapo.
“S-sì…”, ho biascicato io.
“Bene! Allora vieni anche tu”, ha intimato. “Io ho qui una gradinata in più. Tu ci porti a Trieste, e ti vedi il Brescia gratis! Va bene?”.
Voi sapete com’è difficile inventare una scusa plausibile davanti a una tonnellata torreggiante di lardo e gelatina, tremolante e nervosa come Barollo. C’è poco da fare di fronte a quegli occhi da pazzo. Così, anche se dentro di me cominciavo già a pensare a che cosa avrebbe detto al ritorno Caterina, gli ho risposto:
“Va bene”.
E poi chissenefrega! Avevo appena fatto il pieno al self-service, e il Brescia lo volevo vedere davvero. Certo che vengo. Tutta la vita ci vengo, a Trieste! Per farla breve, partimmo con la mia Renault Clio verde, che Dio l’abbia in gloria.
Io ero alla guida. Al mio fianco, nel posto del passeggero, si è sistemato l’Investigatore, che da dietro i Ray-Ban aveva come al solito iniziato ad indagarci tutti:
“Chi sei? Dove lavori? Come vivi? Quanto guadagni?”.
Aiuto! Lui queste domande poteva farle liberamente, ma sapevamo tutti che, se gliele avessimo rivolte noi, l’Investigatore avrebbe risposto a fatica, e sempre con molta circospezione.
Dietro di me c’era Alberto, perso nei suoi pensieri, e accanto a lui Barollo, un po’ meno agitato di prima, ma sempre in fase eruttiva. Barollo che, appena salito in macchina, aveva disteso sul lunotto posteriore la sua sciarpa biancoblù con la V bianca. A ogni sorpasso in autostrada, ci aveva detto, tutti dovevano vedere qual era la nostra squadra!
«…e dopo trecento chilometri di Clio siamo arrivati a Trieste. Al casello polizia armata fino ai denti, in assetto anti-sommossa, con cani ferocissimi e latranti. Ci hanno scrutato a lungo da sotto i loro caschi blu, ma non hanno detto nulla né a me né ad Alberto, perché per l’occasione avevamo sfoderato le nostre facce da bravi ragazzi; né all’Investigatore, evidentemente per solidarietà professionale fra le forze dell’ordine; né a Barollo che, da sveglio, aveva normalmente un ghigno tipo Jack Nicholson in Shining nella scena della scure, ma che in quel momento, per nostra fortuna, dormiva come un angioletto, se così si può dire.
Era troppo presto per il fischio d’inizio. Io e Alberto pensavamo di fare un giro nel centro della città, mentre Barollo e l’Investigatore cercavano un bar. Così, quando loro, una volta seduti, hanno ordinato tramezzini e birre, iniziando subito a sfogare la tensione pre-partita a rutti, noi due, cui quello spettacolo aveva tolto ogni appetito, siamo andati a fare due passi.
Bella Trieste. Piazza Unità d’Italia, i palazzi asburgici, il teatro romano, una chiesa ortodossa dalle cupole celesti. Io e Alberto snocciolavamo l’uno all’altro gli scarsi ricordi scolastici: il molo Audace, Umberto Saba e le poesie sul calcio, Italo Svevo e James Joyce che gli dava lezioni di inglese. E intanto l’Adriatico azzurro tremolava davanti a noi nel sole del primo pomeriggio. Domenica sonnacchiosa di fine primavera. Caldo. Nessuno in giro.
“Con un tempo così”, ci siamo detti, “Sai che cosa gliene frega ai triestini di vedere la partita. Saranno tutti al mare. Per fortuna sembra che saremo in ottomila bresciani allo stadio”.
All’improvviso abbiamo avvistato un gruppo di maglie biancazzurre venire verso di noi. I laziali! Che strizza conigliesca! Poi, più da vicino, abbiamo capito che era gente tranquilla come noi: due o tre quarantenni e un paio di coppie; insomma, tifosi all’amatriciana. Quando poi ci siamo incrociati abbiamo finto durezza e disprezzo reciproci, ma si capiva che era solo un gioco. Sotto sotto eravamo tutti contenti.
Intanto era quasi l’ora:
“Forza, ragazzi!”, abbiamo detto, ritornando al bar, agli altri due semiaddormentati al tavolino: “Andiamo allo stadio”.
«…appena lo abbiamo visto siamo rimasti tutti e quattro a bocca aperta:
“Ragazzi! Che stadio il Nereo Rocco. Che stadio! A Brescia uno stadio così chissà quando ce lo faranno!”.
Lo abbiamo scorto quasi d’improvviso nella lontananza e, appena scesi dalla Clio, come ipnotizzati, abbiamo iniziato a correre verso di lui. Da un lato l’antico, mitico stadio Grezar rosso-alabardato, dall’altro, incredibile a dirsi, la Risiera di San Sabba, il museo memoriale del lager nazista. E in mezzo lui, il Nereo Rocco, che ci attendeva oltre il piazzale.
“Che stadio, ragazzi! Che stadio!”, ci siamo ripetuti.
Da quel momento siamo caduti in trance agonistica. Ognuno di noi ha cominciato confusamente a intuire che dentro di lui si stava replicando la metamorfosi del tifoso, e che per le successive due ore non ci sarebbero stati più né Alex né Alberto né Barollo né l’Investigatore, con le loro storie individuali e le miserie quotidiane, ma solo quattro degli ottomila magici compatti tifosi bresciani in trasferta a Trieste. E allora forza magico Brescia! A tutto il resto penseremo domani!
Abbiamo fatto il piazzale di corsa, fendendo la folla. Abbiamo scavalcato i gruppetti degli altri tifosi che oziavano nei pressi dei cancelli. Abbiamo rallentato, prima al passo, poi quasi fermi, infine incanalati in lunga fila. Abbiamo mostrato i nostri biglietti agli inservienti, e ci siamo lasciati perquisire, immobili e silenziosi, dagli enormi poliziotti in casco blu e mimetica. Abbiamo dato un’ultima occhiata nervosa ai pastori tedeschi al guinzaglio dei carabinieri al cancello, e poi dentro!
E di nuovo di corsa verso le scale esterne, mentre iniziavamo a percepire gli odori e i rumori consueti che salivano dal parterre. Rapidi ci siamo inerpicati lungo le rampe verso i varchi della gradinata, mentre sotto di noi la marea biancoblù – sciarpe bandiere stendardi grida biancoblù – lentamente fluiva, e cresceva, e spumeggiava, e si gonfiava insieme a noi. Ci siamo infilati nel tunnel d’accesso con gli occhi improvvisamente ciechi, e ancora abbiamo corso nella penombra colma di figure sudate. In quel preciso momento abbiamo udito distintamente l’urlo della folla, che rombava sempre più forte. E infine, con uno scatto, abbiamo divorato gli ultimi metri di oscurità, e dinanzi a noi è apparso il buco bianco dell’accesso al campo.
Quando siamo riemersi nella gloria abbagliante del sole triestino, per un istante abbiamo chiuso gli occhi, accecati dalla luce. Poi li abbiamo riaperti di colpo e, guardandoci intorno, ci siamo urlati per la terza volta:
“Che stadio il Nereo Rocco! Ragazzi, che stadio! Altro che il Riga!”.
Già era bello fuori, e dentro ancor di più! Non aveva la pista d’atletica, e gli spalti erano altissimi, stracolmi e rimbombanti di tifo. Vista da Dio sul terreno di gioco. E ancora una volta eravamo felici come in un sogno. Perché stavamo per vedere il nostro Brescia, e davanti a noi si ripeteva il fantastico spettacolo di sempre, che chi non l’ha visto non lo potrà mai capire: folla nera, prato verde, cielo blu!
«…come suol dirsi, non ci fu partita. Troppo bella la stagione, troppo grande l’entusiasmo, troppo determinati i ragazzi, troppa la fame di punti. Neppure il Brasile avrebbe retto quel giorno a Trieste. E tanto meno la Lazio, timida e svogliata, che manco giocava con la divisa biancazzurra, ma con una maglia giallo canarino. La Lazio che ci affrontava con la classica malavoglia di fine campionato, tipica delle squadre italiane già appagate, pronta a concederci la vittoria senza lottare. Solo la zazzera bionda di Beppe Signori di tanto in tanto balenava sul campo, ma i nostri difensori lo fermavano sempre senza fargli quasi toccar palla, e ripartivano in bello stile come Franz Beckenbauer. Mentre gli altri avversari, a ogni tackle perso, sembravano dire ai nostri:
“Ma prego, cari signori, si accomodino! La palla è a loro disposizione. La giochino come meglio credono. E rammentino che oggi stiamo concedendo loro di andare in porta senza contrastarli perché, se l’anno prossimo avessimo magari bisogno di un aiuto, immaginiamo di poter contare anche sulla loro riconoscenza”.
Calcisticamente ci davano del lei, i laziali. Il massimo del rispetto! E pensare che non avevamo neppu
e bisogno di favori, tanto eravamo forti. Sì! Tutti campioni del mondo i biancoblù quel giorno allo stadio Nereo Rocco di Trieste, davanti a ottomila bresciani festanti e orgogliosi. Raramente si era visto un legame così saldo fra i tifosi e la squadra di Mircea Lucescu. Che si dava un po’ troppe arie da grande esperto, lui che quando allenava la nazionale rumena era stato il primo C.T. di quel paese a battere l’Italia a Bucarest. E veramente le sparava grosse quando doveva giustificare se stesso e le brutte prestazioni del Brescia. Te lo ricordi, Riccardo? I giornalisti gli chiedevano:
“Mister, che cosa è stato? Perché questa sconfitta? A cosa attribuisce una prestazione così sotto tono?”.
E Mircea Lucescu rispondeva:
“L’arbitro non era in giornata”.
Oppure:
“Oggi gli infortuni ci hanno penalizzato”.
E anche:
“Ha piovuto tutta la settimana, e il campo pesante ha messo in difficoltà la nostra squadra, che non ha potuto mettere in campo la sua tecnica”.
E persino:
“Il Palazzo non ci ama”.
Ma quale Palazzo! Mai che si prendesse lui la colpa. Ci mancava poco che accusasse delle nostre sconfitte i raccattapalle avversari. Però era un grande tecnico, nei momenti migliori venerato a Brescia quasi fosse San Faustino, il patrono della città.
«…e poi quel giorno il pubblico acclamava tutti. Persino lo sciagurato Nello Cusin in porta. E c’erano in difesa i giovani Paolo Negro e Massimo Paganin, e Marco Rossi brontolone, e Stefano “Bistecca” Bonometti libero. E a centrocampo l’espertissimo Luciano De Paola, che neppure adesso, quando commenta le partite su Teletutto, ha fatto pace con l’italiano, ma che tatticamente parlava la lingua degli angeli; e Marco Schenardi in fascia destra non ancora vicentino; e il magnifico Sergio Domini.
E infine il trio rumeno: il primo, all’ala destra, era Ioan Ovidiu Sabau, l’Uomo Bionico, con lo striscione biancoblù dei Sabautati che lo seguiva ovunque. Ci mettemmo poco ad accorgerci che era arrivato anche lì, al Nereo Rocco. Quello striscione incomprensibile davvero ci perseguitava, davvero ci faceva andare fuori di testa! Ogni volta che lo leggevamo non riuscivamo mai a capire che cosa volesse dire:
“E chi cazzo saranno mai questi Sabautati?”
Ma proprio in quel magnifico pomeriggio triestino io, Alex Cominardi, per primo fra tutti i tifosi, ho avuto l’ispirazione di leggere Sabautati pronunciando Sabò, alla francese, invece di Sabau, e improvvisamente tutto si è chiarito:
“Ragazzi!”, ho detto agli altri sorridendo, e indicando lo striscione: “Sapete chi sono i Sabautati? Sono i Sabotati! I Sabotati da Sabau!”.
E loro giù pacche sulle spalle e una marea di complimenti! Persino Alberto, nonostante Carla se ne stesse andando di casa, sembrava felice. Mi ha detto:
“Grande! Grande Alex! Non c’è storia con te! Sei davvero il più intelligente. I Sabotati! Geniale! Io non ci sarei mai arrivato”.
È bastato questo per capire che quel giorno ogni cosa stava trovando improvvisamente un senso, come nel migliore dei mondi possibili.
«…anche per il nostro centravanti, il secondo fra i rumeni, il buon Florin Raducioiu, gli applausi si sprecavano a Trieste. Mai così in palla come in quella stagione: alla fine fece tredici gol, che in Serie A non è niente male. Impensabile, a giudicare dalle sue precedenti uscite nel nostro calcio: prima con la Romania a Italia 90, quando si vedeva lontano un chilometro che s’impegnava come un matto non per la sua nazionale, ma per essere acquistato da una squadra occidentale, guadagnare finalmente un sacco di soldi, e lasciarsi alle spalle il socialismo reale. Poi con il Bari, quando non ne beccava una. E infine con il Verona, quando dribblava mezza difesa avversaria a velocità supersonica e alla fine, giunto solissimo a un metro dalla porta, che gli sarebbe bastato un tocco per segnare, era talmente rintronato dalla sua stessa frenesia che nove su dieci la sparava fuori, e tutta l’Italia rideva di lui!
E infine c’era il terzo rumeno, il migliore di tutti: il fantasista Gheorghe Gica Hagi, uno dei più forti giocatori mai visti a Brescia – quando ne aveva voglia – uno cui la Curva Nord del Riga cantava la canzone di Ufo Robot urlando all’unisono alla fine del ritornello le parole: “Hagi gol! Haaagi goool!”, ottenendo un effetto-eco davvero impressionante. Gica il virtuoso, Gica il Maradona dei Carpazi, della stessa schiatta degli immensi, insieme ai veterani della Leonessa Egidio Salvi e Gigi De Paoli, e persino al divino Roberto Baggio! Gica Hagi che aveva anche lui un gruppo di fedelissimi filo-rumeni al suo seguito con lo striscione degli Hagitati, che è come dire gli Agitati, e in questo caso si capiva subito che cosa voleva dire perché non c’erano difficoltà di pronuncia.
«…e sono stati proprio i rumeni a sbloccarla: dopo un primo tempo di studio è partito sulla destra l’Uomo Bionico, il preferito da Barollo, vincendo prima un contrasto, poi dribblando un paio di laziali condiscendenti. Giunto al limite dell’area, ha sparato in porta una mina in diagonale che è entrata piegando le mani al timido Fernando Orsi, la riserva di Luca Marchegiani – pensa un po’ questa Lazio che, casualmente, non aveva schierato neppure il portiere titolare. Per l’eccitazione del gol il rude Barollo è saltato in aria, precipitandosi poi giù per le scalette della gradinata – sembrava un incrocio fra un budinone bianco e un bisonte alla carica. In mano aveva la sua radiolina di bachelite nera da cui allo stadio non si separava mai, e occasionalmente ascoltava o, più spesso, agitava minacciosamente contro gli arbitri. Giunto di sotto, rimbalzando qua e là a rischio di caduta, si è infine appeso all’inferriata che delimitava il campo urlando con voce strozzata un suo artigianale peana all’indirizzo di Ioan Ovidiu Sabau, detto Nellu. E, a dire il vero, neppure noi altri tre siamo stati fermi – no! no! no! – anzi ci siamo precipitati festanti dietro a Barollo, ululando come selvaggi, ed evidentemente destando il sospetto in un drappello di carabinieri. I quali, guidati dal loro brigadiere, da quel momento in poi si sono appostati vicinissimi a noi, e occhiuti e grintosi ci hanno osservato di sottecchi per il resto della partita, neanche fossimo terroristi in vena di attentati.
Poi dopo altri venti minuti del secondo tempo un’altra grandissima azione dei ragazzi sotto la nostra curva ha chiuso la partita. È scattato Marco Rossi sulla sinistra, è andato sul fondo e ha crossato a centro-area, tesissimo. Raducioiu è partito verso il primo palo portando via il suo marcatore, e nello spazio che si è aperto davanti alla porta si è inserito libero Hagi che di fronte piena ha fatto il 2-0! Mamma mia! Che gol! Il Nereo Rocco è esploso come un vulcano! E noi, come quattro fratelli, ancora abbiamo esultato da matti, mentre io, potenza misteriosa del tifo, mi sono trovato ad abbracciare per la gioia l’Investigatore, quello stesso strano insidioso tipo che con i suoi bizzarri comportamenti mi aveva rovinato il viaggio di andata.
«…ma, come nei vecchi film usavano mormorarsi gli amanti al momento dell’addio:
“La nostra storia era troppo bella per durare. Ed è finita”.
Noi questo non ce lo siamo detto, però sapevamo che sì, era davvero finita. L’arbitro aveva appena emesso il triplice fischio quando il sole di Trieste ha iniziato a declinare. E con lui tramontava la nostra breve solidarietà: insomma, ritornavamo quattro individui separati e distanti, i soliti di ogni giorno. Poco dopo, chiusi dentro la Clio, incolonnati nella lunga fila di auto bresciane che lasciavano il Nereo Rocco, ci siamo apprestati al viaggio di ritorno.
Ma, contrariamente a quanto pensavamo, il giorno era stato troppo grande per terminare così: qualcosa doveva ancora accadere. Dopo qualche chilometro di autostrada ci siamo fermati a una stazione di servizio per fare benzina. Siamo scesi dall’auto, ancora lievemente stralunati, e d’improvviso ci siamo trovati immersi in quella luce aranciata che è preludio alle apparizioni portentose.
“Strano”, ha detto Alberto: “In questa stazione di servizio non c’è nemmeno un tifoso”.
Ed era proprio così. Non si mostrava neppure il benzinaio. O, se c’era, a noi sembrava un’ombra: e poi neppure un’auto bresciana di tutta quella colonna si era fermata. Eravamo soli? No. D’improvviso una Mercedes nera metallizzata si è accostata alla pompa di benzina dietro alla nostra, e ne è sceso un ometto in giacca e cravatta: era tarchiato, grinzoso e portava occhiali d’oro. Un po’ stempiato, aveva però i capelli lunghi sulla nuca, tinti di fresco di un biondo falso, quasi color del miele. L’ometto ci ha fissato un momento con bruni occhi dardeggianti e poi, da dietro le lenti, diffidente, ci ha domandato quasi controvoglia:
“Allora, ragazzi, vi è piaciuta la partita?”.
Barollo e l’Investigatore hanno avuto un fremito.
“È il Gino!”, hanno sussurrato, e nel silenzio magico della sera si sono avvicinati a lui. Io e Alberto, più incerti, non ci siamo mossi di un passo. Finalmente lo incontravamo anche noi, il pres! Lo avevamo visto tante volte in fotografia, ma mai di persona. Noi e il Gino! Che strano incontro: era come se una divinità fosse discesa sulla terra per mostrarsi ai mortali. Lo guardavamo ed eravamo felici ma, inspiegabilmente, anche un po’ delusi.
Intanto Barollo non riusciva più a controllarsi. L’emozione, ravvivata dall’incontro inaspettato, lo faceva crepitare come una mitraglia:
“Bellissima vittoria, Gino! Sicuramente ci salviamo, eh? E adesso che cosa farai? Ci porterai in Europa? Chi comprerai? E chi darai via? Dài, Gino, ti prego: dacci qualche novità!”.
Cinque domande e due esclamazioni aveva messo in fila. Troppe per chiunque. Figuriamoci per il Gino. Si vedeva che il nostro pres era infastidito dalla curiosità di Barollo, che per giunta aveva commesso l’errore di chiamarlo per nome e di dargli del tu. Lo ha guardato torvo senza rispondergli e poi, rivolgendosi all’Investigatore, gli ha detto irosamente:
“Ah, c’è anche lei qui? Venga un attimino, per favore!”.
L’Investigatore è scattato come una molla, e i due, parlando fitto, si sono allontanati di qualche metro, il Gino imperioso e l’Investigatore, che lo sovrastava di una testa, in atteggiamento ossequiente. Sono stati lì dieci minuti buoni. Io, Alberto e Barollo, osservandoli, di tanto in tanto ci dicevamo:
“Ma come sarebbe? Allora è vero che l’Investigatore lo conosce! Allora è vero che lavora per lui! Ma che cosa sarà? Spionaggio industriale? Illecito sportivo? Tradimenti extraconiugali?”.
Finito di parlare, il Gino ha riaccompagnato verso di noi l’Investigatore. Sembrava rasserenato, e ci ha sorriso – la pelle incartapecorita gli si tendeva in piccole rughe intorno agli occhi. Poi è salito sulla sua Mercedes e, prima di ripartire, ci ha richiamati vicino a sé con un cenno dal finestrino. Infine, passando ad Alberto il suo biglietto da visita, ha detto:
“Grazie per essere venuti fino a Trieste, ragazzi. Telefonate martedì in sede a questo numero e chiedete a chi vi risponderà di farvi avere il regalo che preparerò per voi”.
E se ne è andato rombando.
Due giorni dopo, di prima mattina, ho telefonato io in via Bazoli per prendere appuntamento. Sono arrivato là alle quattro, e ho incontrato una ragazza meravigliosa che, però, non mi ha mai sorriso. Ma, non appena le ho nominato il Gino, mi ha consegnato una busta con la Leonessa stampata sopra. Dentro alla busta ho trovato quattro biglietti di tribuna per la trasferta della domenica successiva: Milan-Brescia a San Siro!
Incredibile ma vero: anche il Gino era stato buono con noi!
Per il resto del viaggio di ritorno abbiamo tempestato l’Investigatore di domande per sapere che cosa avesse veramente a che fare con il Gino. Ma credimi, Riccardo: è stato tutto inutile! Niente da fare: non ci ha detto nemmeno una parola.
«…e dopo altri trecento chilometri stavo per pagare il pedaggio a Brescia Centro. Anche qui era pieno di polizia che studiava ogni nostra mossa. A un tratto, mentre estraevo il portafoglio, un brivido mi ha scosso, gelandomi la schiena. I ragazzi l’hanno notato, ma io ho dato i soldi al casellante facendo finta di nulla. Più tardi, alla pizzeria dei Sorrentino, davanti a una margherita, ho svelato loro la ragione del mio spavento:
“Sapete una cosa? Prima al casello mi sono accorto di aver dimenticato a casa i documenti, la patente e tutto il resto. Non ho con me neppure la carta d’identità. Niente di niente! Forse li ho lasciati a casa perché ero distratto, o forse perché non ero poi tanto sicuro di fare un viaggio così, oggi. Ma ci pensate? Con tutta quella polizia a Trieste, se mi avessero chiesto i documenti sarei stato certamente trattenuto là. E probabilmente anche per voi niente partita. E poi come facevamo a ritornare a Brescia? E invece eccoci qui. Davvero è stata una bella fortuna…”.
“Dì pure che è stata una gran botta di culo”, ha sentenziato Barollo da par suo, con la bocca piena di bruschetta.
Da dietro i suoi Ray-Ban, l’Investigatore si è limitato a sogghignare, bevendo la sua birra senza dir nulla.
Solo più tardi, mentre lo stavo lasciando per tornare a casa, è stato Alberto, nonostante i suoi problemi con Carla, a trovare con serenità le parole giuste:
“Non è stata solo fortuna, Alex. La realtà è che oggi è stata una giornata perfetta”».
Il commento di Alberto non poteva essere migliore: una giornata perfetta, la loro, non perché più esaltante di ogni altra trasferta, o più grande di ogni altra vittoria del Brescia. Ma perché Alex e i suoi tre amici avevano sentito che la vita, in quel breve arco di tempo, li aveva trattati bene, senza neppure uno di quegli scherzi che è solita giocare.
Pensateci, voi che avete studiato, e provate a trarre dalla loro storia una morale più profonda di quella di Alberto. Vi sfido a farlo, ma non credo che possiate arrivarci. Forse perché a voi – e anche a me che ho studiato come voi – le cose semplici e belle hanno smesso di stupire.
O forse perché, se pure ci capita ancora di incontrarle, siamo ormai tanto ciechi da non riconoscerle più.
Fine
























