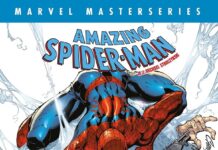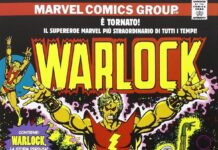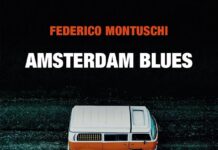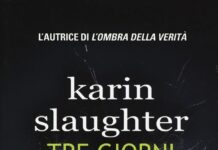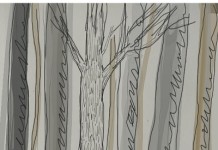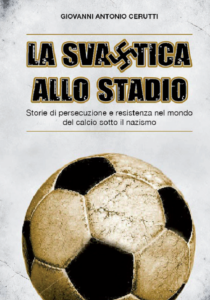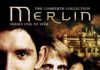Calcio, letteratura & politica
Faccio una doverosa premessa: il calcio non mi piace, o meglio, non mi piace più, a lungo andare mi annoia. Alla formulazione di questo giudizio credo però concorra in maniera determinante la mia profonda avversione per tutto ciò che gravita attorno al gioco giocato: le immorali milionate di euro di ingaggio e gli spropositati valori dei cartellini, la tifoseria organizzata, spesso violenta e incontrollata, i club che altro non sono che macchine per fare soldi, i diritti TV, la sovresposizione mediatica, le mille trasmissioni nelle quali non si parla d’altro che di aria fritta, i ragazzoni viziati e osannati come nuovi dei, le immancabili veline di contorno, la società stessa che mantiene in piedi l’intero baraccone mentre intorno tutto affonda.
Come ho già avuto modo di dire, mettendo le parole in bocca al personaggio di un mio racconto, io ho deliberatamente preferito al rotolare tondo e preciso di un pallone da calcio, il rimbalzare sghembo e imprevedibile della palla ovale.
Ben altra cosa, invece, è la narrazione che del gioco del calcio è stata fatta. Ricordo di aver letto con avidità, ad esempio, Pensare con i piedi di Osvaldo Soriano, autore a me particolarmente caro, raccolta che contiene il racconto Il rigore più lungo del mondo, considerato da molti il più bello mai scritto sul mondo del calcio.
Ma il football è entrato spesso nelle mie letture, con nomi noti (Gianni Brera, Luciano Bianciardi, Beppe Viola, Darwin Pastorin, Manuel Vazquez Montalban) e libri meno conosciuti come La prima volta di Franco Bernini, ambientato a Torino l’8 maggio 1898, data d’inizio del primo campionato italiano, proprio mentre a Milano le cannonate di Bava Beccaris fanno strage tra la gente che protesta per l’insostenibile aumento del prezzo del pane, o come Rosa di fuoco di Emilio Marrese, romanzo che narra le vicende della squadra del Barcellona in trasferta in Messico – per salvare i giocatori dal fronte e il club dalla bancarotta – nel 1937, mentre la città resiste all’avanzata dei fascisti durante la drammatica Guerra Civile spagnola. Interessante anche Calciatori di sinistra (sono un po’ di parte, lo so) di Quique Peinado, nel quale si raccontano le vicende sportive e umane di onesti gregari e grandi campioni del passato: Paolo Sollier, pugno chiuso al cielo e un abbonamento al Quotidiano dei Lavoratori – organo del movimento di estrema sinistra Avanguardia Operaia – per ogni gol segnato, Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, meglio noto semplicemente come Socrates, capitano della nazionale brasiliana e artefice della cosiddetta democrazia corinthiana, una sorta di autogestione dello spogliatoio attuata durante gli anni della sua militanza nel Corinthias, Cristiano Lucarelli, attaccante livornese che coerentemente rinunciò a ingaggi da nababbo per vestire la maglia della sua città, e tanti altri calciatori magari sconosciuti da noi (assenza ingiustificata, nel libro, quella di Paul Breitner, centrocampista della nazionale tedesca degli anni 70/80, noto, oltre che per le sue capacità pedatorie, per aver posato in una foto sventolando il Libretto Rosso di Mao-Tze-Tung).
Ma tra i tanti libri che mi sono capitati tra le mani ce n’è uno in particolare di cui vorrei parlare in questa sede. Pubblicato nel novembre 2014 da Editrice A, La svastica allo stadio di Giovanni A. Cerutti è una raccolta di quattro scritti presentati precedentemente su A-Rivista anarchica, nella quale si narrano le vicende, non solo sportive, della squadra olandese dell’Ajax, in qualche modo espressione della comunità ebraica cittadina e legata alla resistenza antinazista dopo il maggio 1940, e di tre grandi personaggi del passato – un calciatore e due allenatori – perseguitati per la loro opposizione al nazismo o per le loro origini ebraiche.
Nel primo capitolo I piedi di Mozart il protagonista della storia è Matthias Sindelar, uno dei più forti centravanti di tutti i tempi, a detta non del sottoscritto ma degli addetti ai lavori. Sindelar, nato in un paesino della Moravia (oggi in territorio della Repubblica Ceca, ma all’epoca austriaco) si distinse da subito per la sua classe cristallina sui campi di calcio, che lo portò ad essere la punta di diamante di una squadra fortissima e quasi imbattibile: la nazionale austriaca, nota in quegli anni come Wunderteam, squadra meravigliosa. Ma l’annessione dell’Austria alla Germania nazista, il tristemente famoso Anschluss del 12 marzo 1939, oltre alla fine dell’autonomia politica decretò anche la morte della federazione di calcio austriaca e della nazionale, che pure si era guadagnata sul campo il diritto a partecipare – peraltro come una delle favorite – ai campionati mondiali che si sarebbero disputati in Francia da lì a qualche mese (dal 4 al 19 giugno 1938). I migliori giocatori austriaci vennero quindi inseriti nella compagine tedesca. Sindelar, inutile dirlo, si rifiutò sempre di indossare la maglia del Terzo Reich.
Cerutti narra un episodio estremamente emozionante che ha per protagonista il nostro campione. Hitler, dopo l’Anschluss, per sancire lo scioglimento della federazione austriaca diede mandato a Goebbels, ministro della propaganda, di organizzare una partita amichevole tra le nazionali tedesca e austriaca. È estremamente ovvio che il match, per il dittatore ma anche per il popolo austriaco che all’annessione si opponeva, assumesse un’importanza che andava ben oltre l’evento sportivo, tutto sommato privo di contenuti puramente agonistici. La Germania scese in campo con una determinazione tale che fece da subito comprendere che la posta in gioco era l’affermazione di una superiorità sportiva che doveva suggellare quella militare. Ma i tedeschi fecero i conti senza il classico oste. Agli ordini di Sindelar, in più di un’occasione gli attaccanti austriaci, dopo aver saltato i difensori avversari, rinunciavano deliberatamente di andare al tiro, volgendo poi uno sguardo di sfida verso la tribuna delle autorità. Il Wunderteam stava irridendo i tedeschi. Nel secondo tempo Sindelar e compagni decisero di chiudere i conti con l’avversario e segnarono al 17’ con Sindelar stesso (che aveva fatto partire un classico “tiro alla Sindelar” e cioè a rientrare, nell’angolino, imprendibile per il portiere), il quale si produsse in un insolito, per lui, balletto di gioia sotto lo sguardo attonito dei gerarchi, e poi con un incredibile e violentissimo tiro da cinquanta metri del terzino Schasti Sesta. Al termine della partita le due squadre schierate in riga, una al fianco dell’altra, salutarono le autorità con il classico saluto nazista. Due soli calciatori rimasero immobili, le braccia ostentatamente lungo i fianchi: Matthias Sindelar e il suo amico Schasti Sesta. Leni Riefensthal, la regista cinematografica chiamata a immortalare la partita, dovette tagliare la scena, anche se questo artificio servì a poco in quanto la notizia si sparse in men che non si dica per tutto il paese.
Sindelar morì in circostanze misteriose nel 1939: avvelenamento da monossido di carbonio dovuto al cattivo funzionamento della stufa che riscaldava il suo appartamento, così recitava la dichiarazione ufficiale. Ma chi ci crede, visto che a rinvenire il cadavere fu la Gestapo?
Nel secondo capitolo, Un maestro del calcio europeo inghiottito nel nulla, si parla invece di Arpàd Weisz, allenatore di Inter, Novara e Bologna, il quale, essendo ebreo, perse lavoro e diritti dopo la promulgazione delle vergognose leggi razziali del ’38. Trasferitosi con la famiglia dapprima in Francia, a Parigi, e poi in Olanda a Dordrecht, di lui si persero le tracce e non se ne seppe più nulla. Fu il giornalista sportivo e storico Matteo Marani, dopo accurate ricerche, a scoprire che l’intera famiglia Weisz venne arrestata dalla Gestapo a Dordrecht il 2 agosto 1942 e che dopo un primo trasferimento nel campo di Westerbork in Olanda, fu spedita al campo di sterminio di Auschwitz dove la moglie e i figli dell’allenatore ebreo, dal kalendarium del lager, risultano essere stati avviati alla camera a gas appena scesi dal treno il 7 ottobre. Arpàd Weisz, invece, prima di essere annientato, venne impiegato nei campi di lavoro per sostenere lo sforzo bellico nazista. Morì ad Auschwitz il 31 gennaio 1944. Una targa lo ricorda allo stadio Meazza di Milano.
Il terzo personaggio raccontato nel libro, nel capitolo dal titolo L’uomo che fece grande il Torino, è Ernest Erbstein, il quale, ungherese di origini ebraiche (seppur non professante), conobbe la stessa discriminazione del suo collega Arpàd Weisz, all’atto dell’introduzione delle leggi razziali. La famiglia Erbstein ebbe una vita avventurosa nel periodo che va dalla cacciata dall’Italia alla fine della guerra, girovagando tra Germania, Olanda e Ungheria dove i nazisti suoi concittadini, le famigerate Croci Frecciate, riuscivano ad essere ancor più feroci e determinati, nella persecuzione degli ebrei, degli originali tedeschi cui si ispiravano. Ernest Erbstein rientrò in Italia, a Torino, nel dopoguerra. Nei quattro campionati che la squadra granata disputò sotto la sua direzione tecnica, il grande Torino stabilì ogni genere di record, diventando una delle compagini più famose e calcisticamente importanti d’Europa. La parabola ascendente del maestro di calcio ungherese e dei fortissimi giocatori che egli dirigeva s’interruppe tragicamente il 4 maggio 1949, quando l’aereo, che riportava in Italia la squadra dopo una trasferta a Lisbona, come è noto andò a schiantarsi contro la collina sulla quale sorge la basilica di Superga.
La preziosità del libro di Giovanni A. Cerutti è data dal fatto che partendo dalla semplice curiosità per vicende legate all’amato sport, il lettore ha l’occasione di ripercorrere (nel mio caso il percorso è stato inverso) gran parte della storia del Novecento, drammatica, violenta, straordinaria, senza la conoscenza della quale è difficile, anzi impossibile, interpretare i giorni strani e inquietanti che stiamo vivendo. Giorni che sembrano essere l’eco sinistra di qualcosa che è già stato e che è bene continuino ad essere solo un brutto ricordo.
Bibliografia citata/utile per approfondimenti:
Osvaldo Soriano, Pensare con i piedi, Einaudi, 1995
Gianni Brera, L’arcimatto – 1960-1966, Baldini & Castoldi, 1993
Luciano Bianciardi, Il fuorigioco mi sta antipatico, Stampa Alternativa, 2006
Darwin Pastorin, L’ultima parata di Moacyr Barbosa, Mondadori, 2005
Manuel Vazquez Montalban, Il centravanti è stato assassinato verso sera, Feltrinelli, 1993
Franco Bernini, La prima volta, Einaudi, 2005
Emilio Marrese, Rosa di fuoco, Pendragon, 2010
Quique Peinado, Calciatori di sinistra, Isbn Edizioni, 2013
Giovanni A. Cerutti, La svastica allo stadio – storie di persecuzione e di resistenza nel mondo del calcio sotto il nazismo, Editrice A, 2014
Nello Governato, La partita dell’addio – Matthias Sindelar, il campione che non si piegò a Hitler, Mondadori, 2007
Matteo Marani, Dallo scudetto ad Auschwitz – vita e morte di Arpàd Weisz, allenatore ebreo, Aliberti Editore, 2007
Leoncarlo Settimelli, L’allenatore errante – storia dell’uomo che fece vincere cinque scudetti al grande Torino, Ed. Zona, 2006
Simon Kuper, Ajax, la squadra del ghetto, Isbn Edizioni, 2005