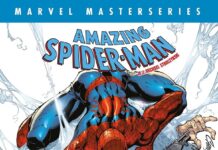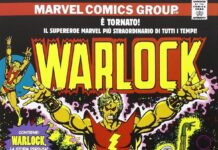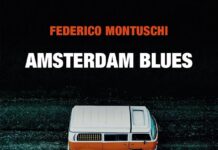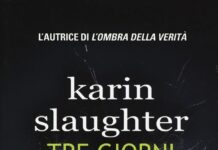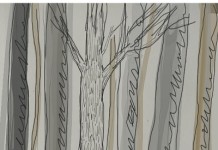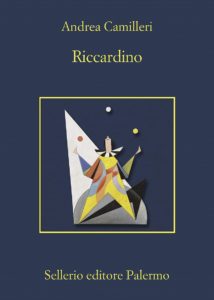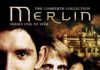Riccardino, all’inizio, si legge con trepidazione, con un senso di fine imminente perché è l’ultimo romanzo che Andrea Camilleri ci ha consegnato. Anche se non è l’ultimo che ha scritto: infatti era stato stilato tra il 2004 e il 2005 quando, compiuti ottant’anni, lo scrittore pensava di essere giunto alla fine della parabola della sua vita e quindi anche di quella del suo commissario. Dopo quasi dodici anni, come lui stesso dichiara con l’ironia che gli è propria, “sorpreso di essere ancora vivo” decise di rimaneggiare il romanzo dal punto di vista linguistico, perché la lingua di Montalbano, come la lingua viva, parlata, nel tempo si era evoluta e quindi il suo autore aveva sentito il bisogno di rinnovarla, lasciando però intatta la trama. Una trama avvincente, piena di colpi di scena, che ben presto ci fa dimenticare le sensazioni iniziali generate dall’idea che si tratti dell’ultima inchiesta di Montalbano.
Sicuramente i lettori affezionati di Camilleri sanno quanto il Maigret di Georges Simenon abbia influito sulla “nascita” del commissario: non è un mistero infatti che Camilleri fosse un profondo conoscitore di Maigret, avendo curato, insieme a Diego Fabbri, la produzione dei 16 episodi dello sceneggiato realizzato dalla Rai tra il 1964 e il 1972. Come ebbe a dichiarare il regista Sironi in un’intervista a me rilasciata, Montalbano non ci sarebbe stato se non ci fosse stato Maigret. E leggendo Riccardino mi è venuto in mente proprio uno dei romanzi di Simenon, Le memorie di Maigret, in cui si assiste al medesimo gioco di specchi fra l’autore e il suo personaggio. Sicuramente Camilleri lo aveva presente durante la stesura; del resto, come ha affermato Umberto Eco nelle Postille critiche al Nome della rosa, “i romanzi parlano tra loro”. Camilleri però ha ampliato ulteriormente il gioco di rimandi aggiungendo, a volte, qualche riferimento a Luca Zingaretti, l’attore che interpreta Montalbano nella serie televisiva. È un gioco molto interessante che non può che intrigare, perché sembra quasi che l’autore influenzi con la sua presenza l’indagine del commissario, gli dia consigli, lo rimproveri per i suoi errori… ma non aggiungo altro per non togliere il piacere della lettura a chi ancora non avesse avuto modo di concedersela.
Articoli correlati:
Andrea Camilleri – La fine di Montalbano
Georges Simenon – Le memorie di Maigret (recensione)