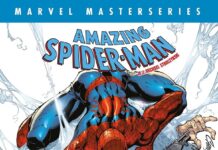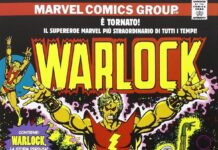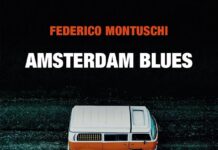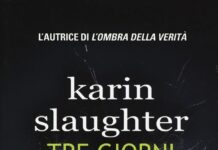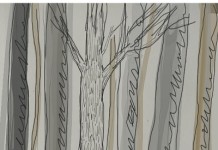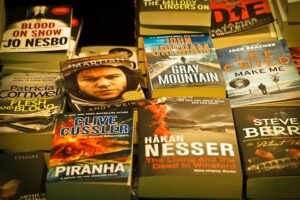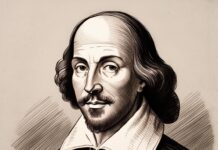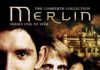Il fenomeno della ripetizione e dell’iterazione nei prodotti culturali moderni risponde a un’esigenza di prevedibilità e rassicurazione, caratteristica di una società sovraccarica di complessità e stimoli. La tendenza a semplificare e ridurre l’inatteso emerge sia nella musica, con l’affermarsi di hit simili tra loro all’interno del repertorio di uno stesso artista, sia nella narrativa, con la proliferazione di produzioni seriali e format ripetibili. Questa “fame di ridondanza” riflette una sorta di ricerca del familiare e del prevedibile, in grado di lenire l’ansia generata dalle continue trasformazioni del mondo moderno.
In ambito musicale, l’esigenza di ripetere schemi di successo è manifesta nella produzione di brani che variano solo leggermente dall’uno all’altro, assecondando il desiderio del pubblico di rivivere una determinata esperienza sonora ad libitum. Secondo Simon Reynolds, critico musicale britannico, la musica popolare contemporanea è “ossessionata dalla ripetizione” e si basa su un ciclo di auto-citazioni e riferimenti costanti, che si traducono in una semplificazione dell’ascolto e in una memorizzazione istantanea dei brani da parte degli ascoltatori.
Allo stesso modo, la narrativa contemporanea, in particolare quella seriale e di genere, risponde a un’esigenza simile. Come sostiene Umberto Eco in Apocalittici e integrati, le narrazioni seriali si basano su “schemi ricorrenti” che fungono da archetipi, offrendo un senso di stabilità che permette al lettore di trovarsi a proprio agio all’interno di mondi narrativi familiari. La rassicurazione che deriva dalla prevedibilità della struttura narrativa stimola l’identificazione e il senso di continuità, elementi cruciali in un’epoca in cui il lettore cerca rifugio dalla complessità e dall’imprevedibilità della vita reale.
Un altro aspetto significativo è il consumo rapido e frequente di contenuti iterativi e “a puntate” nelle piattaforme di streaming, che rende lo spettatore avvezzo a narrazioni veloci e ripetitive, spesso incentrate su eroi, mondi o situazioni ciclici. Come ha osservato Mark Fisher, l’industria culturale contemporanea tende a promuovere un “tempo senza eventi” o “tempo piatto”, nel quale si ha l’impressione che i cambiamenti effettivi siano pochi o, se presenti, reversibili. La ripetizione e il ritorno di pattern simili producono così un “presente continuo”, in cui l’esperienza del consumo culturale diviene una fuga ciclica dalle complessità del mondo reale.
La ricerca di questi contenuti semplici e ciclici riflette un bisogno di sicurezza e stabilità, e agisce come una sorta di “comfort zone” cognitiva, dove l’imprevisto è minimizzato. Il “presente continuo” offerto dai consumi ciclici e ridondanti, però, crea una sorta di stasi temporale, nella quale il passato e il futuro si appiattiscono a favore di un eterno “qui e ora” facile da gestire e digerire, il che si traduce in un distacco dalla complessità della vita contemporanea e dall’impegno per comprenderla, limitando il cambiamento e il pensiero critico.
Insomma, il consumo culturale ciclico offre un rifugio temporaneo dalle sfide quotidiane, ma rischia di inibire la capacità delle persone di affrontare, interpretare e risolvere le problematiche reali del loro tempo. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
Per rimediare a questo stato, che si traduce anche in stasi creativa, sarebbe necessario un impegno congiunto da parte di educatori, istituzioni culturali, critici, creatori e pubblico. Soltanto attraverso una collaborazione a lungo termine sarebbe possibile ristabilire un equilibrio tra la prevedibilità rassicurante dei contenuti seriali e l’entusiasmo per l’originalità e l’innovazione culturale. Ma non vedo la volontà di realizzarlo, da parte di nessuno degli attori coinvolti. Per pigrizia o per interesse, si preferisce adagiarsi nel comodo abbraccio della ripetitività.
E intanto l’ombra della sera scendeva.