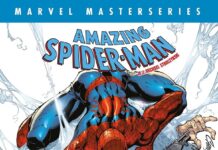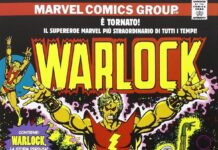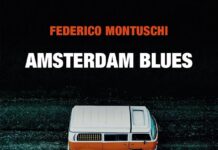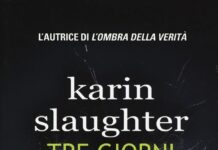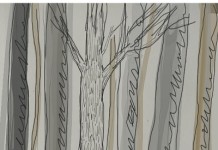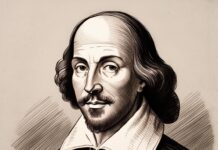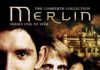“Non lo vedevamo? Non ce ne siamo accorti?” sono domande retoriche, quasi comiche, che ci si potrebbe porre contemplando l’attuale panorama culturale, letteratura inclusa. Il pop, con la sua implacabile strategia di massificazione e banalizzazione, ha ormai distrutto ogni angolo di autentica ricerca artistica. Era inevitabile, direte? Forse, ma dobbiamo davvero accettarlo senza colpo ferire?
Non fraintendetemi: non si tratta di un’accusa verso chi ama la leggerezza o la semplicità, ma verso un sistema che ha reso quella la sola opzione disponibile. Libri che esplorano la complessità umana? Troppo impegnativi. Trame che richiedono un minimo sforzo intellettuale? Nah, meglio un po’ di comfort food letterario: personaggi piatti, dialoghi che sembrano usciti da un algoritmo e trame che scivolano via come serie TV da binge-watching.
La letteratura di massa si è trasformata in una versione decorativa di se stessa, un’esperienza confezionata per soddisfare le aspettative immediate di chi, distratto dal bombardamento social, non vuole pensare. E che cos’è il pop, se non l’arte di appiattire, di rendere tutto omogeneo, tutto digeribile? Abbiamo trasformato i romanzi in una catena di montaggio emotiva: vuoi ridere? Ecco una battuta. Vuoi piangere? Qui c’è un cliché drammatico (drammatico, attenzione: mai tragico, che la tragedia è troppo da digerire). Vuoi sognare? Prego, il solito eroe con l’arco narrativo prefabbricato e semplificato.
E non parliamo del linguaggio! Una volta potente veicolo di idee, ora ridotto a una melassa informe, un miscuglio di frasi fatte, espressioni vuote e slogan. Dov’è finita la letteratura che sfida? Quella che disturba, che provoca? Forse è stata archiviata come troppo “demodé”, mentre i bestseller propongono storie che scorrono come acqua tiepida, lasciandoci esattamente come ci hanno trovati: addormentati, assuefatti, acquiescenti.
Si dirà: “Il pop vende, la cultura è una nicchia”. Certo, ma è davvero impossibile immaginare un modello diverso? Davvero non ci serve più una letteratura che provoca e stimola, ma solo qualcosa che “intrattiene”? E, ribadisco, il problema non è la presenza del pop, ma la sua egemonia. Non è un caso che chi prova a sfidare questo dominio venga relegato ai margini, etichettato come “elitario” o, peggio, “noioso”. Guai a parlare di profondità: il pop la aborre – preferisce la superficie, brillante e lucida come una vetrina.
Da quando, esattamente, il valore di un’opera culturale è misurato dalla sua vendibilità? La letteratura che conta, quella che spinge a pensare e sfida le convenzioni, non ha mai avuto come scopo primario il mercato. Eppure eccoci qui, in un mondo dove “se vende, vale” sembra essere il nuovo dogma. Il che presuppone il suo deleterio opposto: “se non vende, non vale”. Un ragionamento che rasenta il ridicolo: misurare la cultura con il metro delle copie vendute è come giudicare un quadro dal colore della cornice.
Il paradigma “se non vende, non vale”, rappresenta la completa inversione dei valori culturali: la quantità al posto della qualità, la logica del profitto che fagocita il senso stesso della creazione artistica. Una visione mercantile che non lascia spazio all’immaginazione, all’audacia o alla ricerca del nuovo.
Dunque che cos’è la letteratura, oggi, se non un prodotto da scaffale, un brand? Autori che diventano marchi, romanzi che si vendono più per il nome in copertina che per il contenuto. Qualcuno ricorderà quando i libri erano spazi di libertà, non semplici merci? Quei tempi sembrano così lontani, sostituiti da un’industria che se ne frega della qualità, punta soltanto alla velocità di consumo.
“Pop has eaten itself”, dicono gli anglofoni. E noi? Noi ci siamo lasciati mangiare senza opporre resistenza, sorridendo, mentre il pop digeriva tutto: idee, speranze, visioni. Ma ora, guardando il panorama letterario desertificato, dovremmo almeno avere il coraggio di ammettere che, sì, è successo sotto i nostri occhi. E non solo: abbiamo lasciato che accadesse, spettatori imbelli di questa società dello spettacolo che tutto ingloba, come ben denunciava Guy Debord nel suo celebre manifesto, in cui ci ammoniva che “tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione” e che “il mondo intero è diventato merce”. Ci aveva avvertiti, già alla fine degli anni Sessanta. E noi, per cinquant’anni, ci siamo limitati a fare spallucce. Con il nostro silenzio e la nostra indifferenza, abbiamo permesso che la cultura si trasformasse in mero intrattenimento senz’anima, scambiandola per una forma di libertà. Ma è una libertà ingannevole: quella di scegliere tra prodotti identici, svuotati di significato e piegati alla logica del consumo.
E no, non è affatto divertente.
Heiko H. Caimi