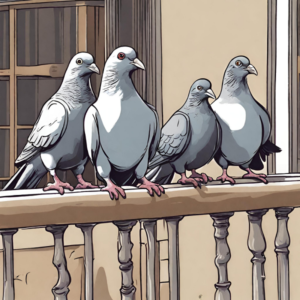Gabri era ripartito per la Germania da poco meno di un’ora. Era pomeriggio, il cielo si stava annuvolando lentamente ed ero sdraiato sul divano, travolto da un vortice di pensieri futili. Riflettevo sulla calma dei piccioni che poco più di ventiquattro ore prima avevano sconvolto il nostro risveglio.
Perché si erano intrufolati nella mia cucina? Perché proprio da me? Perché la grande battaglia con il fucile ad acqua non era bastata a scoraggiarli? Perché tutta quella calma nell’uscire?
Queste e un’altra dozzina di domande senza grossa importanza mi turbavano, facendomi dimenticare tutto il resto: le destre che sicuramente avrebbero vinto le elezioni, la guerra ai confini dell’Europa, la siccità, i miei lavori sempre più precari, le bollette da pagare entro due giorni, la solitudine che mi mordeva il collo da quando Mariangela mi aveva lasciato, la cena che avevo promesso a Gigi e che avrei dovuto paccare con un messaggio. Tutto.
Mi misi a fumare una cannetta sul balcone: il quartiere si stava ingrigendo e l’aria umida si appesantiva del profumo della pioggia. Spesso, durante quella torrida estate in città, il temporale minacciava di cadere senza però mai palesarsi, complice la bassa pressione o forse il forte inquinamento. Almeno una decina di volte in tutto il periodo estivo Padova fu schivata dai nubifragi.
Pensai che quella dovesse essere una delle tante volte.
I piccioni svolazzavano e tubavano ovunque all’interno della corte. Qualcuno sul tetto della casa rosa di fronte, qualcuno sul balcone di fianco al mio, qualcuno sul terrazzo di sotto.
Quattro in particolare avevano dei segni di riconoscimento evidenti, ed erano sempre nelle vicinanze del mio balcone. Gli diedi dei nomi:
Tzigano aveva la coda aperta nel centro, senza piume. Era ciotto e grigio scuro.
Roncio era brutto, secco, sporco e con il becco rosso sangue.
White era bianco, snello e tonico, con qualche macchia grigia sul dorso e sulla testa.
Odio era il peggiore di tutti. Era uno dei tre entrati nella mia cucina e forse, ma non ne ero certo, era anche uno dei due che avevo colpito con il fucile ad acqua. Era bello, il bastardo. Grigio con sfumature che al sole ricordavano il viola acceso. Il petto alto e il collo lungo. Quando camminava sui tetti, aveva il passo elegante e il movimento della testa era così coordinato e fiero che pareva marciasse.
Ero leggermente sballato dalla canna e decisi di fumare una sigaretta e godermi ancoro un po’ l’aria gradevole del tardo pomeriggio.
Guardando a est, tra due condominii, la corte aveva uno scorcio della grandezza di un cancello, da cui s’intravedeva il kebabbaro all’inizio del cavalcavia della stazione. Lì, ragazzini arabi stavano ascoltando musica a tutto volume. La base era hip-hop mentre sonorità e parole erano tipiche del Maghreb. Uno di loro si alzò e si mise a ballare e cantare facendo ridere a crepapelle gli altri, seduti sul muretto. Mi fece sorridere quella scena e, non so per quale motivo, riflettei sul senso della vita, su quello dei confini e sul significato della parola “libertà”. Di quest’ultima in particolare mi sembrava di non saperlo. Di non esserne all’altezza. Di non averla mai toccata veramente.
Dibattei per qualche minuto tra me e me, poi il ragionamento nella mia testa svanì irrisolto, come quasi tutti quelli di questo tipo.
Un piccione planò a un metro dalla mia faccia per poi posarsi qualche metro sotto, sul balcone del vicino cinese.
Roncio, pensai. Era proprio quel pennuto. Era troppo sudicio e smilzo per non esserlo.
Si mosse sopra lo stendino pieno di vestiti. Dopo qualche secondo uscì l’uomo con una scopa, sbuffando, e lo cacciò via. Poi mi guardò, rientrando, e quella fu la seconda volta in pochi giorni che scambiai un cenno d’intesa con lui. Quel cenno mi aprì un vortice d’immagini di scene di vita ordinaria dentro la testa.
Forse c’era una connessione tra me, quell’uomo e i piccioni. In fin dei conti eravamo parte dello stesso piccolo territorio da cui avremmo potuto scappare.
Ma quella era ciò che chiamavamo casa. Chi per scelta, chi per nascita e chi per necessità. Non tutti gli uomini vogliono viaggiare. Non tutti gli uccelli vogliono migrare.
Poi pensai alle mie scelte, al perché fossi lì, in quel condominio sul retro della stazione, a parlare da solo e a maledire i piccioni. Ma non mi riuscì di criticare troppo le decisioni prese fino a quel momento, né tantomeno i miei percorsi.
Pensai allora che la vita di tutti quanti era semplicemente una matassa infinita di piccole sfighe, fortune, sconfitte e gesta quotidiane. I piccioni erano tra le mie sfighe, il battermi con loro tra le mie gesta. Le mie giornate, lentamente, boccheggiavano tra quelle degli altri. Uomini e donne correvano in affanno continuo su automobili, moto e bici che le muovevano a destra e sinistra sotto il mio balcone. E io fermo, statuario sopra le loro teste. Stop.
In un lampo anche quel ragionamento svanì. Volevo rollarmi la sigaretta ma, aprendo il tabacco, mi accorsi che mancavano i filtri. Andai in camera e notai di avere ancora i jeans, me li tolsi e mi misi comodo con i pantaloni della tuta. Tornai sul balcone ma mi venne in mente di aver lasciato l’accendino nei pantaloni appena gettati nella cesta delle cose da lavare e lo recuperai
Mi sedetti sul balcone ma subito mi rialzai sbuffando, cosciente di non aver preso i filtri. Tornai in camera sentendomi un perfetto idiota.
Di nuovo fuori, ripresi a guardare e ascoltare i ragazzi.
La musica era cambiata e ora una voce femminile molto calda intonava una melodia reiterata che interpretai a mio modo cosi: Bashi inde hacaeiashindekha. In poco tempo diventò un vero mantra nella mia testa e presi a canticchiare quella melodia sottovoce. Bashi inde hacaeiashindekha. Alzai a poco a poco la voce; più l’intonavo, più quella melodia mi sembrava trasformarsi in un’invocazione.
Bashi inde hacaeiashindekha.Bashi inde hacaeiashindekha.Bashi inde hacaeiashindekha.
Di colpo si alzò il vento e iniziò a piovere. Forte.
Calò una pioggia grossa e fitta.
I piccioni si alzarono in volo diretti a sud, verso il centro, dove probabilmente avevano ripari più coperti di quelli nella corte. Scapparono a decine, decollarono da ogni punto dei tetti attorno al mio condominio, dalle finestre, dal terrazzo sotto e dalla finestra di Francesco.
Riconobbi White e Tzigano. Andavano verso il centro anche loro, come tutti gli altri.
Capii che la mia battaglia contro i pennuti aveva raggiunto una tregua, e con essa le mie preoccupazioni.
In cuor mio avevo vinto. Io, Pepe Antonio, perenne perdente, avevo finalmente sconfitto, sgominato, debellato i miei avversari, aiutato dalla madre pioggia portatrice di pace, donatrice di lentezza.
Mi appoggiai sull’uscio della porta finestra per godermi gli ultimi tiri di sigaretta e quel tanto atteso scravasso.
La pioggia in pochi istanti aveva spazzato via ogni residuo di guano sul mio balcone e sul cornicione. I piccioni se n’erano andati. L’afa aveva lasciato il posto a una piacevole brezza. Settembre era finalmente arrivato, e con esso i venti freddi da nord, i vecchi vestiti lunghi, la malinconia del mare, i ricordi opachi, i silenzi appucundriaci, il dolce rumore della pioggia sull’asfalto e una primissima voglia di neve.
(fine)
Le puntate precedenti:
1: Una breve giornata di merda
2: Due piccioni con una fava
3: Tre tigri contro tre tigri