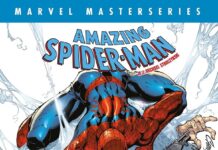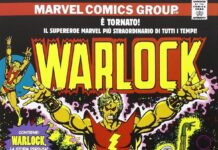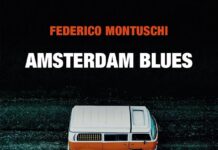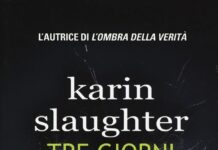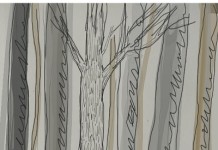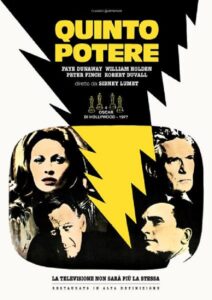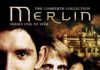Scritto da Paddy Chayefsky, Quinto potere (titolo originale: Network) racconta il mondo del giornalismo televisivo seguendo la parabola del conduttore Howard Beale (Peter Finch) che, dopo essere stato licenziato, annuncia il proprio suicidio in diretta TV. La scioccante dichiarazione diventa un evento mediatico e trasforma Beale in una sorta di “profeta” dei mass media, manipolato dalle logiche del profitto televisivo.
Uno dei temi centrali del film, infatti, è la spettacolarizzazione dell’informazione, che svolge attraverso una critica feroce al modo in cui i media trasformano eventi tragici e personali in intrattenimento. Proseguendo e portando su un altro livello quanto iniziato da Billy Wilder con L’asso nella manica e anticipando il più contemporaneo Don’nt Look Up di Adam McKay. La frase topica di Beale, “Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più!”, diventa un grido di ribellione collettiva, entusiasmante ma vuoto, a sua volta strumentalizzato per fare audience. Una denuncia della disumanizzazione dell’informazione e dell’influenza corrosiva del capitalismo sui media, che riducono le notizie a mera merce. Come scriveva Guy Debord nel suo lucidissimo saggio La società dello spettacolo, “L’intera vita delle società […] si annuncia come un immenso accumulo di spettacoli. Tutto ciò che era direttamente vissuto si è allontanato in una rappresentazione”.
Del resto, la rappresentazione dei media operata in Quinto potere ha numerosi punti in comune con le teorie di Debord, di cui sicuramente Chayefsky era al corrente: entrambe le opere analizzano criticamente il modo in cui i media e l’industria dello spettacolo deformano la realtà, alienano l’individuo e mercificano le emozioni umane. L’autore francese descriveva la società moderna come dominata dallo “spettacolo”, un insieme di immagini che rappresentano e distorcono la realtà al fine di mantenere il controllo sociale. Nel film questo è chiaramente rappresentato dal modo in cui la televisione trasforma ogni evento — persino il crollo psicologico di Beale — in intrattenimento solo per aumentare gli ascolti e generare profitto. Beale diventa un’icona spettacolarizzata del malcontento pubblico, ma la sua rabbia è sfruttata e manipolata a fini commerciali, mostrando come quella della partecipazione e del controllo da parte degli spettatori sia solo un’illusione, dato che in realtà sono solo clienti acquiescenti e passivi.
Quinto potere è stato profetico nell’anticipare il degrado dell’informazione e l’ascesa della televisione sensazionalistica e dei reality show, e il suo messaggio diventa ancora più rilevante con l’avvento dei nuovi media e dei social network. È un’opera che non solo denuncia il sistema mediatico, ma lo fa con uno sguardo cinico e una critica amara alla società che permette, e consuma, questo spettacolo di follia.
La sceneggiatura di Paddy Chayefsky è impeccabile nel fondere una narrazione profonda e complessa con una satira tagliente e nel creare personaggi tridimensionali: non solo racconta la storia, ma interroga i valori del pubblico e della società.
Sidney Lumet, con la sua regia, eleva ulteriormente il testo di Chayefsky. Noto per il suo approccio minimalista e orientato sugli attori, utilizza la tensione drammatica per costruire un’esperienza potente. Gioca abilmente con il ritmo, alternando i momenti di follia mediatica a scene più intime. Il suo lavoro sull’atmosfera claustrofobica e oppressiva degli studi televisivi sottolinea il senso di alienazione vissuto dai mentre il mondo attorno a loro si trasforma in uno spettacolo senza fine, che permea anche le loro vite private.
La fotografia di Owen Roizman è funzionale e priva di orpelli, ma proprio per questo estremamente efficace. Il suo uso di inquadrature strette e close-up su volti e reazioni dei personaggi intensifica il senso di pressione, soprattutto nelle scene incentrate su Howard Beale. Gli ambienti, spesso freddi e austeri, riflettono la spietatezza e la disumanizzazione del mondo televisivo. Lumet e Roizman optano per uno stile quasi documentaristico, evitando un’estetica glamour, per mantenere un senso di realtà cruda, che rispecchia il contenuto critico.
La colonna sonora, curata da Elliott Lawrence, è sorprendentemente sottile e discreta. Piuttosto che dominare la narrazione, accompagna con discrezione le scene chiave, lasciando che siano i dialoghi e le performance attoriali a prevalere. Questa scelta riflette bene il tono realistico e cupo del film, senza cercare di influenzare emotivamente il pubblico in modo diretto; infatti, non cerca di sovrastare l’azione o il messaggio del film, ma agisce come un sottofondo che sottolinea l’assurdità della situazione senza distrarre dalla messinscena.
Diana Christensen (Faye Dunaway) è l’incarnazione della spietata logica del profitto e del cinismo mediatico. Produttrice televisiva ambiziosa e fredda, è disposta a tutto per ottenere ascolti, anche a trasformare la disperazione di Howard Beale in un prodotto d’intrattenimento. La sua mancanza di umanità è evidente nella sua incapacità di stabilire relazioni autentiche: anche quando s’innamora di Max, vede la loro relazione come un’ulteriore espressione di potere, non di affetto reale. Faye Dunaway la interpreta con precisione chirurgica, evidenziando la sua determinazione quasi maniacale e la totale disconnessione dalle emozioni umane. È una figura simbolo del capitalismo sfrenato, che riduce tutto, persino le persone, a meri strumenti utili a raggiungere il successo.
Max Schumacher (William Holden) rappresenta il suo opposto e, in qualche modo, il residuo di un giornalismo che credeva ancora nell’integrità e nell’etica. Direttore delle news, è stanco e disilluso da un mondo televisivo che ha sacrificato la verità e il giornalismo serio in nome dell’intrattenimento. Cerca di resistere al declino morale del suo ambiente, ma è consapevole di essere ormai parte di un sistema che non può cambiare. Il suo rapporto con Diana è significativo: s’innamora di lei pur sapendo che rappresenta tutto ciò che lui disprezza, amplificando la sua tragica contraddizione interiore. William Holden dà al personaggio una profonda gravitas nel rappresentare un uomo in crisi, non solo professionale ma esistenziale, consapevole del proprio lento ma inevitabile crollo in un mondo che non riconosce più.
Diana e Max incarnano il conflitto centrale del film: la lotta tra l’etica e il profitto, tra l’umano e il disumano. La loro relazione diventa metafora del declino morale della società: Max, che cerca di conservare una scintilla di umanità, viene sopraffatto dalla fredda efficienza di Diana.
Howard Beale (Peter Finch) è il personaggio chiave attorno al quale ruotano la trama e l’intero messaggio del film. Conduttore televisivo veterano, è un uomo ormai stanco e vicino al crollo emotivo, un simbolo dell’alienazione dell’individuo nella società moderna e della disumanizzazione del mondo mediatico.
Quando viene licenziato a causa del calo degli ascolti, fa il suo annuncio scioccante in diretta, e questo sfogo iniziale non solo mette in luce l’instabilità del suo stato mentale, ma diventa anche il catalizzatore per la sua “rinascita” come profeta televisivo. Invece di essere allontanato dallo schermo, la rete TV sfrutta la sua follia per aumentare gli ascolti. Beale da giornalista in rovina si trasforma in un predicatore rabbioso, gridando contro la corruzione del sistema e incitando le persone a ribellarsi. Incarna così la figura dell’uomo comune travolto dall’impotenza di fronte al potere dei media e del capitalismo. Il suo personaggio è il mezzo con cui Lumet esplora il tema della disillusione: pur urlando la verità e affrontando l’ipocrisia della società, è ancora nient’altro che una pedina nelle mani di chi gestisce i media, trasformato in mera marionetta mediatica per fini commerciali. Ciò che inizia come un autentico grido di disperazione si trasforma in uno show televisivo, assegnando a Beale il doppio ruolo di vittima e carnefice allo stesso tempo. Il pubblico lo acclama, ma lo fa solo perché il suo spettacolo è diventato una fonte d’intrattenimento. Finisce così per rappresentare il grido impotente di chi è intrappolato in una realtà costruita e sfruttata dal potere. E la sua caduta definitiva, quando diventa inutile anche come strumento di spettacolo, è l’ultima, amara dimostrazione di come il sistema divori e scarti chiunque non serva più ai suoi scopi.
Peter Finch dà un’interpretazione straordinaria e magnetica del personaggio, resa ancora più memorabile dal suo stesso destino: vinse un Oscar postumo per questo ruolo, essendo morto poco prima della cerimonia. La sua interpretazione, che bilancia sapientemente carisma e vulnerabilità, cattura la disperazione, la follia e la lucidità di un uomo che, pur nella sua evidente instabilità mentale, riesce a esprimere le verità scomode che tutti cercano di ignorare.
Quinto Potere è un film di una straordinaria attualità, forse ancor più oggi rispetto al momento della sua uscita. I suoi temi centrali – la manipolazione dei media, l’intrattenimento a scapito della verità, la mercificazione delle emozioni umane – sono diventati questioni fondamentali nell’era moderna, dominata non più solo dalla televisione, ma anche da internet e dai social media. Questo raccontato nel film, infatti, è esattamente ciò che accade oggi con la sovraesposizione di notizie sensazionalistiche e la ricerca di contenuti che generino clic, indipendentemente dalla loro accuratezza. Il concetto di “infotainment” – l’informazione trattata come spettacolo – è ormai parte integrante del nostro consumo quotidiano di notizie. Howard Beale, il conduttore che “diventa matto” in diretta, viene sfruttato per le sue esplosioni emotive, trasformato in una sorta di fenomeno mediatico, proprio come accade oggi con le figure che diventano virali per la loro follia o eccentricità.
Se nel lungometraggio il crollo psicologico di Beale diventa un prodotto da vendere al pubblico, oggi più che mai i momenti di disperazione, paura o rabbia dei vip vengono amplificati e venduti sia attraverso i media tradizionali che sui social: esiste una continua ricerca di emozioni forti che mantengano alta l’attenzione, non importa quanto autentiche o etiche siano le circostanze. Lo dimostrano non solo i reality show ma anche le trasmissioni scandalistiche o le dirette virali che sfruttano il dolore o l’imbarazzo personale.
Nel film, la televisione non è controllata solo da direttori, produttori e creativi, ma dai grandi poteri finanziari che ne determinano le sorti, e questo è un tema cruciale e quanto mai attuale. Le corporazioni oggi dominano il panorama mediatico globale e decidono le narrazioni che conviene spingere, in base a interessi commerciali o politici. In “Quinto Potere”, i dirigenti decidono che il messaggio di Howard Beale può essere sfruttato fino a quando è redditizio, e questo meccanismo spietato è identico al modo in cui, oggi, la pubblicità e il profitto influenzano il modo in cui le notizie e i contenuti vengono costruiti.
La pellicola parla anche dell’alienazione dell’individuo in una società dominata dai media e dalla tecnologia. Beale urla in televisione: “Sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più!”, una frase che cattura il sentimento d’impotenza di fronte a un sistema che sembra non rispondere ai bisogni umani. Un senso di frustrazione e rabbia che oggi è ancora più diffuso, in un mondo in cui le persone sono costantemente bombardate da informazioni e stimoli, ma si sentono sempre più isolate, manipolate e senza potere reale.
Quinto Potere è stato in qualche modo profetico. L’idea che i media possano manipolare e deformare la realtà per intrattenere il pubblico è un tema che è diventato sempre più pressante. Oggi, in piena ascesa delle fake news, in una polarizzazione politica alimentata dai media e nella perdita di fiducia nella stampa, il film appare come un avvertimento che non è stato ascoltato in tempo.