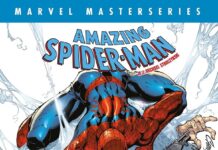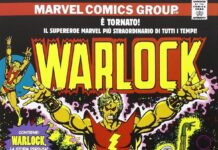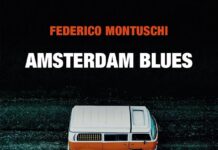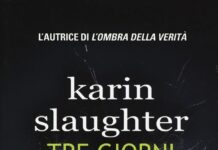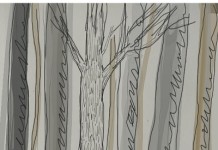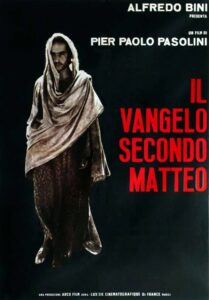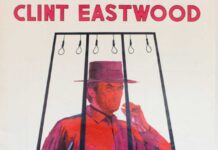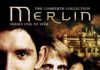Il Vangelo secondo Matteo racconta con fedeltà al testo sacro la parabola di Cristo, dall’Annunciazione alla Resurrezione, utilizzando primi piani, sguardi, silenzi, panoramiche e intere parti del Vangelo, senza aggiungere elementi iconografici o romanzati.
Pasolini si immedesima nella figura di Cristo al punto di far impersonare Maria in età adulta dalla madre Susanna, e affida il ruolo principale a uno studente catalano (Irazoqui), venuto a Roma per conoscerlo, dopo aver scritto un saggio su Ragazzi di vita. Pasolini avrebbe voluto il poeta Evtusenko, in alternativa Kerouac o Ginsberg, in quel ruolo, ma non fu possibile, perciò ripiegò su un dilettante che aveva un volto simile ai Cristi dipinti da El Greco. La Voce del Cristo è quella di uno straordinario Enrico Maria Salerno, che doppia da grande attore di prosa le espressioni intense di Irazoqui, recitando brani evangelici.
La pittura entra ancora con prepotenza nel cinema di Pasolini, che non ha frequentato il Centro Sperimentale e vede il cinema più da un punto di vista poetico-pittorico che cinematografico. Lo spettatore noterà che i fondali del Vangelo – sapientemente ambientato tra i Sassi di Matera, nelle Puglie e in altre zone depresse del meridione d’Italia – ricordano i quadri di Piero della Francesca.
Il Cristo di Pasolini non è stalinista – come ha scritto qualche critico poco accorto – ma è intriso di profonda religiosità e senso del sacro, un Cristo rivoluzionario, perché nella Palestina del tempo portare un messaggio non-violento era di per sé rivoluzionario.
Il Cristo di Pasolini divinizza l’uomo come figlio di Dio, segue l’idea del culto della personalità, contesta il potere (i cappelli da nazista, i copricapo giganteschi, l’ottusità), aborrisce la violenza, chiede la purezza di cuore tipica dei bambini.
Il film è girato con una tecnica che il regista definì magmatica: primi piani, campi lunghissimi, carrello a mano e uso caotico delle musiche (Bach, Mozart, canti popolari russi, messa congolese).
Gli attori sono rigorosamente non professionisti; Pasolini si trovava male con i veri attori, che inserivano altro dalla sua poetica nel film, anche se in diverse occasioni ha fatto ricorso a grandi interpreti come Silvana Mangano, Anna Magnani, Maria Callas, Totò (reinventandolo). Nel Vangelo servono dilettanti, amici scrittori come Alfonso Gatto, Giorgio Agamben, Francesco Leonetti, Natalia Ginzburg ed Enzo Siciliano, immortalati in silenzi e sguardi, con una poetica che ricorda Ejzenstejn, vera fonte d’ispirazione per Pasolini. Debutto di Paola Tedesco, nei panni di Salomé, appena dodicenne, quasi irriconoscibile. Ninetto Davoli si intravede in una breve sequenza.
Il silenzio è il tratto stilistico del film, oltre a un’intensa fotografia in bianco e nero curata da Tonino Delli Colli, prodigio tecnico-pittorico difficilmente eguagliabile.
La critica marxista non comprese la portata rivoluzionaria del Cristo pasoliniano, ma neppure i cattolici più oltranzisti, che avevano già dato battaglia per La ricotta, trascinando il poeta in una causa per vilipendio della religione di Stato.
Un successo di pubblico, comunque, e una soddisfazione per Pasolini, che si vide tributare dai cattolici più aperti il premio dell’Officio Cattolico Internazionale del Cinema. Premio della Giuria a Venezia, nonostante gli sputi e i fischi dei fascisti che osteggiavano Pasolini per la sua dichiarata omosessualità. Dedicato alla memoria del Papa buono, Giovanni XXIII.
Un piccolo capolavoro da rivedere nel tempo.