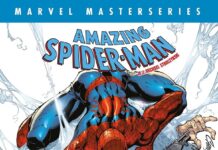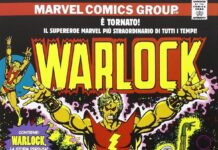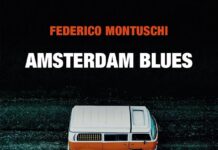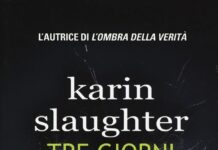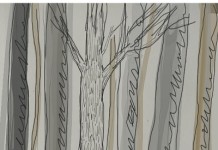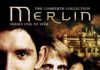Una tragedia intramontabile e universale
Scritto intorno al 1600, Amleto di William Shakespeare non è solo una delle opere teatrali più celebri e rappresentate al mondo, ma anche un capolavoro che ha profondamente influenzato la letteratura, la filosofia e la narrativa moderna. Attraverso l’ambientazione cupa e il protagonista tormentato, il Bardo indaga il senso della nostra esistenza terrena, la natura del potere e le dinamiche della vendetta, mettendo in scena uno specchio fedele delle nostre inquietudini umane.
La vicenda ruota attorno al principe di Danimarca, Amleto, la cui vita viene sconvolta dalla scoperta dell’assassinio del padre, compiuto dallo zio Claudio, che ne ha usurpato il trono e sposato la madre Gertrude. Il fantasma del re defunto ordina ad Amleto di vendicarlo, gettandolo in un vortice di dubbi, follia (apparente o reale) e riflessioni esistenziali che culminano, dopo una serie di disavventure, in una tragedia totale[1].
Il personaggio di Amleto è spesso considerato il primo grande esempio di antieroe della letteratura occidentale. Non incarna, infatti, l’eroe tradizionale: è indeciso, profondamente inquieto e consapevole dei propri limiti. La sua figura sfugge alle rigide dicotomie di bene e male, il che lo rende un personaggio complesso e profondamente umano.
Diversamente dagli eroi epici, mossi da una volontà ferrea e da valori certi, Amleto riflette sulla sua stessa incapacità di agire: «Essere o non essere, questo è il problema». Il celeberrimo monologo è una delle massime espressioni dell’ambiguità esistenziale: Amleto oscilla tra l’azione e la contemplazione, tra il desiderio di vendetta e il dubbio morale, incarnando il conflitto interiore che caratterizzerà molti antieroi successivi, da Raskol’nikov a Gatsby, da Lady Susan all’Ulisse di Joyce.
Sul piano narratologico, Amleto offre un chiaro esempio dello schema in tre tempi, che Shakespeare utilizza in modo magistrale (non si sa se consapevolmente) per costruire la tensione drammatica:
Esposizione e conflitto iniziale: Amleto scopre l’omicidio del padre e deve decidere se e come vendicarlo. Il conflitto principale non è solo esterno (Amleto contro Claudio), ma anche interno (Amleto contro se stesso).
Complicazione: la tensione cresce con la finta follia di Amleto, la morte accidentale di Polonio e la follia di Ofelia. Ogni tentativo di soluzione fallisce, e la situazione precipita verso una spirale di caos.
Risoluzione tragica: il duello finale, la morte di tutti i protagonisti principali e l’ascesa di Fortebraccio al trono rappresentano il momento culminante e la conclusione della vicenda.
Questa struttura ha influenzato profondamente la narrativa successiva. Si ritrova nel romanzo ottocentesco, nel cinema classico hollywoodiano e, più di recente, nelle moderne serie televisive, in cui il meccanismo del conflitto/complicazione/risoluzione è divenuto uno strumento narrativo imprescindibile.
Amleto affronta, come accennato, una serie di temi senza tempo: il senso della vita e della morte, la corruzione del potere, la follia, l’amore e il tradimento. Attraverso il suo protagonista, Shakespeare dà voce a una riflessione filosofica che anticipa il pensiero esistenzialista. La celebre domanda «Essere o non essere» diventa il simbolo di un dubbio che attraversa secoli di storia letteraria: vivere è un atto di coraggio o di follia?
Un altro tema centrale è la finzione, non solo come recita teatrale, ma come maschera sociale. Amleto finge di essere folle per perseguire i propri obiettivi, ma la finzione diventa così convincente da sembrare vera anche a lui stesso. Questo gioco di specchi tra realtà e apparenza trova espressione nel celebre dialogo con Polonio.
L’importanza di Amleto va dunque ben oltre i confini del teatro, e rimane una pietra miliare della letteratura mondiale, capace di affascinare e interrogare il pubblico di ogni epoca proprio perché non offre risposte definitive, ma invita alla riflessione e al dubbio. Ed è ben più di un dramma, collocandosi perfettamente nel genere della tragedia[2]. Come affermò Victor Hugo, Shakespeare ha inventato l’uomo moderno, e Amleto ne è l’emblema.