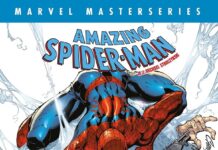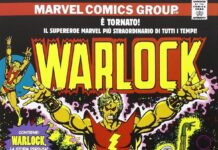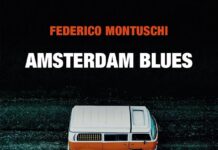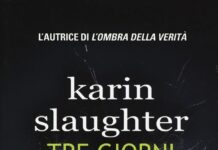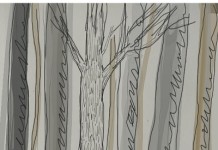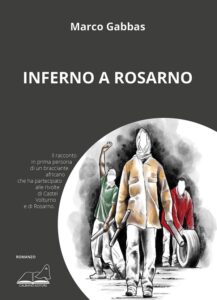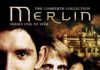Inferno a Rosarno è un romanzo che apre una finestra senza filtri sulla realtà, spesso invisibile, dell’immigrazione e dello sfruttamento in Italia. Raccontato in prima persona da un giovane emigrante sub-sahariano, dipinge un quadro realistico e struggente delle esperienze che milioni di persone vivono nel tentativo di trovare una vita migliore. Quelle stesse esperienze che di solito accogliamo con una scrollata di spalle.
L’opera si distingue per il suo linguaggio diretto, che non ricorre a eufemismi per attenuare la brutalità degli eventi narrati, diventando così ancora più incisivo. Marco Gabbas riesce a rendere palpabile il senso di alienazione e la condizione di precarietà del protagonista. Le descrizioni del viaggio attraverso il Sahara e il Mediterraneo sono talmente vivide da farci sentire quasi presenti, testimoni del pericolo, della fame e della paura.
L’autore non si limita alla denuncia sociale: fornisce anche uno spaccato intimo di quell’umanità dolente che vive spesso ignorata nelle nostre campagne, esplorando le emozioni del protagonista, che non è soltanto una vittima, ma anche un portatore di coscienza storica. Infatti il richiamo alla letteratura di Primo Levi, Frantz Fanon e Aimé Césaire arricchisce il testo di riferimenti culturali, sottolineando le connessioni tra lo sfruttamento odierno e le oppressioni del passato.
Il libro affronta con forza molteplici temi sociali: il razzismo istituzionale, il lavoro nero, la criminalità organizzata e la violenza quotidiana. Gabbas non risparmia critiche alle politiche migratorie italiane ed europee, descritte come strumenti di esclusione e sfruttamento, cui si può opporre soltanto una resistenza fondata sulla dignità.
Le scene che illustrano la vita nei campi agricoli, il rapporto con i caporali e le bande criminali locali sono le più intense e disturbanti: ne emergono chiaramente le dinamiche di oppressione che condannano gli immigrati a un’esistenza disumanizzante, priva di sicurezze e diritti. Eppure, non cedono mai fino in fondo alla disperazione: attraverso le rivolte di Castel Volturno e Rosarno, Gabbas celebra la forza della resistenza collettiva e la possibilità di ribellarsi.
Lo stile è asciutto ma evocativo. La narrazione alterna momenti di tensione estrema a riflessioni più lente e dolorose, creando un ritmo che cattura e coinvolge. La struttura episodica, che segue il protagonista attraverso le sue vicissitudini, permette di esplorare diversi ambienti e dinamiche, dalle traversate mortali nel deserto ai lavori nei campi, fino ai conflitti con la criminalità organizzata.
L’utilizzo della prima persona accentua l’immedesimazione, mentre l’inserimento di dialoghi, pensieri e flashback aggiunge profondità al racconto. Le scene di violenza e sfruttamento sono descritte senza sensazionalismo, il che, paradossalmente, le rende ancora più scioccanti e credibili.
Una delle caratteristiche più distintive del romanzo è la capacità di unire le microstorie alla Storia: le vicende personali del protagonista si intrecciano con dinamiche politiche e sociali ben più ampie e determinanti. Questo lo rende non solo un romanzo di denuncia, ma anche un’opera che invita alla riflessione sui meccanismi globali di oppressione e sul ruolo che vi ricopre l’Europa.
Inferno a Rosarno è un libro necessario, che si inserisce con forza nella letteratura contemporanea sulle migrazioni. Non è un testo facile da leggere, a causa del suo portato emotivo, ma proprio per questo è essenziale: ci sfida a guardare la realtà in faccia, a confrontarci con le ingiustizie che si consumano sotto i nostri occhi.
Con la sua capacità di dare voce agli invisibili, Gabbas riesce a trasformare il dolore e la rabbia in uno strumento di resistenza e consapevolezza, lasciando un segno indelebile nei nostri cuori. Un romanzo potente e crudo, che non solo racconta, ma scuote fin nelle viscere.