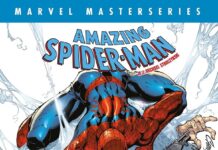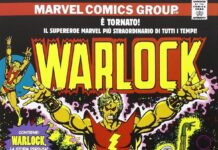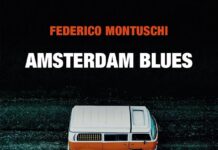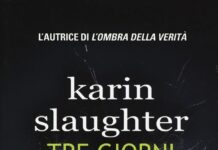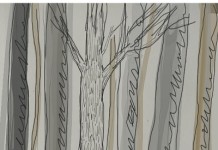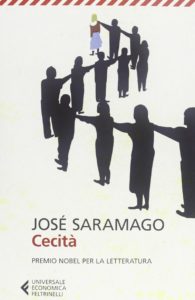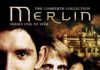In una città non indicata, e che proprio per questo potrebbe essere qualsiasi luogo, un uomo diventa cieco all’improvviso.
A questo primo imprevisto avvenimento seguono in rapida sequenza analoghi e molteplici casi di cecità, tanto da far pensare a un’epidemia. Quale sarà il comportamento dei singoli individui colpiti dal male? E cosa invece comporterà la reazione delle istituzioni, del potere, di fronte a quel dramma, apparentemente incontrollabile?
Saramago, scrittore portoghese tra i più letti e tradotti al mondo, ci prende per mano e ci guida, come fossimo non vedenti noi stessi al pari dei personaggi del suo libro, attraverso le pieghe/piaghe dell’esistenza umana. L’autore estremizza puntando freddamente la lente su particolari aberranti, esaspera il racconto per meglio scandagliare l’animo umano in situazioni limite, creando così arcobaleni di sentimenti anche contrastanti tra loro, che nascono, si fondono per poi separarsi di nuovo.
Il lettore si trova così profondamente immerso nello sgomento di chi perde la capacità di vedere e con essa la sicurezza e l’autonomia, la speranza di riacquistare la vista, la delusione e la rabbia nei confronti delle “contromisure” adottate dal potere (contromisure che ne smascherano il cinismo ma anche i limiti), la mortificazione nello scoprire egoismo sfrenato anziché solidarietà nelle persone vicine, legate dallo stesso problema, la ribellione, che sfocia addirittura in voglia e capacità di uccidere, nei confronti di queste vessazioni, e poi schifo, pietà, rassegnazione, e infine ancora speranza. Finché c’é vita, c’é speranza.
Non é un luogo comune. Non in questo libro. Non tra queste pagine dove una donna, per amore, si finge cieca per poter continuare a vivere accanto al proprio uomo colpito dal male.
Scrittura tanto dolce quanto violenta, quella di Saramago, parole usate come bisturi forse solo per arrivare a sussurrarci, per dirla alla De Andrè, che “non esistono poteri buoni”.