Nato a Cagliari nel 1982, Piergiorgio Pulixi, dopo aver soggiornato lungamente a Londra, vive a Milano. Ha pubblicato Perdas de Fogu (Edizioni E/O 2008), L’albero dei Microchip (Edizioni Ambiente 2009), Donne a perdere (Edizioni E/O 2010) e la serie poliziesca iniziata con Una brutta storia (Edizioni E/O 2012) e La notte delle pantere (Edizioni E/O 2014). Fa parte del collettivo di scrittura Mama Sabot creato da Massimo Carlotto, di cui è allievo.
È autore di 11 romanzi, dell’audiodramma Lovers Hotel, scritto con Massimo Carlotto, di 4 romanzi in collaborazione con il collettivo Mama Sabot e di svariati racconti.
Ha vinto il Premio Glauco Felici (2015) per La notte delle pantere, ilPremio Franco Fedeli (2015) per Il canto degli innocenti, il Premio Vanity Fair 2016 per il miglior personaggio letterario femminile per il commissario Carla Rame.
Con il suo ultimo romanzo noir, intitolato L’isola delle anime (Rizzoli, 2019), Piergiorgio Pulixi arriva nuovamente in finale e poi conquista il premio Scerbanenco, dopo che già lo scorso anno ha raggiunto questa posizione con Lo stupore della notte (Rizzoli, 2018), con il quale si è classificato terzo e ha vinto il Premio dei Lettori.
Vorrei chiederti di presentarti, raccontandoci come sei arrivato alla scrittura.
Questa credo sia la domanda più difficile che si possa fare ad un autore: tendo sempre a far parlare le mie opere rispetto a me, perché un autore non dovrebbe mai mettersi davanti ai propri libri. La maledizione più grande di uno scrittore è essere più famoso delle sue opere; dovrebbe sempre stare uno passo indietro rispetto ad esse.
Sicuramente la lettura, ancora più che la scrittura, è stata la linfa vitale della mia esistenza; i libri sono stati la scenografia della mia vita fin da quando ero piccolo. Sono sempre stato circondato da esempi positivi: mio nonno era un collezionista di libri, le mie insegnanti, prevalentemente donne, sono state di grande aiuto, leggendoci in aula romanzi classici e contemporanei per cercare di farci avvicinare a questa realtà. Ho fatto anche dei lavori che hanno un legame sia con la scrittura, sia con la lettura: ho lavorato per anni in una biblioteca, ho lavorato nell’ufficio stampa di una casa editrice, e poi ho deciso di provarci in maniera più seria, grazie anche all’aiuto del mio maestro Massimo Carlotto, che ha avuto la generosità di insegnare ad alcuni giovani selezionati il suo mestiere, coltivandoci come gruppo di autori. Da qui, ho preso più consapevolezza rispetto a questo mestiere, anche artigianalmente, e ho cominciato a scrivere, dedicando alla scrittura sempre più spazio all’interno della mia vita.
Una curiosità che introduce una sfumatura sui concorsi letterari Italiani: tu che hai partecipato, cosa ne pensi? Sono indice di effettivo valore, o ci sono tanti parametri che concorrono?
In Italia basta guardare il contesto politico-sociale per capire che molti premi, soprattutto quelli più famosi, sono manovrati e manovrabili. Spesso ci sono interessi alti, quasi industriali, da parte delle grosse case editrici. Parlando però di giovani autori, che tentano di iniziare a creare il proprio percorso partecipando a concorsi letterari più piccoli, è diverso. Personalmente ho iniziato così, e devo dire che è una bella palestra, soprattutto per la stesura di racconti brevi: avendo un numero massimo di battute, devi lasciar spazio alla storia; non puoi usare estetismi letterari. devi dare tutto ciò che hai senza sprecare nemmeno una parola, rendendo il tuo stile personale conciso e limpido. Credo anche che il vero valore dei concorsi sia dato dalla giuria popolare, sono cioè i lettori a decretare il vincitore. La giuria tecnica, invece, appare molto contraddittoria; il giudizio di un racconto, aldilà di elementi oggettivi, come struttura e coerenza del testo, si basa molto su un parere soggettivo. Per questo tendo ad avere più fiducia quando la giuria è composta da elementi popolari. Sconsiglio perciò tutti quei concorsi con un contributo economico, escluse le spese di giuria, perché solitamente ci sono dietro meccanismi che non hanno il giusto spirito per affrontare una gara.
Parliamo della definizione di “noir”: questo termine si evolve, ma c’è qualche punto fermo come canone. Puoi farci chiarezza su questo? Cos’è il noir tradizionale, e in cosa si differenzia da altri generi, come il giallo ad esempio?
Partiamo dalla parola stessa, prima che dal genere letterario: ‘noir’, ‘nero’, una parola breve che rimane bene incisa nella mente di un lettore, e per questo amata dagli editori. È diventato un modo quasi errato di definire una serie di generi che in realtà non gli appartengono.
Il noir classico si distacca dal giallo tradizionale. In quest’ultimo viene data importanza alla razionalità degli investigatori: di solito c’è un omicidio che va a spezzare un equilibrio iniziale e l’investigatore, con la sua razionalità quasi sempre cartesiana, cerca di ricostituire questo equilibrio, rinsaldando nel lettore la fiducia sul fatto che la razionalità possa mettere ordine nel caos. Il giallo di questo stampo ha una funzione consolatoria: reifica le ansie del lettore proiettandole su una situazione esterna più oggettiva, esorcizzando le paure della morte e della criminalità. Il noir non ha questo approccio, non è un gioco enigmistico fra autore e lettore a chi arriva prima alla soluzione, spesso la soluzione non c’è. Esso ha a che fare con atmosfere psicologiche: è un genere in cui tendenzialmente il personaggio, raramente positivo, è un perdente, un vinto, spesso un criminale, con un ribaltamento dell’ottica rispetto al giallo, dove il protagonista rappresenta il bene per la giustizia.
L’ottica che il noir predilige è quella di essere un osservatore molto attento della società. La sua vera rivoluzione è stata dire che il male, il mostro, non esiste di per sé in natura, ma viene generato dalla società stessa in virtù della povertà, dell’alienazione, della mancanza di welfare. È un racconto disincantato, spesso cinico, un ‘canto degli ultimi’. Questa sua caratteristica di essere molto attaccato alla realtà, e quindi di attaccarla e denunciarla, ha portato avanti un’intera generazione di autori, all’inizio soprattutto francesi, che univano questa vocazione, un po’ verista un po’ naturalista, con i canoni del poliziesco. Penso a Georges Simenon, per esempio, il cui intento con Maigret era quello di raccontare, più che il caso in sé, la psicologia che porta il personaggio ad un punto di rottura compiendo un crimine, quasi avesse un interesse verista nei confronti della criminalità.
Facciamo un po’ di salti arrivando alla scuola del noir italiano della fine degli anni Novanta, successiva a quella di Giorgio Scerbanenco, con autori come Giancarlo De Cataldo, Massimo Carlotto, Marcello Fois e tanti altri. Questa tendenza si è inasprita. Per fare il giornalista era un periodo particolarmente difficile; raccontare la verità in modo oggettivo, senza incorrere in problematiche legali, era complicato, erano cambiate molte cose nella pubblicazione dei giornali: le responsabilità degli scrittori erano diventate personali, e il giornalista, nel caso in cui fosse stato querelato da una parte terza, doveva pagarsi da solo le spese processuali, qindi molto spesso non c’era molta voglia di scrivere di realtà. C’era in gioco la loro carriera, e anche la loro pelle, perciò questi autori hanno deciso di utilizzare il noir come un surrogato del giornalismo d’inchiesta. De Cataldo, ad esempio, giudice e magistrato, tenta di raccontare l’Italia attraverso dei noir.
Ora questo ruolo è stato esaurito grazie ai cambiamenti del mondo e della società. La televisione si è fatta carico di prendere questo fardello, utilizzando questo nuovo medium per raccontare la realtà, anche se non sempre in maniera buona: spesso c’è un’attenzione morbosa verso la criminalità, un’attenzione sbagliata nei confronti delle vittime, cui non viene data giustizia neppure a livello di giornalismo investigativo. C’è la ricerca del mostro, c’è la costruzione del caso in maniera mediatica, ma quando non fa più audience, dopo un paio di settimane, non c’è più utilità e viene accantonato. Credo che il noir si sia sentito un po’ svilito da questa faccenda: tanti autori hanno abbandonato questo territorio dandosi al thriller, proprio perché sembrava non ce ne fosse più la necessità. Secondo me la necessità c’è, ma bisogna trovare nuove soluzioni narrative.
La mia soluzione, potrei anche sbagliarmi, è stata quella di ibridare il genere noir con altri generi che vanno a puntellarlo. La società odierna è talmente complessa, si muove in maniera talmente parossistica, che ritenere che un singolo genere letterario sia in grado di raccontarla è cosa ingenua. Probabilmente dobbiamo sfruttare più ‘lenti’ e generi letterari che possano contenere una maggiore quantità di colori e nitidezza. Questo è un po’ il territorio in cui mi sto muovendo assieme a Massimo, anche se in modo diverso: lui sta cercando di riportare una narrazione che abbia un legame più sottile tra cittadino e crimine, poiché la percezione di criminalità si è talmente ridotta che il cittadino è immerso nel contesto criminale senza rendersene conto.
Cerchiamo di andare dal generale al particolare: tu hai iniziato con il noir puro, pensiamo a personaggi come Biagio Mazzeo.
 Quando ho scritto questa quadrilogia ero molto giovane ma ci stavo lavorando da anni, e quando sei così giovane non hai paura di niente, sei più ingenuo rispetto alle dinamiche editoriali e sperimenti molto di più a livello letterario. Personalmente mi è andata bene, mi hanno permesso di fare questo esperimento: consisteva nel raccontare una caduta agli inferi non soltanto di un singolo personaggio, il poliziotto protagonista Biagio, ma quella di un’intera squadra di poliziotti e della sua famiglia. È come se, in modo molto umile, avessi voluto comporre una mini-tragedia shakespeariana, utilizzando però tutti gli stilemi del genere noir; quindi ho preso un personaggio che, caduto agli inferi per via della sua ambizione sfrenata, ha trascinato con sé tutte le persone che amava. È un romanzo che parla d’amore, di cosa sei disposto a fare per l’amore degli altri e di cosa sei disposto a sacrificare per amore degli altri. Una brutta storia è il titolo del primo romanzo. Questo personaggio si ritrova talmente invischiato in questa situazione, che perde l’anima e le persone a lui vicine. Alcuni lo seguono, altri no, cadendo come pedine nella guerra sporca che lui combatte. In questa parte sì, è un noir puro, con una visione cinica; nel primo libro si parlava di corruzione all’interno delle forze di polizia, estendendosi poi fino a toccare la corruzione politica della criminalità organizzata, e la ramificazione delle nostre mafie in Italia e nel mondo.
Quando ho scritto questa quadrilogia ero molto giovane ma ci stavo lavorando da anni, e quando sei così giovane non hai paura di niente, sei più ingenuo rispetto alle dinamiche editoriali e sperimenti molto di più a livello letterario. Personalmente mi è andata bene, mi hanno permesso di fare questo esperimento: consisteva nel raccontare una caduta agli inferi non soltanto di un singolo personaggio, il poliziotto protagonista Biagio, ma quella di un’intera squadra di poliziotti e della sua famiglia. È come se, in modo molto umile, avessi voluto comporre una mini-tragedia shakespeariana, utilizzando però tutti gli stilemi del genere noir; quindi ho preso un personaggio che, caduto agli inferi per via della sua ambizione sfrenata, ha trascinato con sé tutte le persone che amava. È un romanzo che parla d’amore, di cosa sei disposto a fare per l’amore degli altri e di cosa sei disposto a sacrificare per amore degli altri. Una brutta storia è il titolo del primo romanzo. Questo personaggio si ritrova talmente invischiato in questa situazione, che perde l’anima e le persone a lui vicine. Alcuni lo seguono, altri no, cadendo come pedine nella guerra sporca che lui combatte. In questa parte sì, è un noir puro, con una visione cinica; nel primo libro si parlava di corruzione all’interno delle forze di polizia, estendendosi poi fino a toccare la corruzione politica della criminalità organizzata, e la ramificazione delle nostre mafie in Italia e nel mondo.
Tantissimi lettori e lettrici sono ancora attaccati a Biagio, che è un personaggio inevitabilmente forte e affascina come affascina il male senza filtri, ma ciò che attrae di più di quest’uomo magnetico sono le sue luci e le sue ombre: è un uomo ambizioso e violento, disposto a tutto pur di difendere le persone che ama, ma ha anche dei lati fragili, è un uomo-bambino che non è mai riuscito a superare la solitudine, il fatto di non aver mai avuto una famiglia vera che cerca di comporsi da adulto, e che però usa al bisogno. Non so se oggi avrei lo stesso coraggio di scrivere una storia così: più vai avanti, più scrivere è complesso, e hai paura di replicare modelli narrativi già usati. Cerco sempre di fare cose nuove, cambiando sempre ambito narrativo. Qui c’era molta inesperienza che mi ha portato a osare.
C’è stata poi l’evoluzione del progetto ‘conferma o smentisci’ dei Canti del male, con un altro personaggio magnetico sul modello di Biagio Mazzeo ma già un po’ mutato, che è Vito Strega.
 Sì, con Vito Strega ho seguito un po’ il modello simenoniano: un personaggio buono, un poliziotto atipico legato a psicologia e sociologia, con un interesse quasi umanistico nei confronti del crimine, che ho usato come fosse una sorta di Ulisse in una serie che è un po’ un’Odissea nei meandri del male, chiamata appunto i I Canti del male. Ogni romanzo va a esplorare un lato diverso della malvagità umana, e questo personaggio andrà a comporre questo mosaico, soprattutto in relazione all’esplorazione: se partiamo dall’assunto che il male cambia le persone, chi ha a che fare con il male quotidianamente, in virtù del mestiere che fa (come un poliziotto), è soggetto ad un cambiamento più veloce, nel senso che il male cerca di portarlo con sé cambiandolo; lo cambierà oppure il personaggio riuscirà a maturare anticorpi che impediscano questa trasformazione?
Sì, con Vito Strega ho seguito un po’ il modello simenoniano: un personaggio buono, un poliziotto atipico legato a psicologia e sociologia, con un interesse quasi umanistico nei confronti del crimine, che ho usato come fosse una sorta di Ulisse in una serie che è un po’ un’Odissea nei meandri del male, chiamata appunto i I Canti del male. Ogni romanzo va a esplorare un lato diverso della malvagità umana, e questo personaggio andrà a comporre questo mosaico, soprattutto in relazione all’esplorazione: se partiamo dall’assunto che il male cambia le persone, chi ha a che fare con il male quotidianamente, in virtù del mestiere che fa (come un poliziotto), è soggetto ad un cambiamento più veloce, nel senso che il male cerca di portarlo con sé cambiandolo; lo cambierà oppure il personaggio riuscirà a maturare anticorpi che impediscano questa trasformazione?
Questa riflessione ha dato un contributo destabilizzante: il male fa parte della natura anche di quelli che vengono considerati innocenti, cioè i bambini.
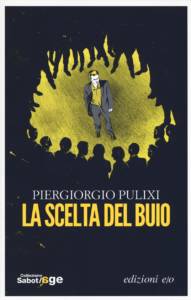 Sì, questa serie va a toccare lati del male inconsueti, cui non siamo abituati. Nel Canto degli innocenti ad uccidere erano dei ragazzini, degli adolescenti. Questo di per sé è destabilizzante, perché tendenzialmente associamo, all’infanzia e all’adolescenza, l’innocenza. La serie continuerà già dall’anno prossimo, con un crossover tra questo libro e la saga di Vito Strega. Ho notato che ai lettori piace il personaggio, il suo modo di scavare nelle sue ossessioni.
Sì, questa serie va a toccare lati del male inconsueti, cui non siamo abituati. Nel Canto degli innocenti ad uccidere erano dei ragazzini, degli adolescenti. Questo di per sé è destabilizzante, perché tendenzialmente associamo, all’infanzia e all’adolescenza, l’innocenza. La serie continuerà già dall’anno prossimo, con un crossover tra questo libro e la saga di Vito Strega. Ho notato che ai lettori piace il personaggio, il suo modo di scavare nelle sue ossessioni.
Poi c’è stato un ulteriore passaggio, che ha aperto la porta ai personaggi femminili come protagoniste, che per forza di cosa si distinguono dai protagonisti maschili. Come mai questa sperimentazione, questo tentativo, questo ‘coraggio’, come dici tu, di imbattersi in qualcosa di nuovo?
 Più che coraggio, mi ha mosso la necessità. Come un’urgenza morale di cercare, nel mio piccolo, di cambiare le cose nel noir, che è sempre stato un genere di protagonisti maschili. Se pensiamo agli albori dei generi gialli, polizieschi, crime negli anni Trenta, era difficile trovarci dentro un personaggio femminile che non fosse: la vittima, la segretaria o la femme fatale. Forse in quel contesto patriarcale era normale: tutta una serie di professioni, magistrato, avvocato, erano inaccessibili alle donne. Per fortuna nel corso dei decenni abbiamo assistito a un’evoluzione sociale, anche se con difficoltà le donne hanno avuto occasione di prendere parte a contesti nuovi, e oggi alcune donne hanno un ruolo di vertice in professioni maschili. Il problema è stato che gli scrittori maschi sono stati molto pigri nel raccontare questa evoluzione: hanno continuato a replicare i modelli maschili (che sicuramente conoscevano meglio), rischiando il paradosso di raccontare una situazione sociale che non esiste più; oggi le donne sono attrici e protagoniste. Il mio romanzo uscito lo scorso anno ha una protagonista femminile di nome Rosa Lopez, ed è ambientato a Milano; tutto questo è stato fatto per essere aderente alla realtà, dato che la questura di Milano ha il maggior numero di donne ai vertici delle sezioni investigative, e chi muove i fili delle indagini sono soprattutto loro. I lettori hanno apprezzato questo mio tentativo, e altri autori hanno cerato di portare avanti questo discorso. Oggi è più interessante raccontare la psicologia femminile all’interno del male perché, salvo rare eccezioni, è stato raccontato pochissimo, è un territorio narrativo vergine. Raccontare come una donna opera in situazione di stress acuto, come la cattura di un serial killer, di un latitante famoso, o addirittura raccontare le indagini delle donne sugli omicidi delle altre donne, è molto interessante, perché le svesti da stereotipi sbagliati e arrivi all’essenza dei personaggi.
Più che coraggio, mi ha mosso la necessità. Come un’urgenza morale di cercare, nel mio piccolo, di cambiare le cose nel noir, che è sempre stato un genere di protagonisti maschili. Se pensiamo agli albori dei generi gialli, polizieschi, crime negli anni Trenta, era difficile trovarci dentro un personaggio femminile che non fosse: la vittima, la segretaria o la femme fatale. Forse in quel contesto patriarcale era normale: tutta una serie di professioni, magistrato, avvocato, erano inaccessibili alle donne. Per fortuna nel corso dei decenni abbiamo assistito a un’evoluzione sociale, anche se con difficoltà le donne hanno avuto occasione di prendere parte a contesti nuovi, e oggi alcune donne hanno un ruolo di vertice in professioni maschili. Il problema è stato che gli scrittori maschi sono stati molto pigri nel raccontare questa evoluzione: hanno continuato a replicare i modelli maschili (che sicuramente conoscevano meglio), rischiando il paradosso di raccontare una situazione sociale che non esiste più; oggi le donne sono attrici e protagoniste. Il mio romanzo uscito lo scorso anno ha una protagonista femminile di nome Rosa Lopez, ed è ambientato a Milano; tutto questo è stato fatto per essere aderente alla realtà, dato che la questura di Milano ha il maggior numero di donne ai vertici delle sezioni investigative, e chi muove i fili delle indagini sono soprattutto loro. I lettori hanno apprezzato questo mio tentativo, e altri autori hanno cerato di portare avanti questo discorso. Oggi è più interessante raccontare la psicologia femminile all’interno del male perché, salvo rare eccezioni, è stato raccontato pochissimo, è un territorio narrativo vergine. Raccontare come una donna opera in situazione di stress acuto, come la cattura di un serial killer, di un latitante famoso, o addirittura raccontare le indagini delle donne sugli omicidi delle altre donne, è molto interessante, perché le svesti da stereotipi sbagliati e arrivi all’essenza dei personaggi.
Questo però, viene fatto sempre da autori maschi. Le scrittrici di noir con personaggi femminili cominciano ad affacciarsi adesso sulla scena, ma si percepisce una sorta di reticenza, di non empatia. Tu cosa ne pensi?
 Sì, a livello statistico è raro che in Italia ci siano donne che si dedichino a una forma di noir pura. Mi vengono in mente Sara Bilotti, Patrizia Rinaldi, Giorgia Lepore, Barbara Baraldi. È più facile che gli editori chiedano a queste autrici di inserire storie sentimentali, cosa che agli autori maschi non viene chiesto. Adesso stanno cambiando molto, perché anche nelle case editrici ci sono più donne. Non è un caso avere tre autrici donne alla finale del premio Scerbanenco, è un bel segnale. La collana da cui vengo ha iniziato a portare delle autrici in un filone molto più noir. Il messaggio lanciato è più forte se deriva da un uomo: si tende a parlare molto del problema ma non delle cause, che sono cause maschili. Anche con L’ira di Venere ho voluto che il messaggio venisse da un uomo, quasi a voler porre rimedio all’errore fatto negli anni passati di sbilanciare questo tipo di narrativa in ambito maschile. In virtù di questo, nell’Isola delle anime ho raddoppiato i miei personaggi femminili; nel precedente c’era Rosa Lopez, personaggio femminile molto mascolino, che veniva da una sezione operativa particolare della polizia di Stato, in cui era necessario essere il ‘maschio alfa’. Qui invece abbiamo due donne molto più realistiche e verosimili, che mantengono la propria femminilità e la propria sensibilità.
Sì, a livello statistico è raro che in Italia ci siano donne che si dedichino a una forma di noir pura. Mi vengono in mente Sara Bilotti, Patrizia Rinaldi, Giorgia Lepore, Barbara Baraldi. È più facile che gli editori chiedano a queste autrici di inserire storie sentimentali, cosa che agli autori maschi non viene chiesto. Adesso stanno cambiando molto, perché anche nelle case editrici ci sono più donne. Non è un caso avere tre autrici donne alla finale del premio Scerbanenco, è un bel segnale. La collana da cui vengo ha iniziato a portare delle autrici in un filone molto più noir. Il messaggio lanciato è più forte se deriva da un uomo: si tende a parlare molto del problema ma non delle cause, che sono cause maschili. Anche con L’ira di Venere ho voluto che il messaggio venisse da un uomo, quasi a voler porre rimedio all’errore fatto negli anni passati di sbilanciare questo tipo di narrativa in ambito maschile. In virtù di questo, nell’Isola delle anime ho raddoppiato i miei personaggi femminili; nel precedente c’era Rosa Lopez, personaggio femminile molto mascolino, che veniva da una sezione operativa particolare della polizia di Stato, in cui era necessario essere il ‘maschio alfa’. Qui invece abbiamo due donne molto più realistiche e verosimili, che mantengono la propria femminilità e la propria sensibilità.
L’isola delle Anime: abbiamo accennato qualche elemento di riferimento; vuoi raccontare qualcosa a chi non l’ha letto?
 L’isola delle Anime è secondo me il futuro del noir, perché presenta una forte contaminazione di generi letterari. Ciò che risalta agli occhi è più il thriller del Noir. Si presenta come un romanzo psicologico con fortissima presenza femminile; ambientato in un’isola, è un inno alla Sardegna, e le isole sono femminili; si svolge in mezzo alla natura, elemento femminile, e si parla molto del culto della Dea Madre. Ma ci sono anche altri generi: c’è attenzione sociale, si parla di antropologia, di archeologia; l’idea era quella di scrivere un inno alla bellezza della mia terra, raccontando una Sardegna più inedita e meno consueta rispetto alla concezione turistica legata alle sue coste. Ho focalizzato l’attenzione sull’entroterra.
L’isola delle Anime è secondo me il futuro del noir, perché presenta una forte contaminazione di generi letterari. Ciò che risalta agli occhi è più il thriller del Noir. Si presenta come un romanzo psicologico con fortissima presenza femminile; ambientato in un’isola, è un inno alla Sardegna, e le isole sono femminili; si svolge in mezzo alla natura, elemento femminile, e si parla molto del culto della Dea Madre. Ma ci sono anche altri generi: c’è attenzione sociale, si parla di antropologia, di archeologia; l’idea era quella di scrivere un inno alla bellezza della mia terra, raccontando una Sardegna più inedita e meno consueta rispetto alla concezione turistica legata alle sue coste. Ho focalizzato l’attenzione sull’entroterra.
La storia è quella di due poliziotte: Eva, poliziotta milanese che viene spedita in punizione in Sardegna, incontrerà una poliziotta della stessa età di nome Mara, e insieme dovranno riaprire vecchi casi di omicidio, detti cold case, legati a due delitti rituali avvenuti nell’isola più di quarant’anni prima. Questi omicidi sono avvenuti in punti opposti dell’isola: il primo (1975) in una zona che si chiama Orune, e il secondo (1986) nell’area archeologica di Matzanni. Entrambi sono avvenuti in una notte particolare per noi sardi: la notte delle anime. Gli omicidi sono speculari, la scenografia è la stessa, c’è la stessa metodologia nel compierli. Le vittime, entrambe due ragazzine molto giovani, sono state trovate nei vestiboli di pozzi sacri di epoca nuragica, nude, in una modalità molto particolare: inchinate a terra con le mani legate dietro la schiena, come intente a compiere una preghiera, un gesto sacro. Entrambe apparivano ricoperte solo da un manto di peli di pecora non tosati, che nascondeva un’incisione fatta a punta di coltello al centro della loro schiena, raffigurante uno stemma molto antico: una sorta di ruota con all’interno un motivo radiale che fa riecheggiare il mito dell’eterno ritorno; la nascita, la morte, e la rinascita delle stagioni. Sono state sgozzate come bestie sacrificali, e il sangue, mentre cadeva, veniva raccolto da canaletti di pietra propri del sentiero, creati apposta per far scorrere il sangue in direzione del pozzo sacro, come se gli assassini avessero cercato una compenetrazione tra un elemento molto umano (il sangue) e un elemento divino (l’acqua). La cosa inquietante è il fatto che queste ragazze avessero il volto coperto da una maschera di legno tipica del carnevale sardo, con corna appuntite. Il vero mistero, ciò che non ha permesso la risoluzione di questi omicidi, e la crescita della maledizione attorno ad essi, è il fatto che nessuno abbia mai identificato le vittime: non un genitore, non un amico, non un parente, tanto che esse vengono definite con il dialetto sardo fantasmi. E quando non hai nome o cognome, questa è l’autostrada per l’archiviazione del caso: non puoi ricostruire nulla sulle vittime, e quindi il caso viene presto dimenticato.
Questi dettagli derivano tutti dalla tua immaginazione o c’è della realtà, dello studio?
Assolutamente: c’è stato uno studio dell’antropologia legato al contesto agropastorale che si rifà ai culti della Dea Madre, ai sacrifici bestiali e umani, e al carnevale sardo. Quest’ultimo nel nostro dialetto significa proprio carne viva da lacerare, c’è sempre un rito di smembramento in onore della divinità per far sì che i raccolti siano più propizi. Non c’è uno studio poliziesco, è antropologico, tradizionale, rituale, dedicato al percorso storico della Sardegna. Quest’ultima per me è un piccolo continente: ha una varietà di anime e personaggi in parallelo a una pluralità di culture che ci hanno vissuto e ci vivono. Sono stato fisicamente in tutti questi siti, cercando di raccontare la terra al meglio, facendo fare al lettore un viaggio emozionale. In passato chi si è dedicato a questi casi non ha mai fatto una bella fine, e malgrado le poliziotte vengano messe in guardia decidono comunque di andare avanti con le indagini. Questi casi rappresentano per loro una vera rivolta professionale. C’è anche molta ironia, perché vengono da due mondi completamente opposti: una milanese, l’altra sarda, faticano a dialogare. Tuttavia il caso riuscirà a legarle, perché saranno sole contro tutto e tutti.
Sei riuscito a tenere insieme temi e personaggi molto diversi.
Sì, è come se volessi rappresentare due mondi diversi di quest’isola: il mondo moderno, rappresentato dalla città di Cagliari, emblema della questura da cui parte l’indagine, e l’entroterra. Apparentemente queste storie non si sfiorano: un punto prospettico moderno va a scontrarsi con un mondo molto arcaico, rappresentato dalla seconda storia; una famiglia chiamata Ladu della montagna che vive in una zona particolare, molto impervia, arretrata e culturalmente pura, dove nessun invasore ha mai fatto penetrare i propri eserciti, perciò totalmente incontaminata. I membri di questa famiglia sono un centinaio, vivono rinchiusi in proprietà da cui non escono mai, e nel corso degli anni hanno incrociato il loro sangue fino a diventare parenti fra loro. Vivono in totale solitudine rispetto a tutte le altre popolazioni, non c’è mai un interscambio. Inoltre, se vi capitasse di inoltrarvi nei loro territori, basterebbe pochissimo per capire che queste persone vivono in totale rifiuto della modernità, considerata peccato. Sono agricoltori, cacciatori, si rifanno alle tradizioni pagane, sono i continuatori di quelle comunità indigene che avevano resistito alla cristianizzazione. I ragazzi più giovani, però, entrano in lotta con gli anziani, perché non vogliono più vivere in quel modo: “noi viviamo il paradosso di essere nati in un’isola senza averne mai visto il mare, e vogliamo vedere il mare”.
Questo è frutto della narrazione oppure esistono realmente queste popolazioni in Sardegna?
In Sardegna non esistono comunità così numerose che vivono con questo stile di vita, tuttavia esistono dei piccoli gruppetti, composti da massimo sei persone, che vivono nel rifiuto della modernità, e solitamente vengono da retaggi criminali. Sono persone che hanno fatto tanto carcere e hanno deciso di non voler più vivere nelle regole del consesso civile. Vivono ai margini della socialità in queste montagne.
La Sardegna è protagonista di questo romanzo, e questo lo rende unico nel panorama letterario e nella tua produzione. Forse è complice un affetto diverso?
Ho impiegato molti anni a scrivere questo romanzo: non ci riuscivo, non mi sentivo pronto. Andrea Camilleri usava un’espressione bellissima, diceva che l’amore è una lente deformante: cioè quando tu ami qualcosa in modo viscerale, il sentimento va ad offuscare la visione dell’oggetto del tuo amore, che sia una persona, un oggetto o un territorio, non fa differenza. Amo molto la mia terra, e per questo non riuscivo a trovare freddezza e oggettività nel raccontarla, il sentimento ne distorceva la mia visione. Quindi ho abbandonato l’isola: sono tanti anni che vivo a Milano, e credo di aver oramai raggiunto la visione dell’esule, che vede la propria terra in maniera più distaccata. Mi sono concentrato nel voler raccontare una Sardegna per come in realtà mi è stata raccontata dai ‘continentali’: coloro che non sono nati nell’isola, ma vengono dal mare. Se tu chiedi a chi non è nato in Sardegna, ma c’è stato, che esperienza ha avuto, la sua risposta sarà che ha avuto un’esperienza mistica, sentimentale. È un’isola che inevitabilmente ti cambia, ti accoglie come una madre ma è anche matrigna; ti fa fare un viaggio quasi purgatoriale grazie ad un itinerario molto suggestivo e particolare, parlando direttamente alla nostra parte più bestiale. Ho voluto raccontare la Sardegna ai sardi da un punto di vista forestiero, perché, quando sei radicato in un territorio, ne sei come assuefatto e non ti rendi più conto della sua bellezza, della sua essenza spirituale. Malgrado io non sia spirituale, questa terra così primitiva e rigogliosa va in questa direzione. Perciò questa indagine sarà su degli omicidi, ma per le protagoniste sarà anche un’indagine nel profondo di loro stesse, che le aiuterà ad uscire da brutte situazioni personali.
Ti sei potuto permettere per la prima volta l’uso del sardo.
Sì, ogni tanto la narrazione presenta dei piccoli innesti in lingua sarda, modi di dire, parolacce: la poliziotta sarda è un po’ sboccata, si abbandona spesso a espressioni gergali. Non ho voluto tradurre le frasi, sono facilmente intuibili dal contesto, volevo che i lettori assaporassero questa lingua ruvida, granitica, il suo sapore antico.
Un’opera letteraria narrativa per te o è scritta bene, o è scritta male: cosa intendi?
Io credo che ogni libro scritto bene debba rappresentare un viaggio emozionale per il lettore, deve farti evadere dalla tua realtà regalandoti ore di intrattenimento, devi poter provare la più vasta gamma possibile di emozioni. Io faccio sempre questo esempio: quando un lettore compra un libro, la cosa più preziosa che regala a un autore o a un’autrice non sono i soldi, per quanto vadano rispettati perché frutto della fatica, ma il proprio tempo. Noi dobbiamo gestire le ore che il lettore ci regala al meglio della nostra professionalità. È come se un lettore entrasse in un’agenzia turistica e chiedesse di fare un viaggio: vuole commuoversi, assaporare culture diverse, divertirsi, vedere cose nuove, vuole che sia un’esperienza, più completa e profonda possibile; paga ma non vuole occuparsi dei fattori tecnici e quotidiani, della logistica. Ci dà tempo e soldi, ma chiede a noi di guidare. L’autore è l’operatore dell’agenzia turistica. Come puoi portare via una persona? Con il linguaggio, la trama, i personaggi e la loro empatia. Un buon romanzo è quello che tu leggi veloce, ma è anche il romanzo stesso a leggerti. In qualche modo, mentre leggi, ti accorgi che sta parlando di te, che sta esponendo lati e parti di te che fatichi a conoscere e magari non avevi mai notato. Un buon libro, attraverso i personaggi, gioca di riflesso con la tua anima. Se al tempo stesso sa insegnarti qualcosa in più su una situazione per te ignota, o sa portati in luoghi che non hai mai esplorato, l’esperienza emotiva diventa anche sensoriale.
L’originalità della trama per me è non è un valore, anzi, da Dante in poi qualche dettaglio originale si può trovare, ma un’intera storia no. Non è il cosa, ma il come. Sentendo te, però, ciò che conta sono la storia e i personaggi.
Sicuramente in letteratura la forma è il contenuto: il modo che hai di condurre le persone all’interno della storia, lo stile letterario, la carnalità della scrittura, tutto questo diventa contenuto. Una volta, durante una presentazione di Marcello Fosca, una signora si è avvicinata con la sua copia e gli ha detto: “Vorrei complimentarmi perché la sua storia è scritta benissimo”, e la sua replica è stata: “Signora, lei ha speso diciannove euro, ci manca che non sia scritta almeno bene: quella è la base”. Noi abbiamo il diritto di curare ogni singola parola come fosse l’ultima: devi avere un rispetto enorme nei confronti del lettore curando ogni parola come se ne andasse della tua vita, e quel rispetto devi mantenerlo per cinquecento pagine; fa parte del gioco. Quando mi parlano di originalità io mi spavento, perché se reputi qualcosa che hai scritto originale, vuol dire che non hai letto abbastanza, perché tutto è già stato scritto. Basta pensare alla Bibbia: di per sé esaurisce quasi tutte le tematiche e i nodi esistenziali dell’uomo, della donna e della psicologia da raccontare. Si passa poi per la tragedia classica greca, e qui si ha la conferma che tutto ciò che si può raccontare sull’essere umano è esaurito. Quello che noi possiamo fare è raccontare queste tematiche in chiave moderna, con uno stile maturato e adattato ai nostri tempi.
Trascrizione ed editing a cura di Giulia Bertini


























