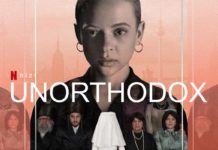È evidente che non si tratti di uno Stato di natura come lo poteva intendere Rousseau. Ovvero, tagliando il concetto con l’accetta, una condizione nella quale gli esseri umani ancora non hanno costituito una società e vivono “liberi, sani, buoni, felici”.
Il primo che, avendo cintato un terreno, pensò di dire questo è mio e trovò delle persone abbastanza stupide da credergli fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, quanti assassinii, quante miserie ed errori avrebbe risparmiato al genere umano chi, strappando i pioli o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: guardatevi dal dare ascolto a questo impostore! Se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno, siete perduti!
[Discorso sull’ineguaglianza, 1755]
Lo Stato di natura cui faccio riferimento vuole indicare le situazioni narrative espresse da due serie televisive: The wilds e Lost, accomunate dall’isolamento dei personaggi su un’isola apparentemente deserta.
In entrambi questi prodotti culturali l’assenza di società non è davvero contemplata, anzi, è proprio la sua complessità a renderne possibili le premesse (un esperimento psicologico nel primo caso, gli ultimi residui di un progetto di ricerca nel secondo). Ma i personaggi non lo sanno, almeno all’inizio, ed è questo il punto.
The wilds è una serie di Prime Video creata da Sarah Streicher (che precedentemente ha lavorato a Daredevil) e uscita a dicembre 2020.
Il personaggio (adulto) principale di The wilds è interpretato da Rachel Griffiths – Brenda Chenowith di Six Feet Under – che in questa serie riprende dei tratti di analisi psicologica sempre sul filo del deragliamento.
Alcuni elementi caratteristici di questa serie, utili a capirne soprattutto l’atmosfera, sono l’isolamento costituito dall’oceano, la natura come aiuto e ostacolo alla sopravvivenza, protagoniste adolescenti con un passato problematico e un distacco netto con il mondo adulto.
La storia procede mostrando il punto di vista di una diversa protagonista a ogni episodio, come una sorta di Rashomon in cui il delitto non è chiaro. La prima a raccontare la propria esperienza, e a dettare il tono della narrazione, è Leah (interpretata da Sarah Pidgeon): la più mainstream delle ragazze intrappolate sull’isola, un personaggio con cui si ci può identificare e il cui tratto dominante è l’ossessione per uno scrittore col quale ha avuto una breve storia d’amore.
È la voce di Leah che nei primi minuti, parlando con quelli che si presentano come gli agenti incaricati di ricostruire i fatti, afferma:
Date per scontato che sia traumatizzata. Date per scontato che abbia vissuto un incubo. […] Non voglio dire che ciò che è successo non sia stato traumatico. Ovviamente, è stato traumatico. Finire dove siamo finite, in mezzo al nulla, completamente strappate alle nostre vite. Ma questo ci porta alla vera domanda, no?
Che cosa c’era di tanto fottutamente fantastico nelle nostre vite?[1]
Certamente è facile attribuire queste parole a un personaggio adolescente, perché l’adolescenza ha la peculiarità, che poi si attenua nella vita adulta, di mettere in discussione le regole, non solo della società ma della vita stessa. Eppure è una domanda che va posta, di tanto in tanto, se non altro come esercizio di gratitudine, o al contrario per correggere la propria rotta.
Leah si risponde così:
Perché questo è quello che ricordo io. Ricordo che mi sentivo inadeguata. Ricordo che volevo essere migliore. Ricordo gli stati d’animo bui, quelli violenti, gli stati d’animo per i quali nessuno aveva pazienza. […] Ricordo le assurde aspettative che avevano nei nostri confronti. Tipo… come se dovessimo essere queste divinità dorate sette giorni su sette[2].
Di nuovo: è molto facile far pronunciare queste parole a un personaggio adolescente. Ma è anche banale?
Per provare a rispondere a questa provocazione voglio introdurre i concetti di millennial e di burnout. Per millennial s’intende una persona nata tra il 1980 e il 1994 (non l’età delle protagoniste, quindi, più verosimilmente quella dell’autrice), mentre il burnout può essere definito come “uno stato di stress cronico che conduce a un esaurimento fisico ed emotivo.[3]”
Pare che sia prassi consolidata riferirsi alla generazione millennial come alla “burnout generation”. Ne parla diffusamente Ann Helen Petersen in un articolo diventato virale e pubblicato su Buzz Feed News che titola, appunto, Come i millennial sono diventati la burnout generation[4].
Perché non riesco a portare a termine queste cose banali? Perché sono esausta. Perché sono esausta? Perché ho interiorizzato l’idea che dovrei lavorare tutto il tempo. Perché ho interiorizzato quest’idea? Perché tutto e tutti nella mia vita l’hanno rafforzata – esplicitamente e implicitamente – sin da quando ero giovane. La vita è sempre stata dura, ma molti millennial sono impreparati ad affrontare le modalità specifiche con cui la vita è diventata dura per noi[5].
Petersen si riferisce agli Stati Uniti d’America, e nel suo articolo parla diffusamente del debito che grava sulle spalle degli studenti. In Italia possiamo considerarci fortunati, almeno su questo punto. Inoltre in Italia c’è una sanità pubblica efficace, cosa che manca negli Stati Uniti. Sembra che le differenze, però, finiscano qui.
Anche da noi la generazione millennial si è affacciata al mondo del lavoro durante o dopo la crisi economica del 2008, ha accettato lavori precari e sottopagati, non tutelati da un sindacato. Anche qui non è più sufficiente avere un diploma o una laurea per trovare e mantenere un lavoro: “Con un netto cambiamento rispetto alle generazioni precedenti, i millennial hanno dovuto ottimizzare se stessi per essere i migliori lavoratori possibili[6].”
Queste condizioni devono essere messe a confronto con le aspettative, con “la necessità di trovare un lavoro che si rifletta bene sui genitori (stabile, ben retribuito, riconoscibile come un buon lavoro), che faccia anche una buona impressione sui coetanei (in un’azienda cool) e soddisfi l’obiettivo finale di tutta questa ottimizzazione: fare il lavoro che ti appassiona.[7]”
C’è uno scollamento tra aspettative e realtà, ma i millennial non cercano di spezzare il sistema, dice Peterson, perché non è così che sono stati cresciuti. Cercano di “vincerlo”.
La mia nuova parola d’ordine era “Tutto ciò che è buono è brutto, tutto ciò che è brutto è buono”: le cose che avrebbero dovuto farmi sentire bene (tempo libero, non lavorare) erano negative perché mi sentivo in colpa per non aver lavorato; le cose che avrebbero dovuto farmi sentire male (lavorare tutto il tempo) mi facevano sentire bene perché stavo facendo quello che pensavo di dover fare, e di cui avevo bisogno, per avere successo[8].
A proposito di successo, un altro fattore di stress sono i social network come Facebook e Instagram, dice Peterson, dove gli account dei coetanei mostrano un mix di tempo libero e viaggi, animali domestici e bambini, cibo sano, un lavoro divertente e in generale una vita desiderabile, equilibrata, soddisfacente e soprattutto non affetta da burnout.
Tutta questa ottimizzazione – come bambini, come studenti e online – culmina nella condizione dominante dei millennial, indipendentemente da classe sociale, etnia o location: burnout[9].
Se l’esaurimento (l’essere esausti) ti porta al punto in cui non puoi più andare oltre, il burnout raggiunge quel punto e ti spinge ad andare oltre. Il senso di realizzazione che viene dall’aver completato un compito estenuante non arriva mai.
L’esaurimento sperimentato nel burnout combina un intenso desiderio di questo stato di completamento con la tormentosa sensazione che non possa essere raggiunto, che ci sia sempre qualche richiesta o ansia o distrazione che non può essere messa a tacere[10].
Ora che l’articolo di Petersen ha messo in luce delle nuove categorie per interpretarla, torno a proporre la stessa domanda: “Che cosa c’era di tanto fottutamente fantastico nelle nostre vite?”.
O, in termini meno young adult: Sto vivendo la vita che desidero? Quanto spesso mi rendo conto di essere esaust*? Quanto è stretta la correlazione tra il raggiungimento dei miei obiettivi e un senso di appagamento che ricompensi i miei sforzi? Con quanta facilità minimizzo i risultati che ho ottenuto o che sto ottenendo, alla luce dell’idea di “successo”?
La seconda serie televisiva che voglio citare è Lost, creata da Jeffrey Lieber, J.J. Abrams e Damon Lindelof per la ABC e trasmessa dal 2004 al 2010.
I personaggi si trovano su un volo intercontinentale quando un guasto fa precipitare l’aereo e i sopravvissuti restano bloccati su un’isola deserta, senza soccorsi in vista e senza la possibilità di comunicare con il mondo esterno. È stato detto moltissimo su questa serie, ma qui vorrei porre l’accento non tanto sui misteri dell’isola, quanto sui primi giorni dei sopravvissuti, quando capiscono che la situazione non si risolverà in fretta.
In questa fase, dopo lo schianto ma prima che i meccanismi di trama si facciano intricati, si percepisce una distanza dalla società che viene enfatizzata dall’isola. Una distanza non solo geografica ma anche psicologica che separa i personaggi dalle loro vite pregresse, in modo sempre più evidente.
Non sono più in fuga, non cercano più di tenere insieme una band, di gestire un reparto di chirurgia o di seppellire il padre. Le priorità adesso riguardano l’acqua potabile, il rifugio, il cibo, la protezione dagli animali selvatici e dalle intemperie.
La tensione è costante, i nuovi elementi narrativi dosati con cura, i flashback contribuiscono allo stimolo di una visione ingorda di un episodio dopo l’altro, ma questa tensione narrativa corre parallelamente al crollo della tensione precedente, sociale: tutto quello che è accaduto prima importa solo nella misura in cui i personaggi portano con sé le abilità acquisite nella vita che conducevano. Il resto sbiadisce di fronte a un oceano onnipresente.
Il personaggio che meglio rispecchia questo cambiamento è John Locke (interpretato da Terry O’Quinn). In sedia a rotelle prima dello schianto, Locke viene misteriosamente guarito dall’isola ,e grazie a un addestramento durato anni, col quale si preparava per un walkabout (originariamente un rito di passaggio della società aborigena australiana, in tempi moderni un’esperienza immersiva per viaggiatori), assume il ruolo del cacciatore.
Sa seguire tracce e cacciare animali col coltello, trovare acqua, sa orientarsi con facilità. Viene coinvolto nel nuovo management che s’instaura tra i sopravvissuti ma non è mai davvero coinvolto nei meccanismi sociali. Si è lasciato alle spalle una vita tragica e squallida per trovare nell’isola il suo scopo, che è solitario. Quella di Locke sull’isola è una rinascita entro uno stato di natura.
Cercando di spiegare a me stessa perché mai queste due serie tv mi coinvolgessero tanto da indurmi a fantasticare di trovarmi io stessa sulle isole in questione, mi è venuto in mente un discorso sentito quando la pandemia Covid-19 era ancora solamente una possibilità astratta, diciamo a gennaio 2020.
Il discorso era circa questo: a sentir parlare amici e conoscenti, sembrava che quasi ci sperassero, che succedesse qualcosa di epocale. Uno stravolgimento della routine, un’occasione per smettere di fare un lavoro odioso e sottopagato, continua fonte di stress. Una cosa abbastanza grossa da togliere un po’ di peso al carico quotidiano di doveri poco remunerativi dal punto di vista emotivo tanto quanto economico.
Il discorso continuava chiedendosi perché i coetanei insistessero a non voler cambiare la propria vita, se la odiavano, tanto da sperare in un evento da film catastrofico.
Eppure anch’io (che non odio la mia vita, il mio lavoro, gli impegni che ho scelto) in certi momenti non disdegnerei un naufragio su un’isola deserta.
Allora la domanda, forse banale, che mi viene in mente è: in quanti, sapendo di non rischiare nulla, accetterebbero di passare un mese su un’isola deserta? E sapendo di tornare, alla fine, alla propria vita, ma correndo dei rischi nel frattempo? In quanti accetterebbero, con la certezza di tornare cambiati? E in quanti andrebbero, sapendo o sperando di non poter tornare?
Chissà, mi chiedo, che la risposta non sia generazionale.
Note
[1]You’re just assuming trauma. You’re just assuming it was a living hell. […] I don’t mean to say that what happened wasn’t traumatic. Obviously, it was traumatic. To end up where we did, in the middle of nowhere, completely cut off from the lives we left behind. That brings us to the real question, doesn’t it? What was so fucking great about the lives we left behind?
[2]Because here’s what I remember of all that. I remember not being enough. I remember wanting to be more. I remember the dark moods, the violent moods, moods that nobody had any patience for […] I remember the ridiculous expectations they had for us. Like… we were supposed to be these golden gods 24/7.
[3]BBC – https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/c384d54a-0116-437f-83e8-ddbca65b6c06
[4]How millennials became the burnout generation, Buzz Feed News, Ann Helen Petersen – https://www.buzzfeednews.com/article/annehelenpetersen/millennials-burnout-generation-debt-work
[5]Why can’t I get this mundane stuff done? Because I’m burned out. Why am I burned out? Because I’ve internalized the idea that I should be working all the time. Why have I internalized that idea? Because everything and everyone in my life has reinforced it — explicitly and implicitly — since I was young. Life has always been hard, but many millennials are unequipped to deal with the particular ways in which it’s become hard for us.
[6]In a marked shift from the generations before, millennials needed to optimize ourselves to be the very best workers possible.
[7]The need to find employment that reflects well on their parents (steady, decently paying, recognizable as a “good job”) that’s also impressive to their peers (at a “cool” company) and fulfills what they’ve been told has been the end goal of all of this childhood optimization: doing work that you’re passionate about.
[8]My new watchword was “Everything that’s good is bad, everything that’s bad is good”: Things that should’ve felt good (leisure, not working) felt bad because I felt guilty for not working; things that should’ve felt “bad” (working all the time) felt good because I was doing what I thought I should and needed to be doing in order to succeed.
[9]All of this optimization — as children, in college, online — culminates in the dominant millennial condition, regardless of class or race or location: burnout.
[10]“The exhaustion experienced in burnout combines an intense yearning for this state of completion with the tormenting sense that it cannot be attained, that there is always some demand or anxiety or distraction which can’t be silenced” – Josh Cohen