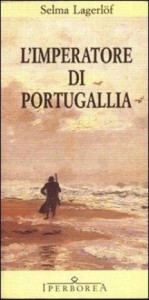L’Imperatore di Portugallia è un piccolo capolavoro di Selma Lagerlöf.
Certo, potremmo dire che di Lagerlöf, premio Nobel per la Letteratura nel 1909 e famosa per narrazioni epocali come La saga di Gösta Berling, questa potrebbe essere considerata un’opera minore. Ed in effetti in un certo senso lo è. Eppure questo romanzo rivela maestosamente tutta la sapienza narrativa dell’autrice svedese.
Nata a Mårbacka nel 1850, Lagerlöf ci offre uno spaccato sulla sua terra natale, il Värmland, che fa da sfondo ad un dramma incastonato in una società agricola e arcaica. Perfino la natura dura e ostile sottolinea come l’antico mondo intessuto di tradizioni e valori ‘contadini’ non sia affatto armonico e sereno, ma sia permeato di crudeltà e avidità.
Il romanzo si apre con Jan, bracciante, che sta per avere una figlia senza desiderarla affatto. Ma incredibilmente non appena la piccola Klara Gulla viene alla luce, il protagonista è colto da un improvviso moto di affetto che non lo abbandonerà mai più.
Man mano che la figlia cresce il loro rapporto diviene quasi simbiotico, l’amore paterno tocca vette inimmaginate, e la bambina cresce sana, intelligente e bellissima. Talmente altruista che quando i genitori si trovano in condizioni economicamente disagiate e rischiano di vedersi sottratta la casa, Klara Gulla decide di partire per Stoccolma per trovare lavoro.
Ed ecco il mostro della grande città, che tutto divora con i suoi metallici e meccanici ingranaggi, inclusa la ragazza.
Jan si rifugia allora in una follia, che lo accoglie piano piano nelle sue materne e rassicuranti braccia, e si convince che la bellissima figlia sia diventata un’imperatrice in una terra lontana e fantastica chiamata Portugallia, dove non c’è male o tristezza.
Jan è essenzialmente un matto, eppure risulta anche essere l’unico personaggio davvero forte, e anche l’unico capace di penetrare il mondo con il suo sguardo, e non certo per il potere di divinazione, come alcuni personaggi sostengono nel libro, ma per il fatto che le sue doti di osservazione si sono acuite, e ciò grazie alla stessa follia: la pazzia è quindi una sorta di dono, e il lettore scivola dolcemente in essa, facendosi cullare.
E’ un romanzo dolce e delicato, una storia commovente che ha il ritmo delle favole antiche. Al centro di tutto, l’amore di un padre per la figlia, e la follia che solo la perpetua illusione dell’amore può provocare.
Attraverso una doppia lente il lettore è chiamato a guardare: quella dell’amore e quella della follia, inscindibili e imprescindibili.
Un artificio narrativo interessantissimo, che Lagerlöf dimostra di dominare con assoluta maestria, fa inoltre sì che il punto di vista (sebbene celato sotto l’uso di un’ingannatrice terza persona) è sempre quello di Jan. Al lettore sembra di essere trascinato dentro un altro modo di pensare, eppure non si rende subito conto che è l’evoluzione degli avvenimenti a far pensare che sia avvenuto uno spostamento al filtro della narrazione, che pure è sempre rimasto lo stesso.
Noi diventiamo folli insieme a Jan fino ad un certo punto, solo per venire poi colpiti dalla crudezza della realtà, ed ecco che ci allontaniamo dalla visione suggerita.
Lagerlöf sa condurci fino al delirio dell’amore, e sta al lettore discostarsi quando e come vuole, sfruttando i segnali che vuole.
Ed è significativo che la frase forse più commovente di tutto il romanzo non riguardi minimamente il rapporto tra Jan e la figlia, ma tra lui e sua moglie. Un rapporto freddo e distante che la follia di Jan riesce invece ad addolcire e riscaldare: “Jan non è matto […]. Il Signore gli ha posto uno schermo davanti agli occhi, perché non veda quello che non sopporterebbe di vedere. E di questo non si può che essere riconoscenti”.
Curiosità: nel 1925 dal libro è stato tratto un film, The Tower of Lies, prodotto negli Stati Uniti ma diretto dal regista svedese Victor Sjöström; fino a poco tempo fa la pellicola era stata data per persa, anche se pare che ne sia rimasta una copia in Danimarca.